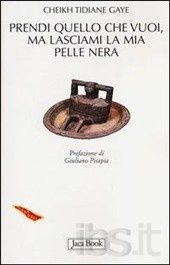recensioni
Mario Grasso, "Latte di cammella"
/image%2F0394939%2F201303%2Fob_779f2c609ac33adc7800b898cce6e030_cop-jpg.jpeg)
Latte di Cammella
di Mario Grasso
2012 Sensoinverso
pp 185
17,00
L’errore di “Latte di Cammella “ di Mario Grasso è cedere alla tentazione della narrativa, volendo dare una veste accattivante a ciò che dovrebbe essere solo reportage, brutale denuncia. L’inizio del romanzo, col giornalista Vanni Ossarg che fa un sogno premonitore e poi incontra personaggi inquietanti in un villaggio diroccato, brumoso e fuori dal tempo, sembra precipitare il lettore in un thriller paranormale, per poi riacciuffarlo immediatamente per i capelli e lanciarlo nella materia dell’inchiesta giornalistica. Vanni Ossarg andrà in Somalia e poi in Sierra Leone, raccontando a modo suo ciò che vede. Di là dal contenuto completamente diverso, il modo di esporre è quello de “La profezia di Celestino”, in un mix fra saggio e narrativa, in un accumulo di dialoghi, incontri, illuminazioni e indottrinamento del lettore.
Il reportage di Grasso, il suo modo di raccontarci l’Africa, è viziato da uno spiccato indirizzo di pensiero, teso alla giustificazione forzata di tutto ciò che è il continente nero, visto come innocente e incolpevole, come originariamente “buono”. Vengono così trovate attenuanti per la sharia, le incursioni dei pirati, addossando all’occidente tutte le colpe.
"Chi vuole aiutare la Somalia non deve pensare alle lotte dei clan, alle brutture del fondamentalismo esasperato, alle tante cose che devono cambiare, ma alla gente e ai bambini la cui unica colpa è di essere nati lì o altrove." (pag. 101)
Vero è che la denuncia è indispensabile, che troppo spesso le guerre a colpi di machete - sbrigativamente etichettate come etniche o tribali - sono dimenticate dai nostri telegiornali, con i loro orrori impensabili. Fiumi di sangue e di morte scorrono in Africa, inseguendo diamanti, petrolio, rifiuti tossici scaricati dal cielo, con la complicità di politici corrotti, signori della guerra, multinazionali rapaci e persino organizzazioni finto-umanitarie, soprattutto complice, e muto testimone, l’occidente.
Il libro è una carrellata di orrori: bambini trasformati in macchine per uccidere, costretti ad amputare braccia e gambe di parenti, resi aggressivi con la cocaina inserita sotto pelle, bambini di cui si è distrutta l’umanità, rendendoli soli al mondo, vittime a loro volta di mutilazioni atroci, di malattie, di fame, di emarginazione e analfabetismo; bambine stuprate e infettate con l’Aids; figli sacrificati dagli stessi genitori, vaccinati troppe volte in cambio di una zanzariera da rivendere.
La parte più bella del libro, tuttavia, non è né la storia narrata, né l’intento d’insistita accusa, ma piuttosto la descrizione dell’Africa, dei suoi paesaggi polverosi e dorati, dei suoi tramonti di fuoco, dei suoi odori speziati ed acri, dei suoi immensi alberi di baobab, delle sue acacie spinose, del fumo acido dei copertoni bruciati, del fetore delle discariche a cielo aperto, dei liquami versati in mare, dei mercati dove si vende merce poverissima, cose che noi getteremmo nella spazzatura e lì significano un altro giorno di sopravvivenza. Pagina dopo pagina entriamo nei luoghi, sentiamo gli odori, percepiamo il calore e il vento, le voci, vediamo i volti di ebano e di giaietto.
C’è un altro filone nel romanzo, ammesso che di romanzo si possa parlare, ed è il sentimento che sboccia fra Vanni e Sonia, colei che ha a cuore la sorte dei diseredati, degli ultimi della terra. L’atto d’amore è descritto con tono aulico, senza volgarità, come un balsamo che lenisce le ferite, che dà tregua all’orrore, come risarcimento per “l’eroe”.
Lo stile è pulito, con spiegazioni particolareggiate ma non sempre necessarie, nella foga di dire tutto e fin troppo, di raccontare e investigare ogni aspetto dei rapporti fra occidente e continente africano, comunicando fatti, notizie, dati statistici, mescolandoli ad opinioni e riflessioni personali.
/http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-EogyH1joFlI%2FUBajC4cWcZI%2FAAAAAAAAAGE%2Fu5nZZnnByjQ%2Fs320%2Fcop.jpg)
CriticaLetteraria: Mario Grasso, "Latte di cammella"
Latte di Cammella di Mario Grasso 2012 Sensoinverso L'errore di "Latte di Cammella " di Mario Grasso è cedere alla tentazione della narrativa, volendo dare una veste accattivante a ciò che dovrebbe
http://www.criticaletteraria.org/2012/08/mario-grasso-latte-di-cammella.html
Giana Anguissola, "Violetta la timida"
/image%2F0394939%2F201303%2Fob_dc4e82be41bca5ebda55adf127d861d0_cop-jpg.jpeg)
Violetta la timida
di Giana Anguissola
Mursia, 1970
pp. 273
Giana Anguissola (Travo, Piacenza 1906 – Milano 1966) comincia a scrivere a sedici anni, collaborando al “Corriere dei Piccoli” sul quale pubblica romanzi e racconti. Il suo romanzo più famoso è “Violetta la Timida” del 1963, che vince il premio Bancarellino.
Violetta è soprannominata dalle compagne di scuola “mammola mansueta”, cammina con gli occhi bassi ed ha le orecchie perennemente in fiamme, perché affetta da “coniglite acuta”, quella che oggi, probabilmente, uno psicologo definirebbe fobia sociale.
“La Signorelli, una ragazza che è tutto il contrario di me: energica, simpatica, importante, disinvolta, con un bel cognome… Cioè, mica che Signorelli sia un gran bel cognome: è il mio che è brutto: Mansueti, e allora tutti gli altri cognomi mi sembran belli. E poi mi chiamo anche Violetta che, messo insieme a Mansueti, non poteva dar per risultato altro che un coniglio. Infatti sono timidissima.” (pag.11)
Un giorno viene chiamata dal preside della scuola: la giornalista Giana Anguissola in persona sta cercando una ragazzina che sia brava in componimento e lei lo è, lei è studiosa, creativa, intelligente, ambiziosa, ma goffa e imbranata come tutti i timidi..
“La prima cosa che, naturalmente feci, fu quella d’inciampare in un gran tappeto blu rischiando di cadere lunga e distesa davanti alla scrivania del preside. Per cui, non appena ritrovato l’equilibrio, rimasi lì ad occhi bassi, con le guance che mi cuocevano come due cotolette, senza aver neppure avuto il tempo di guardarmi intorno." (pag. 12)
L’Anguissola - che da quel momento in poi Violetta chiamerà signora A. - le chiede di scrivere pezzi per adolescenti sul “Corriere dei piccoli”, raccontando la propria semplice vita di ragazza normale, fra la casa, la scuola, i genitori, il nonno Oreste, l’amico grasso e goffo Terenzio, la compagna antipatica Calligaris, le prime festicciole fra bambine. Accorgendosi subito di come la timidezza e l’ansia inficino ogni prestazione di Violetta e le condizionino la vita, la signora A. le consiglia, o meglio le impone, di fare proprio tutto ciò che la spaventa, affrontando gli ostacoli, svincolandosi dalla sindrome da evitamento cronico.
“Per quest’altra volta e per sempre, il tuo compito, te l’ho già detto, è quello di affrontare ogni situazione che t’intimorisca o ti faccia soggezione, a meno che non si tratti di un leone, sarai guarita dalla timidezza.” (pag.30)
Sarà così che Violetta, da inibita, si trasformerà quasi in prepotente, fondando il “club dei timidi” (oggi sarebbe un gruppo Facebook) per aiutare chi ha il suo stesso problema. Ecco che un esercito d’insospettabili – fra cui l’amico/aspirante fidanzato Terenzio - s’iscrive al suo club e invade la città, un esercito disposto a tutto pur di superare ansie e timori.
A parte l’improbabilità che tale miracolosa guarigione avvenga, specialmente nel caso della fobia sociale, se il libro ci catturava all’epoca per lo stile divertente, spigliato, ironico, una rilettura odierna ci offre uno spaccato sul mondo educativo dei primi anni sessanta, che si considerava moderno e progressista ma era, in realtà, ancora rigido, influenzato dalla chiesa cattolica e dai programmi ministeriali dell’allora imperante DC, una scuola dove si parlava quasi ogni giorno di religione, dove si narravano storie di santi e martiri.
“La signorina Carbone, poi, vedendo che addirittura deturpavate dei visi già perfettamente dipinti dal buon Dio, ha avuto mille ragioni di sdegnarsi e mandarvi a lavare!” (pag.241)
Nella breve introduzione alla vita e all’opera dell’autrice nell’edizione Mursia del 1970, leggiamo, infatti, che l’Anguissola:
“contribuì a combattere i fumetti e a rieducare i ragazzi a letture sane e artisticamente valide.”
L’intento edificante è evidente e disseminato ovunque, specialmente alla fine di ogni capitolo, che si pone come lezioncina di vita:
“Errore sarebbe da parte dell’adolescente seguire ancora gli istinti dell’infanzia che si spengono e peggiore errore sarebbe seguire di già gli istinti della giovinezza che sorgono. Perché se può ispirare una sorridente indulgenza l’adolescente che indugia a giocare, ispira una pietà mista a repulsione l’adolescente che si atteggia precocemente a donna o uomo, intendo nelle sue manifestazioni esteriori come vestire da tali o parlare o fumare da talaltri.” (pag. 240)
Era tuttavia, quello, un mondo pulito, pieno di speranza, dove tutto sembrava avanzare verso un miglioramento della società, dove l’aggettivo “moderno” era sinonimo di progresso e civiltà. Al boom economico corrispondevano aspettative sempre più alte, scolarizzazione di massa, mezzi di trasporto per tutti, vacanze, frigoriferi, automobili, supermercati, industrie che assumevano giornalmente, emigrazione dalla campagna in città. (E sarà proprio la differenza fra città e campagna l’argomento del seguito, “Le straordinarie vacanze di Violetta".)
A quel mondo lontano e scomparso ci piace volgerci ogni tanto e ricordarlo come l’unica stagione di totale speranza vissuta dalla nostra nazione.
/http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-NnkBuBP3Dyg%2FUCZoDHFHNyI%2FAAAAAAAAAGo%2FfxUP0aC2q84%2Fs320%2Fcop.jpg)
CriticaLetteraria: Invito alla lettura: Giana Anguissola, "Violetta la timida"
Giana Anguissola (Travo, Piacenza 1906 - Milano 1966) comincia a scrivere a sedici anni, collaborando al "Corriere dei Piccoli" sul quale pubblica romanzi e racconti. Il suo romanzo più famoso è ...
http://www.criticaletteraria.org/2012/09/invito-alla-lettura-giana-anguissola.html
Mario Vargas Llosa, "Avventure della ragazza cattiva"

Avventure della ragazza cattiva
di Mario Vargas Llosa
trad. G. Felici
Einaudi, 2006
pp. 357
Non decolla per tutta la prima parte, procede per accumulo e non per sviluppo, Avventure della ragazza cattiva di Mario Vargas Llosa, a metà fra il picaresco e la storia d’amore. Solo nella seconda parte ci appassioniamo alle vicende di Lily, femme fatale dal nome cangiante, come cangianti sono i suoi travestimenti (ma non il suo carattere) e di Ricardo, anonimo interprete peruviano. Ricardo è un travet, un uomo medio, un Charles Bovary senza ambizioni ma con un cuore capace di concepire, e custodire per tutta la vita, un amore immenso. S’innamora a quindici anni di Lily, la ragazza cilena, che cilena non è e che non si chiama nemmeno Lily, bensì Otilia - ma questo Ricardo lo imparerà a sue spese solo molto più tardi. La ritrova a ogni tappa della sua vita sotto nomi e travestimenti diversi, come guerrigliera Arlette, come moglie di un diplomatico francese prima e di un allevatore di cavalli poi, come schiava del sesso giapponese. Ricardo è disposto a tutto pur di stare accanto a Lily, si lascia umiliare da lei, che lo abbandona ogni volta per mettersi con uomini più ricchi, che mal sopporta la vita semplice e borghese che lui può offrirle e cerca il riscatto da un passato di miseria. Alla fine, però, a essere sottomessa, mortificata, sarà lei, vittima consenziente del perfido Fukuda, magnate giapponese che la incatenerà in un rapporto violento e sadico, fino distruggerla nel fisico e nel morale. E, tuttavia, proprio Fukuda sarà l’unico uomo capace di conquistarla e soggiogarla. Ricardo leccherà le ferite di Lily, la inseguirà in capo al mondo, dissiperà le sue poche sostanze per curarla, salvo poi essere abbandonato di nuovo, e poi di nuovo recuperato in extremis, quando non ci sarà più tempo né spazio per ripensamenti. In punto di morte Lily/Otilia/Kuriko tornerà definitivamente da lui, l’unico maschio di cui si fidi, l’unico al quale si senta legata da vero affetto e stima, l’unico che consideri “un santo” a pieno titolo. (E come darle torto?) In qualità di esiguo risarcimento, gli lascerà una casetta nel sud della Francia, assegnatale dalla sua ultima conquista.
Lily, però, non giganteggia, non incute timore, non ha fascino perverso, risulta ripetitiva e alquanto prevedibile nella sua inaffidabilità. Semmai il personaggio più riuscito è Ricardo, con la sua umanissima debolezza, con la sua pazienza, col suo amore che non finisce ma anzi cresce ad ogni incontro, ad ogni abbandono. Ricardo ha dalla sua la bontà, l’umiltà, è un uomo che lavora per vivere, che ama la letteratura e le lingue straniere, soprattutto il russo. È un uomo che non vediamo, che non sapremmo nemmeno descrivere, probabilmente un uomo non bello, ma forte della sua costanza, della sua gentilezza, della sua onestà e dedizione.
Ormai sono passati molti anni perché ti rimanga il minimo dubbio: ti amo tanto che farei qualsiasi cosa per tenerti accanto a me, qualora fossimo uniti. Ti piacciono i gangster? Diventerò rapinatore, sequestratore, truffatore, narco,quello che vuoi. Quattro anni senza sapere niente di te e, adesso, riesco appena a parlare, a pensare, da quanto sono commosso nel sentirti così vicina.
Attorno a lui ruotano una serie di amici e conoscenti, molti dei quali destinati a morire presto e con storie che ci vengono raccontate in parallelo. A fare la parte del leone, oltre alla continua presenza/assenza di Lily, è l’ambiente mutevole in cui Ricardo si muove. Inseguendo il suo amore, o forse sfuggendogli, Ricardo si sposta di nazione in nazione, di continente in continente, dal Perù, paese di origine - coll’elegante quartiere di Miraflores a Lima, ma anche col terrorismo mortifero di Sendero Luminoso - a Parigi, città di elezione, città dell’anima e del cuore, attraverso la swinging London degli hippie, fino alla torbida Tokio dei locali a luci rosse e delle case di piacere e alla Madrid degli artisti, dove Ricardo avrà una storia con una ragazza più giovane, incapace di fargli dimenticare il suo unico grande amore. Questo peregrinare, inevitabilmente, lo trasformerà in apolide, in métèque, uomo senza patria che non si sente a casa in nessun luogo perché non è più peruviano ma non è nemmeno francese o spagnolo. Simbolo di questa condizione è l’innumerevole quantità di passaporti della ragazzaccia, la bad girl del titolo, la ninã mala, che, con la sua inafferrabilità, finisce per incarnare il disagio stesso del protagonista, la sua non appartenenza. Alcuni critici rimproverano a Vargas Llosa di aver contraddetto se stesso in questo romanzo, di non aver continuato sulla falsariga del testo difficile, della narrazione a più piani temporali, di aver optato per uno stile forse trito, ma il linguaggio del romanzo è semplice come semplici sono le parole dell'amore. Più e più volte la ragazzaccia chiede a Ricardo di dirle le sue "cheap, sentimental things", quelle dolci, tenere frasi che sembrano banali quando le leggiamo ma acquistano tanto significato se, invece, sono dirette a noi.
Stai diventando una huachafita [donnetta sentimentale, n.d.r.] anche tu, niña mala, - la baciai sulle labbra. - Dimmene un’altra, un’altra, per favore.
The first part does not take off, it proceeds by accumulation and not by development, Adventures of the bad girl by Mario Vargas Llosa, halfway between the picaresque and the love story. Only in the second part are we passionate about the events of Lily, femme fatale with an iridescent name, as her disguises (but not her character) are iridescent and of Ricardo, an anonymous Peruvian interpreter.
Ricardo is a travet, an average man, a Charles Bovary without ambitions but with a heart capable of conceiving, and guarding for life, immense love. At fifteen he falls in love with Lily, the Chilean girl, who is not a Chilean and who is not even called Lily, but Otilia - but this Ricardo will learn at his own expense only much later. He finds her at every stage of his life under different names and disguises, as a guerrilla woman Arlette, as a wife of a French diplomat first and then a horse breeder, as a sex slave of a Japanese man. Ricardo is willing to do anything to be next to Lily, he lets himself be humiliated by her, who abandons him every time have liaisons with richer men, who can not stand the simple and bourgeois life that he can offer her and seeks redemption from a past of misery. Eventually, however, it will be her who is submissive, mortified, she will be the consenting victim of the perfidious Fukuda, a Japanese tycoon who will chain her in a violent and sadistic relationship, to the point of destroying her in body and in morale. And yet, Fukuda himself will be the only man capable of conquering and subjugating her. Ricardo will lick Lily's wounds, chase her to the end of the world, dissipate his few substances to cure her, only to be abandoned again, and then recovered again in extremis, when there will be no time or space for second thoughts. On her deathbed Lily / Otilia / Kuriko will definitely return to him, the only male she trusts, the only one to whom she feels bound by true affection and esteem, the only one whom she considers "a saint". (And how to blame her?) As a small compensation, she will leave him a little house in the south of France, assigned to her by her last conquest.
Lily, however, does not inspire fear, has no perverse charm, she is repetitive and somewhat predictable in its unreliability. If anything, the most successful character is Ricardo, with his very human weakness, with his patience, with his love that does not end but rather grows with each meeting, with each abandonment. Ricardo has goodness, humility on his side, he is a man who works to live, who loves literature and foreign languages, especially Russian. He is a man whom we do not see, whom we could not even describe, probably a man who is not handsome, but strong in his constancy, his kindness, his honesty and dedication.
Many years have passed for you to have the least doubt: I love you so much that I would do anything to keep you next to me, if we were united. Do you like gangsters? I will become a robber, kidnapper, swindler, narco, whatever you want. Four years without knowing anything about you and now I can barely speak, think, how moved I am to feel so close to you.
A series of friends and acquaintances revolve around him, many of whom are destined to die soon and with stories that are told to us in parallel. In addition to the continuous presence / absence of Lily, the lion's share is the changing environment in which Ricardo moves. Chasing his love, or perhaps escaping it, Ricardo moves from country to country, from continent to continent, from Peru, country of origin - with the elegant Miraflores district in Lima, but also with the deadly terror of Sendero Luminoso - to Paris, city of choice, city of soul and heart, through the swinging London of the hippies, to the murky Tokyo of the red light clubs and pleasure houses and the Madrid of the artists, where Ricardo will have a story with a younger girl, unable to make him forget his one great love. This wandering, inevitably, will transform him into a stateless person, a métèque, a man without a homeland who does not feel at home anywhere because he is no longer Peruvian but neither is he French or Spanish. Symbol of this condition is the countless number of passports of the bad girl, the bad girl of the title, the ninã mala, who, with her elusiveness, ends up embodying the protagonist's unease, his non-belonging.
Some critics reproach Vargas Llosa for having contradicted himself in this novel, for not continuing along the lines of the difficult text, the narration with several temporal timeframes, for having opted for a perhaps trite style, but the language of the novel is as simple the words of love. Over and over again the bad girl asks Ricardo to tell her his "cheap, sentimental things", the sweet ones, The ones that seem trivial when we read them but acquire a lot of meaning if, instead, they are directed at us.
You are becoming a huachafita [sentimental woman] too, niña mala, - I kissed her on the lips. - Tell me another, another, please.
The Hunger Games

Hunger Games
di Susanne Collins
Mondadori, 2008
14,90
Ciò che crea un fenomeno editoriale è la novità del soggetto. Il discorso vale per i monaci assassini di Eco, per i vampiri “vegetariani” della Meyer, per la stirpe del sangreal di Dan Brown, o per il bondage sadomaso della James. Tutto quello che viene dopo, è nella scia, è imitazione dell’originale.
Con “Hunger Games”, di Susanne Collins, si apre forse una stagione di reality show adolescenziale all’ultimo sangue, ma il suo essere capostipite di un nuovo genere, sta nella crudeltà dell’argomento trattato che t’inchioda dalla prima all’ultima pagina.
Katniss Evergreen è un’adolescente del Distretto 12, nel continente postapocalittico di Panem, un Nord America inselvatichito e imbarbarito, dove coesistono scienza raffinatissima e medioevo. Come punizione per un’antica ribellione verso la ricca e nullafacente capitale, i vari distretti devono offrire annualmente un sacrificio umano. In un reality show, che tutti sono obbligati a seguire, ogni distretto estrae a sorte un ragazzo e una ragazza da offrire, o meglio immolare, in una lotta con un unico vincitore e un unico sopravvissuto. Il nome estratto è quello di Primrose, la sorellina di Katniss, e lei non può accettarlo, si offre volontaria al suo posto.
Inizia così una preparazione che ha tutto lo sgradevole sapore cui ci hanno abituato anni di trasmissioni televisive come l’Isola dei Famosi o Il grande fratello, reso ancor più agro dalla consapevolezza che l’eliminazione del giovane partecipante coinciderà, non con il suo rientro a casa, bensì con la sua morte. I concorrenti sono addestrati, rivestiti, intervistati, abbelliti da stilisti e truccatori, per poi essere gettati nell’arena, un luogo che ricorda la cupola di “The Truman Show”, dove niente è naturale e ogni cosa è manovrata dagli Strateghi, cioè gli autori del programma. I ruscelli scorrono o si seccano a comando, la pioggia scroscia su ordinazione, l’aria si fa rovente o gelida secondo ciò che il programma e l’audience richiedono. Katniss guarda la luna e spera che almeno quella sia vera, sia la luna di casa sua, per sentirsi meno sola, meno vulnerabile, meno alla mercé di una dittatura che uccide, che frusta, che strappa la lingua per il minimo sgarro, per una parola di troppo o un atteggiamento di sfida.
Nell’arena si svolge una lotta mortale con mani, unghie, denti, lame, frecce, che ci riporta a un passato/futuro già visto in film come “Mad Max”. I concorrenti, o meglio, i “tributi”, devono uccidersi l’un l’altro per sopravvivere, altrimenti saranno comunque eliminati. Un colpo di cannone segna l’uscita di scena del contendente e un hovercraft solleva il cadavere e lo porta via. L’unico sentimento è la paura, che si trasforma in furia cieca; l’amicizia è solo un’alleanza momentanea contro i più forti, nessuna debolezza è concessa.
Non è comprensibile come si possa definire “Hunger Games” “un romanzo per ragazzi”, se non, forse, nell’incapacità della protagonista (e dell’autrice) di affrontare e sviluppare a pieno il rapporto con il giovane che la ama, Peeta, e il triangolo con l’amico d’infanzia, Gale. Si può obiettare che il romanzo è incentrato nel microcosmo dell’arena, in una bolla spaziotemporale che pare un videogioco, dove amarsi è secondario al rimanere vivi, al mantenere intatta la possibilità di provare sentimenti umani.
“Non so bene come dirlo. Solo non voglio… perdere me stesso. Ha un senso? - chiede. Scuoto la testa. Come potrebbe perdere se stesso? – Non voglio che mi cambino là dentro. Che mi trasformino in una specie di mostro che non sono.?” (pag 143)
L’emblema angoscioso di questa situazione da incubo è il sigillo che ogni notte viene proiettato sullo schermo del cielo, preceduto da un inno. Subito dopo compare l’immagine di chi è morto quel giorno. Lo stomaco si contrae dall’orrore, leggendo.
“La notte è appena scesa, quando sento l’inno che precede il riepilogo delle morti. Attraverso i rami vedo il sigillo di Capitol City che sembra fluttuare nel cielo. In realtà, sto guardando un altro schermo, uno schermo enorme trasportato da uno dei loro hovercraft.” (pag 157)
Il senso del romanzo è la rivolta di Katniss e Peeta, il ragazzo che la ama, a tutto questo dolore, all’obbligo di compiere comunque il male, di uccidere o essere uccisi. Anche soffrire, anche provare dispiacere al pensiero di ammazzare un compagno innocente, è considerato insurrezione. Quando muore Rue, la più piccola dei tributi, così simile alla sorellina della protagonista, Katniss la piange e ne cosparge il corpo di fiori, prima che l’hovercraft venga a raccoglierla, e questo è già un atto di ribellione. Lo stesso vale per il gesto finale: Katniss e Peeta scelgono di morire insieme piuttosto che uccidersi l’un l’altro, scelgono di fare ciò che Peeta ha deciso fin dall’inizio, cioè non concedersi al nemico, rimanere umani, rimanere interiormente puri e liberi. Si salveranno in extremis, ma il finale resta aperto per gli altri due libri della serie, “La ragazza di fuoco” e “Il canto della rivolta”.
Questo libro è una mescolanza di generi da cui scaturisce, forse, un genere nuovo, sincretico. Il cosmo di Panem contiene due mondi. Il primo è quello tecnologicamente sofisticato di Capitol City, una sorta di Ghotam City, dove si ritrovano molti cliché della fantascienza - dalla possibilità di risanare completamente ferite mortali, alla manipolazione genetica che crea nuove letali specie e ibridi mostruosi. Il secondo è quello medievale, oscuro, miserevole, dei distretti, dove la fame imperversa, dove ogni cosa è proibita, la corrente elettrica va e viene, e per cacciare si usano arco e frecce, lacci e trappole.
“Capitol City scintilla come un’enorme distesa di lucciole. Nel distretto 12 l’elettricità va e viene e di solito c’è solo per qualche ora al giorno. Capita spesso che le sere si trascorrano alla luce delle candele. Le rare volte in cui possiamo contare sull’energia elettrica sono quando la tv trasmette gli Hunger Games o qualche importante messaggio governativo che è obbligatorio guardare. Qui, invece, l’elettricità non manca. Mai.” (pag 83)
Katniss, Peeta, Rue, Faccia di Volpe, Gale, somigliano, di volta in volta, ai protagonisti di “Alien” o“Prometheus” e, insieme, ai rampolli della stirpe di Shannara, fra tecnologia e arretratezza, fra passato e futuro remoto. L’unico presente, forse, è quello degli studi televisivi, che ci riporta all’oggi, al nostro essere costantemente sotto le telecamere, sugli schermi, per strada, nei social network.
Lo stile è paratattico, coinvolgente, giovanile, reso incisivo dal presente storico. Ci cala dentro l’azione che prevale su tutto il resto, lasciando che le riflessioni e il sentimento morale scaturiscano per reazione a ciò che accade, al raccapriccio delle immagini, degli eventi, della sofferenza, in un crescendo di angoscia che dà quasi assuefazione.
What creates an editorial phenomenon is the novelty of the subject. The same goes for Eco's murderous monks, for Meyer's "vegetarian" vampires, for Dan Brown's sangreal lineage, or for James's sadomasochistic bondage. Everything that comes after, is in the trail, is an imitation of the original.
With Hunger Games by Susanne Collins, perhaps a season of adolescent bloody reality shows opens, but it being the forefather of a new genre, lies in the cruelty of the subject matter that nails you from first to last page.
Katniss Evergreen is a teenager from District 12, in the post-apocalyptic continent of Panem, a wild and barbarous North America, where refined science and the Middle Ages coexist. As punishment for an ancient rebellion against the rich and non-performing capital, the various districts must offer a human sacrifice annually. In a reality show, which everyone is obliged to follow, each district tosses up a boy and a girl to offer, or rather immolate, in a fight with a single winner and a single survivor. The name extracted is that of Primrose, Katniss' little sister, and she cannot accept it, she volunteers in her place.
Thus beins a preparation that has all the unpleasant flavour to which we have been accustomed by years of television broadcasts such as the Island of the Famous or Big Brother, made even more bitter by the awareness that the elimination of the young participant will coincide, not with his/her return to home, but with his/her death. Competitors are trained, dressed, interviewed, embellished by stylists and make-up artists, and then thrown into the arena, a place reminiscent of the dome of "The Truman Show", where nothing is natural and everything is maneuvered by Strategists, i.e. authors of the program. The streams flow or dry out on command, the rain pours down on request, the air becomes hot or freezing according to what the program and the audience require. Katniss looks at the moon and hopes that at least that is true, and the same moon of her house, to feel less alone, less vulnerable, less at the mercy of a dictatorship that kills, that whips, that rips the tongue for the slightest transgression, for a word too much or a defiant attitude.
In the arena a deadly struggle takes place with hands, nails, teeth, blades, arrows, which takes us back to a past / future already seen in films such as Mad Max. Competitors, or rather "tributes", must kill each other to survive, otherwise they will be eliminated. A cannon shot marks the contender's exit from the scene and a hovercraft lifts the corpse and takes it away. The only feeling is fear, which turns into blind fury; friendship is only a temporary alliance against the strongest, no weakness is granted.
It is not understandable how one can define "Hunger Games" "a novel for children", if not, perhaps, in the inability of the protagonist (and the author) to face and fully develop the relationship with the young person who loves her, Peeta , and the triangle with his childhood friend, Gale. It can be objected that the novel is centered in the microcosm of the arena, in a space-time bubble that looks like a video game, where loving is secondary to staying alive, to keeping intact the possibility of experiencing human feelings.
“I'm not sure how to say it. I just don't want to ... lose myself. Does it make sense? - he asks. I shake my head. How could he lose himself? - I don't want them to change me in there. That they turn me into a kind of monster that I am not? "
The anguished emblem of this nightmare situation is the seal that is projected onto the screen of the sky every night, preceded by a hymn. Immediately after, the image of those who died that day appears. The stomach contracts with horror, reading.
"The night has just fallen, when I hear the hymn that precedes the summary of the deaths. Through the branches I see the seal of Capitol City which seems to float in the sky. In fact, I'm looking at another screen, a huge screen carried by one of their hovercraft. "
The meaning of the novel is the revolt of Katniss and Peeta, the boy who loves her, to all this pain, to the obligation to do evil anyway, to kill or be killed. Suffering, even feeling sorry at the thought of killing an innocent companion, is also considered insurrection. When Rue, the smallest of the tributes, so similar to the protagonist's little sister, dies Katniss weeps and sprinkles her body with flowers, before the hovercraft comes to pick her up, and this is already an act of rebellion. The same goes for the final gesture: Katniss and Peeta choose to die together rather than kill each other, They choose to do what Peeta has decided from the beginning, that is, not to concede himself to the enemy, to remain human, to remain internally pure and free. They will be saved in extremis, but the ending remains open for the other two books of the series, Catching fire and Mockingjay.
This book is a mixture of genres from which, perhaps, a new, syncretic genre arises. Panem's cosmos contains two worlds. The first is the technologically sophisticated one of Capitol City, a sort of Ghotam City, where many science fiction clichés can be found - from the possibility of completely healing mortal wounds, to genetic manipulation that creates new lethal species and monstrous hybrids. The second is the dark, miserable medieval one of the districts, where hunger rages, where everything is prohibited, the electric current comes and goes, and bow and arrows, laces and traps are used to hunt.
"Capitol City sparkles like a huge expanse of fireflies. In district 12, electricity comes and goes and is usually only there for a few hours a day. It often happens that evenings are spent in the light of candles. The rare times we can count on electricity are when the TV broadcasts the Hunger Games or some important government message that is mandatory to watch. Here, however, electricity is not lacking. Never."
Katniss, Peeta, Rue, Fox Face, Gale, from time to time, resemble the protagonists of Alien or Prometheus and, at the same time, the offspring of the Shannara lineage, between technology and backwardness, between past and remote future. The only present, perhaps, is that of television studios, which brings us back to today, to our being constantly under the cameras, on the screens, on the street, in social networks.
The style is paratactic, engaging, youthful, made incisive by the historical present. The action prevails over all the rest, letting reflections and moral sentiment arise as a reaction to what happens, to the horror of images, events, suffering, in a crescendo of anguish that is almost addictive.
Joe Lansdale, "La sottile linea scura"

La sottile linea scura di Joe R. Lansdale
Einaudi, 2004 pp.300
Edizione di riferimento “La biblioteca di Repubblica l’Espresso”
C’è chi, parlando de “La sottile linea scura” di Joe R. Lansdale, cita subito il Bildungsroman, il romanzo di formazione alla Stand by me, con la classica perdita dell’innocenza. Stanley Mitchell, il protagonista tredicenne, in una lunga estate calda texana, scopre che il mondo non è come lo credeva, che le persone fanno sesso fra loro, uccidono, si ubriacano, picchiano la moglie, brutalizzano i figli. Soprattutto scopre che i neri non sono uguali ai bianchi, non è loro concesso lo stesso posto nell’ordine delle cose.
“Quella è gente che non ha di meglio da fare che smuovere le lapidi della gente di colore o ridurle in mille pezzi buttandole nel torrente. Che poi sono pure codardi, figliolo, perché lo sanno che i neri non reagiranno mai, così davanti a tutti, col rischio di vedersi arrivare quelli del Klan, altra gente di quella fatta.” (pag 131)
Scopre che i diritti non sono per tutti, che le donne, specie se di colore, sono sempre vittime; che i pregiudizi avvelenano i rapporti sociali, le amicizie, il vicinato; che c’è chi lucra sulla pelle degli altri; che non tutto è come appare. Noi, però, non ci soffermeremo su quest’aspetto scontato, ma toccheremo il principale pregio di un romanzo che, se non segna, non sconvolge, non penetra, comunque avvince almeno per il tempo limitato della lettura: non è la crescita interiore del protagonista, come abbiamo detto, né l’intreccio, improbabile e pure irrisolto, quanto piuttosto l’atmosfera riuscitissima dell’America fine anni cinquanta. Non seguiamo, quindi, l’investigazione di Stanley sulle due ragazze morte in circostanze oscure molti anni prima, il ritrovamento delle lettere, il cofanetto sepolto, la paurosa casa sulla collina. Alla fine, le scoperte fatte da Stanley ci lasciano indifferenti, il protagonista sembra non avvertire nemmeno orrore mentre disseppellisce cadaveri che dovrebbero agghiacciarlo. Non ci interessa dipanare il mistero del fantasma senza testa che si aggira lungo la ferrovia, quanto piuttosto tallonare Stanley nei suoi spostamenti, pedalare con lui su per la collina mentre l’aria rinfresca prima del temporale, infilarci nel gabbiotto del proiezionista negro sempre ubriaco.
“D’estate ce ne voleva prima che facesse buio, e il sole – che ancora non trovava ostacolo in grattacieli né in casermoni popolari – si tuffava tra gli alberi del Texas orientale come una stella cadente. Via via che tramontava, dava l’impressione di mettere a ferro e fuoco interi boschi.” (pag 20)
Stanley gestisce con la famiglia un drive in, in una cittadina del Texas magistralmente ricreata dall’autore e che ci pare aver visto tante volte nei film, fatta di case di legno, di prati, di ragazzini in bicicletta, di giovani con il ciuffo e il risvolto sui pantaloni, di tavole calde capaci di farci tornare alla mente quelle evocate negli anni trenta da Mc Cain ne Il postino suona sempre due volte.
“Alla radio passava il rockabilly, o il rock and roll, come finì poi per essere chiamato, ma di queste atmosfere rock and roll l’aria delle nostre parti non era certo satura. Eravamo solo un branco di ragazzini che il pomeriggio e la sera si radunavano di fronte al Dairy Queen, in particolare il venerdì e il sabato sera. Alcuni di noi, come Chester White, portavano i capelli a coda di papero e giravano su macchine super truccate. Quasi tutti avevano i capelli corti, e una cospicua banana sul davanti, tenuta ferma da un bel po’ di brillantina. Indossavano calzoni ben stirati, camicie bianche inamidate, e scarpe marroni belle lucide e guidavano la macchina di famiglia le volte che riuscivano a metterci le mani sopra.” Pag 20)
Sembra una scena di Grease o del telefilm Happy Days, ma qui i protagonisti hanno varcato la sottile linea scura che “separa i misteri delle tenebre dalla realtà”, porta alla luce i cadaveri, il marcio, il putrefatto, il celato, e dove un ragazzo che ha appena smesso di credere a Babbo Natale scopre la bestialità degli uomini. Durante la sua indagine, Stanley si scontra con la rabbia covata dai negri per la loro condizione subalterna, rabbia che, a loro volta, i maschi (non solo neri) sfogano sui figli e sulle donne per riaffermare la propria esistenza, il proprio posto nel mondo. Stanley però si salva, la sua luce interiore rimane intatta grazie all’esempio familiare, alla rettitudine del padre, all’amore della madre, alla complicità della sorella maggiore, alla dignità del suo cane, all’amicizia del proiezionista Buster e del coetaneo Richard. Qualcosa però si è incrinato, la vita non sarà mai più spensierata come una volta, una sorta di malinconia diffusa accompagna tutto il romanzo dalla prima all’ultima pagina.
“Non sempre la vita dà soddisfazione e, al tirar delle somme, carne e polvere finiscono per rivelarsi la stessa cosa.” (pag 315)
Many, speaking of Joe R. Lansdale's A Fine Dark Line, immediately cite the Bildungsroman, the training novel such as Stand by me, with the classic loss of innocence.
Stanley Mitchell, the thirteen-year-old protagonist, in a long hot Texan summer, discovers that the world is not as he believed it, that people have sex with each other, kill, get drunk, beat their wives, brutalize their children. Above all, he discovers that blacks are not the same as whites, they are not given the same place in the order of things.
“Those are people who have nothing better to do than to move the gravestones of black people or to cut them into a thousand pieces by throwing them into the stream. Who are cowards too, son, because they know that black people will never react, like this in front of everyone, with the risk of seeing those of the Klan arrive, other people like that ".
He discovers that rights are not for everyone, that women, especially if they are coloured, are always victims; that prejudices poison social relationships, friendships, the neighbourhood; that there are those who make money on the skin of others; that not everything is as it appears.
We, however, will not dwell on this obvious aspect, but we will touch the main merit of a novel that, if it does not mark, does not upset, does not penetrate, however enthuses, at least for the limited time of reading: it is not the inner growth of the protagonist as we have said, neither the improbable and yet unresolved plot, but rather the very successful atmosphere of America in the late fifties.
Therefore, we do not follow Stanley's investigation about the two girls who died in obscure circumstances many years before, the discovery of the letters, the buried casket, the scary house on the hill. In the end, the discoveries made by Stanley leave us indifferent, the protagonist seems seems even not to feel horror as he unearths corpses that should freeze him. We are not interested in unraveling the mystery of the headless ghost that wanders along the railway, but rather in following Stanley in his movements, pedaling with him up the hill while the air cools before the storm, slipping into the cage of the always drunk negro projectionist.
"In the summer it took a long time before itgot dark, and the sun - which still had no obstacle in skyscrapers or popular barracks - plunged into the trees of eastern Texas like a shooting star. As it set, it gave the impression of putting entire woods on fire. "
Stanley manages a drive in with his family, in a town in Texas masterfully recreated by the author and which we seem to have seen many times in films, made of wooden houses, meadows, kids on bicycles, young people with tufts and the lapel on the trousers, of cafeterias capable of bringing to mind those evoked in the thirties by Mc Cain in The postman always rings twice.
"Rockabilly, or rock and roll, passed on the radio, as it ended up being called, but the air of our parts was certainly not saturated with these rock and roll atmospheres. We were just a bunch of kids who gathered in the afternoon and evening in front of the Dairy Queen, especially on Friday and Saturday nights. Some of us, like Chester White, wore duck hair and turned on super lowriders. Most of them had short hair, and a conspicuous banana on the front, held in place by a good deal of glitter. They wore well-ironed breeches, starched white shirts, beautiful shiny brown shoes and drove the family car the times they could get their hands on it. ”
It looks like a scene from Grease or Happy Days, but here the protagonists have crossed the thin dark line that "separates the mysteries of darkness from reality", brings to light the corpses, the rotten, the putrefied, the hidden, and where a boy who has just stopped believing in Santa Claus discovers the bestiality of men. During his investigation, Stanley collides with the anger hatched by the Negroes for their subordinate condition, anger which, in turn, the males (not only blacks) vent on their children and women to reassert their existence, their place in the world.
Stanley, however, is saved, his inner light remains intact thanks to the family example, the righteousness of the father, the love of the mother, the complicity of the older sister, the dignity of his dog, the friendship of the projectionist Buster and the friend Richard. But something has cracked, life will never be as carefree as it once was, a sort of widespread melancholy accompanies the whole novel from the first to the last page
Moreno Montanari, "La filosofia come cura"
/image%2F0394939%2F201303%2Fob_0a8458dd7c0f03cf767e8b8a14412928_montanari-88425-5050-1.jpg)
La filosofia come cura
Di Moreno Montanari
Mursia, 2012
pp. 162
14,00
La nuova collana Tracce Mursia favorisce un approccio discendente alla filosofia, un calarsi della speculazione verso l’individuo, aiutandolo nella sua vita quotidiana. Il saggio di Moreno Montanari, “La filosofia come cura”, è un excursus sul pensiero filosofico, con particolare attenzione per i filosofi di contenuto psicanalitico e per le filosofie orientali, in una sorta di “fusion”, fra Hegel, Nietzsche e le pratiche di meditazione, il tutto integrato in senso olistico. Il testo si situa all’interno dell’odierno orientamento antinegativo, ribaltandolo.
L’immagine che oggi siamo obbligati a dare di noi è quella di persone positive, solari, sane, benestanti e sempre felici. Ogni sofferenza, ogni riflessione sulla morte e sulla malattia, sull’utilità o meno della vita, devono essere occultate, rimosse, bandite, altrimenti si è negativi, si attira il male, si porta male agli altri. Essere infelici non è più in voga, l’uso di antidepressivi è aumentato in modo esponenziale, chiunque provi emozioni difficili da gestire, chiunque abbia subito un lutto, prende una pasticca salvifica, come se piangere un morto non fosse più naturale. E non solo si ricorre ai farmaci per gravi depressioni postraumatiche, ma anche per piccoli disagi, come il non aver voglia di studiare o sentirsi giù di corda durante le festività.
Si hanno tre approcci alla sofferenza: quello medico, che considera il male come prodotto organico e lo cura con i farmaci medicalizzando ogni aspetto della realtà, quello psicosomatico, che lo cura con la psicanalisi, e quello scelto da Moreno, cioè il filosofico.
Sin dai tempi di Eraclito, la filosofia ci esorta a non giudicare, a non sentenziare ciò che è bene e ciò che è male, ciò che va mantenuto e ciò che va estirpato. Anche il male, come ogni altro elemento, fa parte del tutto, in una visione olistica. La sofferenza non è figlia del peccato né è malattia, ma una risorsa da non trascurare o rimuovere. Moreno Montanari ci spinge a rivalutare il negativo e il dolore come straordinari stimoli al raggiungimento di un sé più autentico. Star male anche psicologicamente, aiuta a rafforzarsi, a reagire, a sopportare, che non vuol dire soffrire inutilmente o idealizzare il dolore.
“L’esperienza della sofferenza, per quanto dolorosa possa essere, reca infatti con sé la possibilità di attivare forze, qualità, riflessioni e sentimenti che diversamente non conosceremmo né attiveremmo mai.” (pag. 30)
Montanari parla di iatrogenesi della malattia. È il medico a stabilire che siamo malati o depressi trasformando problemi esistenziali ed umani in patologie da curare con le medicine, togliendo al paziente la responsabilità della sua vita, rendendolo dipendente da figure esterne.
Il saggio affronta il problema della sofferenza dal punto di vista ermeneutico. La sofferenza crea angoscia, angst, e l’angoscia è la spinta, la chiamata, che permette un’interrogazione sullo stile di vita, volta al raggiungimento di un io più vero. L’autenticità, si badi, non è intrinseca al soggetto o innata, ma un modo di porsi nella realtà e con gli altri, un modo, insomma, di vivere.
“L’autenticità non è solo il frutto della consapevolezza che si guadagna interrogandosi sul proprio modo di essere al mondo, ma anche l’effetto della decisione di appropriarsi delle proprie possibilità d’essere, progettandole a partire dalle nostre peculiarità più proprie, ovvero da ciò che più ci caratterizza.” (pag.26)
Heidegger parla di sé contrapposto al si passivo. Non essere autentici significa adattarci agli obblighi del si passivo, per debolezza e per incapacità di assumerci la responsabilità di ciò che davvero siamo, adagiandoci in un comodo conformismo senza prenderci davvero cura di noi stessi, come la filosofia insegna a fare.
Le filosofie orientali - il buddismo in particolare - costituiscono un grande aiuto in questo processo di presa in carico e cura di noi stessi, se non le si considera come religioni, né come filosofie, ma piuttosto come vere e proprie psicoterapie.
Il buddismo ritiene disagio e dolore come qualcosa da esperire perché è nell’esperienza stessa che sta il mezzo per superarla, in una parola, il viaggio è già la meta e il male va sentito, attraversato, non allontanato.
“Non dovremo considerare i disagi, emotivi e fisici, le preoccupazioni, le paure e le sofferenze di cui faremo esperienza come ostacoli da evitare lungo il sentiero che conduce al superamento della sofferenza perché essi stessi costituiscono invero il sentiero.” (pag 32)
Sulla strada della conoscenza di sé sono controproducenti l’isolamento e l’individualismo. Solo il confronto con l’altro ci rivela a noi stessi e mette in evidenza la reale portata di qualità che ci immaginavamo solo di possedere. Uscire da noi stessi ci fa vedere come gli altri ci vedono e non con quell’identità falsa che ci siamo costruiti, il “falso sé”.
“Il soggetto che si sente esasperatamente manchevole, si dota, ma solo immaginariamente, di qualità che vorrebbe avere perché le riconosce come vincenti. Sotto questa spinta l’individuo può addirittura arrivare a convincersi di possedere realmente quelle qualità che ha solo immaginato. […]Così, allorché ci si trovi a rendere direttamente conto di tali presunte qualità in occasioni pubbliche (durante le interrogazioni a scuola o all’università, in determinate prove al lavoro, nel confronto amoroso ecc) si resta schiacciati dal timore del giudizio degli altri e dalla preoccupazione per la difficoltà e l’importanza, assolutamente spropositata, che la prova assume ai nostri occhi e, terrorizzati dalla paura di non avere affatto quelle qualità che ci s’illudeva di possedere, si rischia di restare bloccati, di desistere dall’affrontare la prova o di cadere nel panico.” (pag. 44)
Oggi si è depressi non più per senso di colpa ma per senso di inadeguatezza. L’uomo naturalmente tende alla completezza ed enfatizza l’importanza di ciò che gli manca rispetto a ciò che ha. Lacan ha addirittura ipotizzato che l’uomo cerchi solo in maniera fittizia di realizzare il proprio desiderio ma in realtà lavori per mantenerlo. È utile un ridimensionamento dei desideri alla luce di quanto effettivamente è alla nostra portata, imparando ad apprezzare ciò che abbiamo già e a convivere con ciò che ci manca. Il vuoto non produrrà più allora horror vacui ma sarà un nulla privato delle sue qualità negative, un nulla positivo, il veicolo per condurci da una realtà soggettiva, pensata e individualistica, alla realtà vera, e a noi stessi nella nostra autenticità.
La meditazione ci viene in soccorso, allenandoci alla sospensione del giudizio, ed è una pratica che va sempre riconquistata con l’allenamento. La respirazione aiuta a rilassarsi e ad agire sui nostri pensieri e le nostre emozioni. Le difficoltà che incontriamo nella meditazione costituiscono esse stesse il sentiero verso la realizzazione.
Il nostro carattere è il nostro destino, sebbene il futuro non dipenda esclusivamente da noi perché alla sua concretizzazione concorrono molte variabili esterne. Cercando di controllare il nostro mondo per renderlo comodo e sicuro, lo restringiamo finendo per vivere un surrogato di vita. L’abitudine non è di per sé dannosa, lo è semmai l’inconsapevolezza che la accompagna. Conoscere le nostre abitudini e ciò che le provoca vuol dire conoscere se stessi.
Conoscere se stessi significa valorizzare i propri talenti senza rincorrere quelli che non ci sono propri. Imparare a decidere è la cosa più difficile e la si ottiene solo con l’abitudine a farlo, smettendo di delegare agli altri la responsabilità del nostro destino. La crisi odierna dei valori e dei riferimenti ci costringe a decidere senza un ordine esterno condiviso e questo ci spaventa, non lo viviamo come libertà ma piuttosto come schiacciante responsabilità. L’uomo nietzschiano è stremato dal suo essere sovrano di se stesso, dalla sua sovramoralità.
Nella vita tutto è possibile ed è facile che le nostre aspettative non si realizzino. Invece di tendere ad un’irraggiungibile perfezione, meglio familiarizzare con l’incertezza, con la possibilità del fallimento, della malattia, della morte. Si è autentici solo se si è consapevoli della nostra indeterminatezza e caducità. Le illusioni aiutano, ma è solo il confronto con la scomoda realtà che ci rende veri. Non si può rimanere fermi a ciò che si è senza cercare di migliorarci ma nemmeno volersi del tutto diversi, pena la depressione, il senso d’insufficienza e d’inidoneità. Noi siamo ciò che crediamo di essere ma anche ciò che non sappiamo di essere, in una continua oscillazione fra io ideale e io reale.
“È nella vita e non nell’ideale che si realizza la nostra identità”. (pag. 74)
Non dobbiamo quindi conformarci a un ideale autoimposto o imposto dall’esterno ma adattarci alla vita che scorre, che ci vuole sempre diversi, che è imprevedibile e che non si lascia controllare da noi.
Anche il passato va rivisto, poiché, se non lo si può cambiare, si può però considerare ciò che è stato in modo diverso, modificando l’influenza degli eventi su di noi, superando i sensi di colpa, comprendendo che noi siamo come siamo proprio grazie a ciò che abbiamo vissuto.
“Siamo l’esito di quanto abbiamo vissuto, siamo ciò che ci è accaduto e il modo in cui lo abbiamo elaborato: il nostro presente comprende tutto il nostro passato e ogni volta che diciamo di sì ad un solo istante della nostra vita la riaffermiamo nella sua interezza.” (pag. 90)
In conclusione al suo saggio, Montanari si sofferma sul suo filosofo preferito, Nietzsche, concentrandosi sul concetto di nichilismo. La nostra è una società in cui Dio è morto, i valori hanno carattere umano e storico e ci siamo accorti che la vita non ha alcun senso. Questo però non deve indurci a una forma di nichilismo passivo, bensì al suo contrario, al nichilismo attivo. La vita non ha senso, è vero, ma non per questo non è bella. La vita ha valore così com’è, solo perché è vita, non ha bisogno di un senso, di un fine, di una trascendenza che la ordini e la muova. Vivere è già il meglio che ci sia, al di là del bene e del male, e senza mettere l’uomo al centro delle cose, bensì in armonia con la biosfera.
Secondo Montanari, l’unica possibilità di dare senso all’esistenza è la comunione con gli altri. Solo se anche gli altri vedono ciò che noi vediamo e odono ciò che noi udiamo, possiamo essere certi dell’esistenza del mondo e di noi stessi.
Tutto ciò che nasce è destinato a morire, spesso senza preavviso. Agli occidentali viene insegnato a negare la morte, a considerarla un tabù impronunciabile. Ma la morte deve essere oggetto di meditazione, poiché solo pensandola, solo mettendoci nei panni di chi sta per morire, si può dare valore alla vita, apprezzarla, non sprecarla, mirando all’ascesi, alla cura di sé, alla liquidazione di ogni alibi per la propria condizione. In questo modo la morte non ci terrorizzerà, non tanto nel suo processo cruento, quanto per lo strazio di una vita che finisce senza essere mai stata vissuta.
“È uno sbaglio lasciar consumare le ore nella speranza di giungere alle mete della vita.” (pag 80)
/http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-n_4DCK76xtk%2FT9hif6g1iMI%2FAAAAAAAAGSc%2FC8cRu3Ffwxk%2Fs320%2FMontanari_88425-5050-1.jpg)
CriticaLetteraria: Moreno Montanari, "La filosofia come cura"
La nuova collana "Tracce" di Mursia favorisce un approccio discendente alla filosofia, un calarsi della speculazione verso l'individuo, aiutandolo nella sua vita quotidiana. Il saggio di Moreno ...
http://www.criticaletteraria.org/2012/10/moreno-montanari-la-filosofia-come-cura.html
"Tu puoi!" il nuovo libro di Mario Furlan
/image%2F0394939%2F201302%2Fob_b1099235b733e198aef051796c8ce968_furlan-tu-puoi.gif)
Di David Di Luca
Il volume è disponibile su Amazon.it
Mario Furlan non ha certamente bisogno di presentazioni. Giornalista con presenza multimediale, organizzatore di attività sociali che si occupano degli ultimi come i City Angels, ma anche formatore e motivatore. Proprio in quest'ultima veste ha scritto questo libro dal titolo Tu puoi!
Come ci si può aspettare da Mario, non è un libro del tipo "è tutto facile, spingi questo bottone'. Al contrario, Furlan mette in queste pagine tutta la propria esperienza, dicendoti: nella vita ci sono delle difficoltà, ma è proprio confrontandosi con queste che si diventa forti e si ottengono risultati e soddisfazioni.
Il risvolto di copertina definisce il libro "un pugno nello stomaco". E a volte proprio di quello c'è bisogno per svegliarsi dal torpore che spesso ci porta a dare la colpa di una situazione agli altri, mentre siamo sempre e comunque noi ad essere responsabili, cioè capaci di rispondere a tutto quello che ci succede.
di Ida Verrei: Integrazione o inclusione?
"Prendi quello che vuoi, ma lasciami la mia pelle nera"
di Cheikh Tidiane Gaye
Edit. Jaca Book – collana Terra Terra
pp. 121
10,00
Recensione
di Ida Verrei
Scrittore e poeta italo-senegalese, Cheikh Tidiane Gaye ci regala una narrazione che è insieme letteratura e poesia, analisi sociologica e storia, testimonianza del presente e incursione nella memoria. Un libro intenso, colmo di moniti per le coscienze individuali e collettive.
È un romanzo epistolare insolito; una lunga lettera senza risposta all’amico-fratello Silmakha, una sorta di diario, dove si alternano riflessioni profonde e amare, ricordi dolci, storie nella storia. È uno spietato atto di accusa alla civiltà occidentale, e alla città di Milano in particolare:
“I miei primi mesi in Italia sono stati difficili (pag. 18) … Mi sono perso e non mi sono ritrovato…
Ho anche paura di uscire da casa mia e girare in città. Milano, che tanti cantano come una città integrata, è il luogo delle disuguaglianze… (pag.22)
Ma è anche un’ accorata dichiarazione d’amore al paese che lo ospita e che vorrebbe sentire suo, senza però perdere la propria identità:
“quando un cuore batte per una nazione, non può essere che la conferma di una reale integrazione” (pag.
Integrazione, però, non è omologazione, rinuncia alle proprie radici, negazione della propria cultura; integrazione è inclusione, afferma Gaye, è riconoscimento dell’altro, è rispecchiamento nei sentimenti, nelle pulsioni, nei diritti di ciascun essere umano: è empatia.
E attorno a questo tema si dipana una storia di disagi, angosce, rifiuti, offese brucianti, vissute sempre con coraggio e dignità, con l’orgoglio di non aver mai “steso la mano, perché un vero gor (onesto) mangia col sudore della propria fronte”(pag.36); l’orgoglio della sua “pelle nera, il colore dell’ebano, non delle tenebre…” ( pag.82).
Cheikh Tidiane Gaye dai suoi compatrioti è considerato “uno che ce l’ha fatta”; e forse è così: ha un buon impiego in banca, un posto riconosciuto nel mondo letterario italiano. Ma continua a subire molestie razziali per il colore della pelle, non si sente libero, percepisce la diffidenza dell’altro. E non si tratta solo di chiusura mentale di derivazione xenofoba, non è soltanto ignoranza, non-conoscenza. Altre storie diverse eppure simili alla sua, lo dimostrano. E allora ci racconta di Michel, laureato in scienze bancarie, uno dei tanti extracomunitari di seconda generazione, che si considera “un marciapiede inondato dai passanti con rifiuti” (pag.25); o quella dell’anziano Salifu, della Costa D’Avorio, amato e rispettato nella propria comunità, ma diventato dopo vent’anni apolide, perché il suo paese spaccato da una politica scissionista lo rifiuta e il nostro lo respinge; o ancora, quella di Ibraim, il giovane professore che ha abbandonato i propri alunni in patria e ora vende merce su un telo steso sui marciapiedi di Genova, e porta in tasca il dizionario Italiano-Francese, per imparare la lingua di Dante.
“La grandezza di un popolo si misura dal suo modo di trattare gli ospiti.
Nelle nostre tradizioni il bene più prezioso è l’estraneo… Mi diceva mio nonno: all’ospite veniva offerto il latte appena munto della mucca più grassa; la capra era immolata in segno di buon augurio e accoglienza. Prima, all’ospite veniva data una sedia o la stuoia e tutta la famiglia era lieta di avere una nuova persona con sé. Era considerata come la rugiada “ (pag.31)
Cheikh Tidiane Gaye attibuisce un significato sociologico e politico al proprio concetto di integrazione, noi potremmo aggiungere che è riconducibile anche a un concetto teologico di ispirazione pasoliniana: “ Noi possiamo conoscervi solo attraverso Dio perché i nostri occhi sono troppo abituati alla nostra vita e non sanno più riconoscere quella che voi vivete nel deserto e nella selva, ricchi solo di prole. Noi dobbiamo sapervi riconcepire e siete voi a testimoniare Dio ai fedeli inariditi, con la vostra allegrezza, con la vostra pura forza che è fede” (S.Francesco- dal film Uccellacci e Uccellini di P.P.Pasolini)
E a questo si riferisce Gaye quando parla di “inclusione”: si tratta di “riconcepire” la presenza dell’immigrato extracomunitario come fatto organico, parte della nostra vita, un altro sapere, non addomesticato, che ci stimoli a un confronto con culture altre, che possono soltanto accrescere e valorizzare la nostra, perché “ la somiglianza è monotona, la diversità è ricchezza” (pag.33)
Le argomentazioni di Gaye non sono solo cronaca, letteratura, fredda osservazione di eventi, sono vita, legate al filo rosso della storia: “il nostro passato è l’unico in grado di testimoniare il nostro presente e il nostro futuro. (pag.70) E del passato ci parla l’autore, attraverso il racconto di un viaggio nella terra d’origine, richiamato da eventi tristi e luttuosi. Ci racconta incontri, emozioni, ricordi che lo travolgono; ma con onestà ci parla anche di realtà che non sente di condividere: la bigamia, il maschilismo, i rituali esasperati. Per un attimo il suo cuore vacilla, da qualcuno viene anche accusato di essere diventato un vero tubab (uomo bianco), ma un pellegrinaggio all’isola magica di Gorée, lo riconduce alle sue più autentiche radici.
Un tempo l’isola serviva ai colonizzatori in Africa come punto di vendita degli schiavi africani ai mercanti europei in partenza per il nuovo continente americano. Prima di essere venduti, gli schiavi venivano rinchiusi nella Maison des Esclaves; lì, le famiglie venivano divise, gli individui perdevano la propria identità, prigionieri dei negrieri, in attesa di oltrepassare la “porta del non-ritorno”, verso le coste americane, o, se non ritenuti idonei, buttati in un mare invaso dagli squali. Un commercio durato tre secoli; milioni di africani strappati alle loro terre; una storia dimenticata, occultata. Gaye si chiede perché l’Occidente cancelli le proprie colpe, come possa non sentire il peso di crimini contro l’umanità che gridano vendetta al cospetto di Dio:
“Cara Europa, ascolta il battito del mio cuore, leggi nei miei occhi, apri il tuo cuore e abbracciami. Cara Europa, amo i tuoi figli e amerò la tua terra, ma non so come dire al mondo dei danni che hai causato al mondo…(pag.80)
…Insegna ai tuoi figli la storia, la verità …ad accogliere, non a respingere…
Non ti chiederò il risarcimento, ma il rispetto. (83)
Il libro di Cheikh Tidiane Gaye è una denuncia dura, ferocemente lucida, un j’accuse senza appello, che sgomenta e scuote, ma è anche poesia.
Le pagine più belle, struggenti sono quelle che dedica alla propria terra. Lì, il linguaggio si fa lirismo puro. Io non so se l’essere poeta in quel modo sia qualcosa che gli appartiene, proprio in quanto poeta, o se gli venga dal suo sangue africano, dalla sua pelle nera: “Sono nato poeta, ho il verso sulle mie labbra, la rima nelle mie mani, la strofa nei miei occhi…(pag.82), quello che è certo, però, è che emoziona e commuove come il canto antico degli Aedi greci:
“…rivivrò con le mie danze da negro, racconterò le fiabe, le favole indigene e raccoglierò i passi di tuoi valorosi lottatori.
… Prenderò un cavallo tutto bianco e percorrerò da imperatore il mondo e inviterò l’umanità a cantare il tuo illustre nome. Nel braciere d’incenso purificherò non solo i passi dei tuoi degni figli e, all’ombra dei tuoi griot, affileremo le corde delle Kora e percuoteremo i balafon…
…Chiederò a Dante, Hugo, Leopardi e Rousseau, e al resto dei grandi cantori del verbo, di diventare il tuo poeta.” (pag 87)
In chiusura, una tenerissima lettera al figlio mulatto. È un padre che racconta, insegna, ammonisce, indica: “tu, oggi non seguirai il percorso di tuo padre, ma, credimi, sei l’ombelico del mondo, sei il linguaggio della creazione umana. Non pensare troppo alla tua ibridità. Non pensare di non esistere: tu sei la linfa della vita, partorita tra due culture e civiltà. Il mondo appartiene a te.”(pag.120)
È una speranza che, come dice Giuliano Pisapia nella sua bella prefazione, deve tradursi in realtà. È un augurio, al quale mi piace aggiungere il mio:
Che la tua vita nel nostro mondo, che è anche il tuo, sia sempre colma di miele!
Ida Verrei.
Emanuele Marcuccio, "Pensieri minimi e massime"
/image%2F0394939%2F201302%2Fob_14f37d_emanuele-marcuccio-pensieri-minimi-e-massime-fron.jpg)
Pensieri minimi e massime
di Emanuele Marcuccio
prefazione di Luciano Domenighini
postfazione di Lorenzo Spurio
PhotoCity Edizioni, Pozzuoli (Na), 2012, pp. 47
ISBN: 978-88-6682-240-0
Prezzo: 7,60 Euro
Parafrasando Shakespeare (cfr. La Tempesta, atto IV, scena I), siamo fatti della materia di cui sono fatte le stelle: principalmente di atomi di carbonio e di carbonio sono fatti i diamanti. Immensa come le stelle è la vita, preziosa più dei diamanti (aforisma 69)
Non è un saggio né una silloge poetica “Pensieri minimi e massime” di Emanuele Marcuccio bensì una raccolta di ottantotto aforismi più una appendice che costituisce parte integrante dell’opera.
L’aforisma 14 è l’enunciazione della poetica di Marcuccio: “Nelle arti, come nella vita, se c’è spontaneità, c’è anche personalità.” L’autore ci appare come un giovane che annota i suoi pensieri, “semplici ma profondi”, come egli stesso tiene a precisare, un giovane d’altri tempi, imbevuto di poesia, da Leopardi, a Pascoli, a Shakespeare, un giovane che si abbevera alla fonte poetica, che ne trae consolazione. Non fa mistero del suo bisogno di recuperare uno sguardo meravigliato sul mondo, il fanciullo pascoliano che è in noi, l’espressione semplice, le parole povere e ripetute ma non prive di valore, la genuinità di baci e abbracci in un rapporto d’amore che è anche dialogo, raccontarsi la vita come dono. È significativa l’insistenza sul concetto di “meraviglia”.
L’autore alterna questa enunciazione istintiva con riflessioni più articolate, più intellettuali, forse estrapolazioni e rielaborazioni di saggi, e addirittura con echi da tragedia greca: “Cupo è il nostro tempo, cupa è la scena di questo mondo e il nostro sentire in una tempesta si inabissa.” (aforisma 42)
Mentre riflette sulla lirica, ha barlumi poetici egli stesso: “L’anima del mondo ha ali ad abbracciare il tutto” (aforisma 32).
Marcuccio conosce la poesia e le sue figure retoriche, il correlativo oggettivo che passa da Eliot a Montale – nell’appendice compie, infatti, un notevole e avvincente excursus attraverso i secoli, da Omero a San Francesco fino a Ungaretti – ma è convinto che alla base di tutto ci sia, sempre e comunque, l’ispirazione, vista come folgorazione irrazionale, o meglio pre-razionale, scorciatoia intuitiva.
L’ispirazione è come la grazia divina, un dono, un capriccio degli dei che investe il poeta, che è solo un recettore, un vaso che attende l’illuminazione, senza la quale c’è solo arido e sterile artificio. Il poeta deve porsi in ascolto, attendere questa voce, questa luce che lo colmerà, che lo trasfigurerà. Solo in seguito potrà rielaborare, limare, ricostruire il materiale grezzo che è, però, già di per sé diamante.
/http%3A%2F%2Fblogletteratura.files.wordpress.com%2F2012%2F07%2Femanuele-marcuccio-pensieri-minimi-e-massime_front_730.jpg%3Fw%3D440%26h%3D330%26crop%3Dtrue)
"Pensieri minimi e massime" di Emanuele Marcuccio, recensione a cura di Patrizia Poli
"Pensieri minimi e massime" di Emanuele Marcuccio, recensione a cura di Patrizia Poli prefazione di Luciano Domenighini PhotoCity Edizioni, Pozzuoli (Na), 2012, pp. 47 Parafrasando Shakespeare (cfr
Fabio Marcaccini, "Buongiorno anche a te"
/image%2F0394939%2F201302%2Fob_9caf2b_120875-copertina-frontcover-icon.png)
Prefazione di Patrizia Poli
Oltre ogni inganno, l'uomo, il poeta Marcaccini, è solo. Solo di fronte alla sua coscienza, solo con la consapevolezza dei propri umanissimi errori e di ciò che non sarà mai piu', solo di fronte al tempo che se ne va. Niente piu' abbellimenti, niente illusioni, bensì parole, pulite e scabre. Egli trova conforto nella natura, madre e non matrigna, intesa come archetipo, elemento primigenio. Il mare sarà quindi il suo mare di Calafuria, ma anche “il mare” di tutti noi, il mare di ogni epoca ed ogni vita. Di fronte all'onda, allo scoglio, alla risacca, come di fronte all'aquila e alla vetta, egli sarà ancora una volta solo col suo dolore, appena mitigato, a tratti, da tenui bagliori di speranza. Come unico riscatto, l'Amore, ormai scevro da connotazioni profane, capace di sublimare la carnalità in un dolcissimo sentimento che unisce e redime, che solleva al di sopra delle brutture del mondo. Insieme all'amore, l'amicizia, sempre desiderata e sempre tradita da coloro in cui si era riposta fiducia. Ultimo ma non certo ultimo, l'affetto paterno, che trasmette il testimone a chi viene dopo di noi, a chi si ama di un amore smisurato ed infinitamente indulgente. La poesia di Marcaccini ci tocca nel profondo, perché sgorga dall'umano bisogno di redenzione e dignità, contro tutto e tutti.

/image%2F0394939%2F20190531%2Fob_6113d1_61425960-10216728261030327-19684367693.jpg)