Bei ricordi della “tolleranza repressiva”, come la chiamava Marcuse

Di Guido Mina di Sospiro – pubblicato nell’originale inglese da New English Review, tradotto in italiano da Patrizia Poli.
Il contesto: l’Italia durante gli anni di piombo nei secondi anni settanta.
La situazione: dopo la seconda guerra mondiale, si era creata una tregua camuffata da pace; l’Italia era riuscita a rimanere nell’Occidente, ed era divenuta un membro della NATO. La sinistra italiana non poteva accettare questa realtà, né poteva farlo il blocco sovietico. Ma il boom economico degli anni cinquanta e sessanta aveva distrutto qualsiasi speranza realistica di una rivoluzione marxista. Con l’economia che peggiorava nei tardi anni sessanta, e poi con la crisi del petrolio, la sinistra, i sindacati di sinistra, e la sinistra extraparlamentare cercarono tutte di trarre vantaggio dalla situazione. A suon di picchetti, scioperi, dimostrazioni sempre più frequenti e tumultuose, edifici occupati, e di tutti i mezzi a loro disposizione, un certo numero d’italiani, ingenui ma duri, si persuasero che il destino dell’Italia fosse nelle loro mani piuttosto che in quelle delle due superpotenze e dei loro alleati. Perciò, fecero tutto quanto poterono per realizzare una rivoluzione marxista. I simpatizzanti dell’estrema sinistra – i radicali, quelli che tiravano bombe Molotov e facevano fuoco durante le dimostrazioni – e i terroristi in piena regola, decisero di prendere una scorciatoia, e si dettero alla lotta armata, trasformando le principali città della nazione in zona di guerra.
Tali convulsioni riaccesero la miccia, e cominciò così la “strategia della tensione” - con bombe presumibilmente esplose da agenti italiani (ma non necessariamente), i quali seguivano l’agenda delle organizzazioni straniere o dei governi che non comparivano (“stay-away-gornments”).
Logistica dell’autore: giusto nel mezzo di tutto ciò, da ragazzo, nel liceo più caldo di Milano.
Il nuovo anno scolastico poteva cominciare trionfalmente, con uno sciopero, seguito da un’assemblea generale.
Il liceo scientifico Leonardo da Vinci era dotato di quella che oggi è conosciuta come la sala dei congressi della provincia di Milano, un auditorio che accoglie cinquecentoventicinque ospiti ma, allora, con sedili più striminziti, di più. Era sottoterra, proprio sotto la scuola. Gli attivisti politici lo avevano requisito, e trasformato nell’aula magna delle loro assemblee generali.
Io saltavo le assemblee ogni volta che le circostanze me lo permettevano, ma era prudente non saltarle tutte, poiché eravamo osservati dalla Psicopolizia (per usare il termine coniato da Orwell in 1984), e un saltatore seriale poteva essere un qualunquista o, peggio ancora, un apolitico, passi falsi entrambi.
I relatori alle assemblee avevano preso a cuore la massima latina repetita iuvant. Erano i leader o rappresentanti di vari gruppi di ultra sinistra, come Movimento Studentesco, Lotta Continua, Il Manifesto, Avanguardia Operaia e altri, oltre alla Federazione Italiana Giovani Comunisti.
Il primo oratore esprimeva sdegno per questo o quello (di solito qualcosa di molto topico, che interpretavano come una provocazione fascista o borghese), quindi giurava sostegno alla tale o talaltra causa, e finiva con un elettrizzante incitamento a combattere per tutti i compagni. Dopo un applauso non proprio fragoroso, l’oratore successivo esprimeva sdegno per questo e quello (lo stesso argomento del suo predecessore), poi giurava sostegno alla tale o talaltra causa, e finiva con un elettrizzante incitamento a combattere per tutti i compagni. Dopo un applauso ancor meno fragoroso, l’oratore successivo esprimeva sdegno per questo e quello, (lo stesso argomento del suo predecessore / dei suoi predecessori), poi giurava sostegno a questo e quello, e terminava con un eccitante incitamento a combattere per tutti i compagni. Siccome c’erano diversi gruppi di ultra sinistra, ogni capo rappresentante sentiva che fosse suo dovere politico parlare, così il tutto andava avanti per ore.
Ogni tanto, un roboante “Lenin-Stalin-Mao-Ze-tung!” si frapponeva (per darci la sveglia?); suonava sia ideologicamente appropriato sia ritmicamente accattivante.
Se qualcuno fuori dei ranghi esprimeva un modicum di dissenso, gli o le veniva istantaneamente urlato “boo”, e gli o le veniva tolto dalla bocca il microfono altrettanto velocemente. Se qualcuno esprimeva dissenso effettivo, un accadimento molto ma molto più raro, che da solo valeva la partecipazione all’assemblea, veniva pestato a sangue. E perciò l’armonia regnava suprema nell’aula magna durante tali maratone di libertà di parola.
Quando questa particolare assemblea terminò, lasciai l’aula tutto anchilosato e, come se mi stesse aspettando, m’imbattei in Fletcher (un attivista di estrema sinistra che alla fine diventò un terrorista a tutti gli effetti e che, per ragioni che non capivo, visto che di certo non lo avevo mai incoraggiato, aveva deciso che mi avrebbe fatto da mentore in questioni rivoluzionarie). Avevo cercato di stargli lontano dopo la sua lezione sulle molteplici categorie umane che dovevano essere spazzate via per poter ottenere l’ideale società marxista senza classi, ma inciampare l’uno nell’altro di quando in quando sembrava inevitabile.
“Ehi, compagno!” disse.
Ancora quell’appellativo. “Ehi, come stai?” risposi.
“Sto bene – ma sono preoccupato.”
“Oh, no! Per cosa?” chiesi, mostrandomi interessato.
“Può darsi che ci siano dei neofascisti nei gabinetti,” disse indicandoli. “Vai a controllare, compagno, e fammi sapere cos’hai scoperto.”
“Vacci tu,” pensai, ma invece mi sentii dire: “Consideralo fatto,” e all’interno dei gabinetti marciai stoicamente.
Non si muoveva una foglia, e comunque a dire il vero non ce n’erano. I gabinetti erano piuttosto grandi. Mi sarei preso tutto il tempo per ispezionarli. Non avevo paura, ero piuttosto sul riflessivo, forse come risultato della stimolante assemblea alla quale avevo partecipato.
Nei gabinetti c’era puzza di urina e di quell’altra secrezione umana; inoltre, altra cosa prevedibile, non c’era traccia dei fantomatici neofascisti.
Quando uscii, trovai Fletcher esattamente dove lo avevo lasciato. “Allora?” mi chiese, ansiosamente.
“Non c’è nessuno lì dentro,” dissi. “I neo fascisti se la sono squagliata. Che peccato, compagno.”
Mi riservò lo stesso sguardo dell’insegnante compiaciuto dei progressi del suo allievo.
Mentre tornavo a casa, a piedi, poiché i mezzi pubblici erano spesso inutilizzabili per via degli scioperi, fui fermato dalla polizia. Niente d’insolito in questo; succedeva tutti i giorni, a volte anche due volte al giorno.
La polizia e i carabinieri come categoria erano uno strano gruppo. Molti venivano dal mezzogiorno rurale e poverissimo, dove la scelta era fra arruolarsi o morire di fame. Avevano subito un acuto shock culturale mentre, nello stesso tempo, erano già traumatizzati. Esili, bassi, spaventati, confusi, e di solo pochi anni più grandi di noi, o in alcuni casi ragazzi come noi, ci odiavano perché, a differenza di loro, ci stavamo facendo una cultura (insomma, di tanto in tanto); perché non eravamo contadini; e perché parlavamo italiano senza il loro pesante accento, del quale erano diventati acutamente consapevoli, poiché a casa parlavano esclusivamente nel dialetto del loro paese d’origine, e di cui erano ora imbarazzati. Ci percepivano come esseri privilegiati di un altro universo, il che non faceva che fomentare il conflitto di classe e il razzismo. Ad esempio, il termine usato da molti settentrionali per definire i meridionali era terroni, termine tanto offensivo quanto nigger in America; i poliziotti e i carabinieri l’avevano sentito raramente o addirittura mai quando vivevano ancora nel mezzogiorno.
E c’era di più, la cosa più importante di tutte – il sospetto strisciante che dovevano provare di essere dalla parte sbagliata delle barricate: anche loro erano proletari, forse erano i veri proletari ma, durante le dimostrazioni, dovevano sopportare la furia distruttiva di una moltitudine di militanti invasati, e per poche lire.
Nessuna meraviglia, quindi, se la polizia e i carabinieri erano abbattuti e attoniti allo stesso tempo. Non c’era possibilità che potessero contrastare ogni reato, e ciò comportava che la criminalità comune prosperava. E, - ci credereste? – non amavano affatto la gioventù. Si basavano sull’equazione: giovane maschio abile, capelli lunghi, blue jeans = più che sospetto. La cosa arrivava fino a ciò che oggi si chiama “profiling razziale”, un serio passo falso nel decalogo della correttezza politica. A quei tempi la correttezza politica significava che ti avrebbero sparato alle gambe invece che al petto, come gentile avvertimento che t’inducesse a desistere dalle tue attività. Tali attività potevano consistere nell’esprimere il tuo dissenso come professore d’università, investigare alcuni compagni-che-sbagliavano come giudice, o ficcare il naso dove non dovevi come giornalista. Molta di questa gente veniva gambizzata (sparata nelle gambe), mentre altrettanti venivano direttamente ammazzati.
Io, e decine di migliaia di altri ragazzi della mia età, subivamo il profiling razziale giornalmente. Ecco perché la polizia fermava me e la mia criniera ondulata, talvolta puntandomi una mitraglietta, chiedeva la mia carta d’identità, e poi mi faceva aspettare per una mezz’oretta. Inoltravano via radio i miei dati al quartier generale per vedere se ero o meno su qualche loro lista nera. Nel frattempo, mi prendevano in giro nel loro accento pittoresco, e parlavano fra loro in un dialetto per me misterioso, sperando che reagissi in qualche modo. Qualunque cosa avessi detto diversa da “Sì, signore” o “No, signore” avrebbe dato loro un pretesto per arrestarmi e trascinarmi fino alla più vicina stazione di polizia per accertamenti, ovvero ulteriori investigazioni. Ben addestrato dalla Psicopolizia dell’estrema sinistra, tuttavia, riuscivo sempre a rimanere calmo. Alcuni amici e mie conoscenze non erano altrettanto composti e, portati in qualche stazione, sperimentavano la loro parte di brutalità poliziesca, sebbene non avessero fatto alcunché.
Perché non mi tagliavo i capelli? Perché, in quel caso, i militanti dell’estrema sinistra mi avrebbero potuto scambiare per un neo-fascista, e mostrare ancor meno civiltà della polizia. I capelli corti erano un altro passo falso del decalogo. La scelta era fra essere vessato dalla polizia o finire col cranio fracassato. Era più sicuro sembrare un attivista di sinistra.
***
The context: Italy during the Years of Lead in the 1970s.
The situation: After WWII, a truce-camouflaged-as-peace had come into being; Italy had managed to remain within the West, and had become a member of NATO. The Italian Left could not accept this reality, nor could the Soviet Bloc. But the economic boom of the 1950s and of the 60s had thwarted any realistic hope for a Marxist revolution. With the economy worsening in the late 1960s, and then with the oil crisis, the Left, Leftist trade unions, and the extra-parliamentary Left all tried to take advantage of the situation. By dint of picket lines, strikes, ever-more frequent and tumultuous demonstrations, occupied buildings, and all the means at their disposal, a number of Italians, naïve but tough, became persuaded that Italy's destiny was in their hands rather than in those of the two superpowers and their accessory allies. Accordingly, they did all they could to bring about a Marxist revolution. Ultra-Left sympathizers—the radical ones among them, those who threw Molotov cocktails and fired guns during demonstrations—and full-blown terrorists decided to take a shortcut, and engaged in armed struggle, turning the country's major cities into a warzone.
Such convulsions reignited the fuse, and the "strategy of tension" began—with bombs going off presumably exploded by Italian agents (but not necessarily) carrying out the agenda of foreign organizations or stay-away governments. In other words: if no revolution had been so tenaciously and so stubbornly pursued, in all likelihood the Years of Lead would not have happened. Then, with the fall of the Berlin Wall and with the falling apart of the Soviet Union, the elements of friction would have gone missing altogether, as they did.
Logistics of the author: right in the midst of it all as a teenager in Milan's most hazardous high school.
The new academic year could now commence triumphantly, with a strike followed by a general assembly.
The Leonardo da Vinci High School was graced with what is now known as the Congress Hall of the Milan Province, an auditorium that accommodates five hundred and twenty-five guests but then, with skimpier seats, more. It was underground, right beneath the school. Political activists had possessed themselves of it, and turned it into the official great hall for their general assemblies.
I used to skip assemblies whenever circumstances allowed me to, but it was judicious not to skip them all, as we were being watched by the thought police, and a serial-skipper may well be an anythingarian or, worse yet, an apolitical element—faux pas both.
Read more in New English Review:
• The Insidious Bond Between Political Correctness and Intolerance
• The Battling, Baffling Watergate Editor
• Our Irrepressible Conflict
Speakers at the assemblies had taken the Latin maxim repetita iuvant (repeating does good) to heart. They were the leaders or representatives of various ultra-left groups, such as Students’ Movement, Continuous Struggle, The Manifest, Working Class Avant-Garde and others, as well as the Federation of Italian Communist Youth.
The first speaker would express outrage at this and that (usually something very topical, possibly what they interpreted as a fascist or bourgeois provocation), then pledge support to so-and-so, and end with a rousing incitement to all comrades to fight on. After not-so-thunderous applause, the next speaker would express outrage at this and that (the same topic as his predecessor), then pledge support to so-and-so, and end with a rousing incitement to all comrades to fight on. After even-less-thunderous applause, the next speaker would express outrage at this and that (the same topic as his predecessor[s]), then pledge support to so-and-so, and end with a rousing incitement to all comrades to fight on. As there was quite a number of ultra-left groups, each chief representative felt that it was his political duty to speak, so this went on for hours.
From time to time, a loud “Lenin-Stalin-Mao-Ze-dong!” would be interposed (as a wake-up call?); it sounded both ideologically appropriate and rhythmically fetching.
If somebody from outside the ranks expressed a modicum of dissent, he or she was instantly booed, with the microphone being removed from their lips just as quickly. If somebody expressed actual dissent, a far, far rarer occurrence which alone was worth attending the event for its entertainment value, he was beaten unconscious. That was why harmony reigned supreme in the great hall during these marathons of free speech.
As this particular assembly came to an end, I left the hall feeling stiff in the joints and, as if he were waiting for me, I stumbled upon Fletcher (an ultra-left activist who eventually turned into a full-fledged terrorist and who, for reasons I could not understand since I certainly had never encouraged him, had decided that he would be mentoring me in revolutionary matters), I’d been trying to stay away from him after his lecture about the many categories of human beings that needed to be swept away in order to achieve the ideal Marxist classless society, but bumping into each other from time to time seemed unavoidable.
“Hey, comrade!” he said.
That appellation, again. “Hey, how are you?” I replied.
“I’m good—but worried.”
“Oh no! About what?” I asked, looking concerned.
“There may be neo-fascists in the restrooms,” he pointed at them. “Go check them out, comrade, and let me know what you’ve found.”
"You’re quite welcome to go yourself," I thought—but heard myself say, “Consider it done,” and into the restrooms I did march.
Nothing stirred. The restrooms were sizable. I’d take my time to inspect them. I was not afraid, but in a meditative mood, perhaps as a result of the stimulating assembly I had just sat through.
In the restrooms it reeked of urine and of that other human excretion; also predictably, there was no trace of the phantasmal neo-fascists.
As I exited, I found Fletcher exactly where I’d left him. “So?” he asked, anxiously.
“There’s no one in there,” I said. “The neo-fascists got away. Too bad, comrade.”
He looked at me like a teacher pleased with his pupil’s progress.
On my way home on foot, as public transportation was so often unavailable due to strikes, I was stopped by the police. Nothing unusual in that; it happened every day, sometimes twice within the same day.
The police and carabinieri as a category were a funky lot. Most of them came from the rural and impoverished south, where their choice had been between enlisting and starving. They were undergoing acute culture shock while at the same time they were already shell-shocked. Skinny, short, frightened, in a daze and only a few years older than we were, or in some cases teenagers like us, they hated us because, unlike them, we were getting an education (well, on and off); because we were not peasants; and because we spoke Italian without their heavy accent, of which they had become acutely aware, since at home they spoke almost exclusively in the dialect from their town of origin, and by which they were embarrassed. They perceived us as privileged beings from another universe, which only fomented class conflict, and racism. For example, the word used by many northerners to call southern Italians was terroni, as offensive as the N-word in America; policemen and carabinieri had never heard it as much, or even at all when they were still living in the south.
And there was something else, which topped it all—the sneaking suspicion they must have felt that they were on the wrong side of the barricade: they too were proletarians, in fact they probably were the real proletarians but, during demonstrations, they had to endure the destructive wrath of a multitude of possessed militants, and for a pittance.
No wonder, then, if the police and carabinieri were overwhelmed and stupefied alike. There was no way that they could address every violation, which entailed that ordinary criminality thrived. And—wouldn’t you know it?—they didn’t like young people one bit. They went by the equation: young, able-bodied male, long hair, blue jeans = more than a suspect. That amounted to what today is called racial profiling, a very serious faux pas in the scale of political correctness. Back then political correctness meant that you’d be shot in the legs rather than in the chest as a polite warning to desist from your activities. Such activities could be voicing your dissent as a university professor, investigating some comrades-who-make-mistakes as a judge, or sticking your nose where it didn’t belong as a journalist. Many such people were gambizzati (“legged”, shot in the legs), while as many were killed outright.
Read more in New English Review:
• Skewed Projection in a Broken Mirror
• The Revolution of Evolution
• Days and Work (Part One)
I, and tens of thousands of other kids my age, experienced profiling on a daily basis. That was why the police stopped me and my mane of wavy hair, sometimes at gunpoint, asked for my ID, and then made me wait for about half an hour. They’d radio in my data to headquarters, and see whether or not I was on some black list of theirs. In the meantime, they would mock me in their colorful accents, and speak in dialect among themselves, which I couldn’t understand, hoping for some reaction from me. Anything I’d say other than “Yes, Sir,” or “No, Sir,” would prompt them to arrest me and whisk me to the nearest police station for accertamenti, further investigations. Well-schooled by the ultra-left thought police, however, I always managed to keep calm. Some friends and acquaintances of mine were not as collected and, taken to some station, they experienced their share of police brutality although they had done nothing.
Why didn’t I cut my hair short? In that case, ultra-left militants might have mistaken me for a neo-fascist and they would have shown less civility than the police. Short hair was yet another faux pas from the decalogue. The option was between being harassed by the police or ending up with a crushed skull. It was safer to look like a left-leaning activist.
Miss Inoculo II

Miss Inoculo, splendore della notte. Mi sposti e rimesti come un relitto nell'oceano.
Mi sciacqui e lavi di desideri e ricordi. Mi spezzi a poppa e a prua. Ghermisci le mie vele e le soffi verso il sole. Vuoi forse vedermi bruciare? Tessi nuvole di zucchero filato in cielo, e lo dipingi terso e incontaminato. Come l'ho immaginato. Com'era in un tempo lontano privo di turbamenti. Ora le menti si turbano. Ora son turbe di pensieri oscuri, invocati da un mondo di tenebra. Ora son turbolente nubi di procelle scagliate contro i galeoni della bellezza.
Leggeva la corrispondenza, la posta dei suoi ammiratori, ammaliati dal suo viso, dai suoi riccioli, dalle sue fossette. Dalle sue squame.
Miss Inoculo, quando sono nel reparto ortofrutta, penso sempre a te.
Alcuni forse più dal suo corpo.
Era in viaggio verso la prossima destinazione, nel suo tour promozionale per la CSK, e la sensibilizzazione verso la Inoculazione, nonché la promozione della Inoculazione contro la Inoculazione.
Miss Inoculo, vorrei inocularti tutto il mio siero.
Tutti volevano pezzi di lei, o la volevano a pezzi, come il direttore della CSK, Porchinstein.
L'aveva fatta eleggere solo per quello. Per averla. La votazione del pubblico era solo una farsa.
Lei aveva fatto intendere che dopo l'incoronazione si sarebbe concessa. Era un bluff.
Voleva solo raggiungere il suo obiettivo. Ora avrebbe dovuto affrontarlo.
Le lettere che riceveva dagli ammiratori variavano da manifestazioni rigurgitanti di lussuria, a passionali dichiarazioni, da ridondanti espressioni romantiche che nascondevano meri impulsi primari, a goffaggini sgrammaticate a malapena comprensibili. Poi c'erano i visionari e i disperati, e i disperati visionari: per cui era uno schermo su cui proiettare le loro fantasie di salvezza.
L'alba sorge con lo schiudersi delle tue palpebre, nel sole dei tuoi occhi.
Costui probabilmente scriveva dalla galassia di Tattoine, se non era stata definitivamente detonata dall'Impero del Male. O da quello del Bene.
So che se ti incontrassi, la disperazione si dissiperebbe come nebbia, e potrei trovare la forza di vivere. Questo è il potere che hai su di me. Per favore, usalo bene. Rispondimi, e uno spiraglio fenderà la mia notte. Sei la mia unica speranza. Giacché percepisco la tua purezza. Giugno è il mese preferito del tuo calendario. Cordiali saluti.
Ad ogni modo, sperava fosse sito in una galassia davvero lontana lontana. Nella gamma delle specie che l'assediavano, questo esempio si poneva all'estremo opposto di Porchenstein. Se per quest'ultimo lei era solo un pezzo di carne, o di pesce, da consumare e su cui sfogare le proprie pulsioni bestiali, per l'Uomo di Tattoine o Simili, lei era un essere etereo, intoccabile, ma dotato di tutte le virtù metafisiche in grado di sciogliere quel nodo che gli legava la testa e stringeva la psiche in qualche morsa incomprensibile. Le facevano entrambi paura, in modo diverso. Porchinstein anche un po' schifo, in effetti. L'Uomo di Tattoine pena. Ma entrambi costituivano un assedio. Il secondo, con l'attribuzione taumaturgica, l'affardellava di una responsabilità che non poteva essere sua, e che non poteva essere vera. Lei, forse, poteva sembrare una creatura speciale, in virtù della grazia irradiata dal proprio aspetto, ma era solo una normale, ordinaria sirena. E aveva una missione da cui non poteva essere distratta.
Continua...
"Parlami di te"

Parlami di te
Hervé Mimran, 2018
Brutta commedia pasticciata questa di Hervé Mimran, che spreca il buon Fabrice Luchini per raccontare non si sa bene cosa, pare la vera storia di Christian Streiff, ex CEO di Airbus e del gruppo PSA, il quale ha scritto un libro che è, come riporta Wikipedia, “un’autobiografia nel quale racconta la sua malattia e la lenta convalescenza”. LENTA. Perché riprendersi da due ictus susseguitisi in una manciata di ore senza soccorso medico richiede tempo, non certo il mesetto scarso mostrato nel film, in cui il protagonista, afflitto da afasia fluente a seguito della patologia (significa che produce frasi con ritmo e intonazione nella norma ma composte da parole disconnesse tra loro per significato e sintassi rendendo il discorso poco o non comprensibile), liquida la sua convalescenza con un paio di sketch basati su giochi di parole tradotti anche decentemente in italiano e poi, sulle sue gambe, torna a casa. E si limitasse a questo, potremmo anche accettarlo. La sospensione dell’incredulità decide di suicidarsi quando, sempre nel giro di pochissime settimane, con l’aiuto di un’ortofonista, sceglie di partecipare a un importante salone espositivo enunciando il suo discorso da CEO con grande successo. Partono gli applausi, le congratulazioni, le pacche sulle spalle e un bel licenziamento in tronco comunicato anche con fastidio perché le multinazionali sono tutte fatte da persone cattive e insensibili contro i disabili volenterosi. E poi è il karma, no? Dall’inizio mostravano Luchini come un animale da profitto e sfruttamento, che a malapena si occupava della figlia nonostante una moglie morta atrocemente, di cui conservano ancora il letto di morte come un mausoleo (anche questo, come si dirà in seguito, intuito da un’inquadratura mostrata un attimo senza un commento, un’interazione tra gli attori, una spiegazione, nulla), scontroso con tutti, che non dice mai grazie. E allora tiè, così impari. Francamente tra i manager e il regista non saprei dire chi è il più cinico. In tutto ciò Mimran pensa bene di buttare a casaccio la storia dell’ortofonista che ricerca la sua madre biologica, la sua storia d’amore con l’infermiere a metà tra il simpaticone e il ritardo mentale lieve e, ovviamente, di lasciarle mezzo in sospeso, con intermezzi di pochi minuti che dovrebbero farci intuire epiloghi scialbi e muti, senza un briciolo di introspezione psicologica, insoddisfacenti e francamente inutili nel contesto. L’ultimo terzo del film è semplicemente insopportabile per i dialoghi, lo sviluppo della trama, il mutare dei rapporti tra i protagonisti, indegni anche di una sceneggiatura di un cartone per bambini della materna. Il film, quindi, che in una scena pensa bene di strizzare l’occhio a Quasi amici rendendo ancora più evidente l’abisso tra i due film, sempre che ce ne fosse bisogno, è una banalizzazione quasi offensiva del percorso di riabilitazione psicologica e fisica di chiunque abbia subito un grave sconvolgimento della propria esistenza per motivi di salute. Nemmeno oso un accostamento con Lo scafandro e la farfalla, perché andrei nel penale. Comunque, alla fine il protagonista impara a dire “grazie”. Non lo avreste mai immaginato, eh?
La Madre

La Madre, liberatasi dal Dottor della Morte e finito il pasto, si ritirò in camera, per il riposo pomeridiano. Un'altra giornata di lavoro era finita. Ora, per qualche ora, era libera.
Libera di fare la lavatrice, stendere, stirare, spazzare, andare a trovare i parenti malati e preparare la cena. Queste erano le sue ore ricreative. Suo figlio non era particolarmente utile, in casa. E nemmeno fuori. A volte si rendeva conto che non l'aveva particolarmente svezzato: e con le sue costanti premure, attenzioni e preoccupazioni non l'aveva nemmeno particolarmente spinto ad autonomizzarsi. Ma era più forte di lei. Il suo istinto materno prendeva il sopravvento, unitamente ad un indefinito senso di colpa, che la induceva a una compensazione nel prendersi cura di lui.
Il suo affetto superava la delusione di avere un simile figlio. Anche questo sentimento di delusione, che percepiva come indegno di una madre, rinforzava il suo senso di colpa. Una madre doveva comprendere la debolezza o la stranezza di un figlio, se quella era la sua natura. Le potenzialità inespresse, non concretizzate, non applicate di cui era portatore, da una parte la consolavano, dall'altra rendevano la situazione ancora più amara: quel che sarebbe potuto diventare, e non era! Un cittadino rispettabile, una persona attiva e indipendente – queste ardite vette sognava, o aveva sognato, per lui. E invece al mondo non poteva che offrire questo figlio ripiegato su stesso.
E un po' se ne vergognava. Per poi vergognarsi della propria vergogna. Aveva così tante qualità!
Da qualche parte, dentro di lui. Frugando. Certamente c'erano.
Come sarebbe vissuto senza di lei? Perché quel figlio non prendeva atto dell'angoscia che provocava con la sua inconcludenza e non reagiva per risolverla? Non era giusto che anche di lei ci si prendesse cura? Ma non accadeva.
Era stata una ribelle, in gioventù, in relazione al suo contesto: la qual cosa significa che non aveva dovuto sforzarsi molto per esserlo, data la natura religiosa, pia e bigotta del suo ambiente originario.
Difatti, non le era in seguito costato molto tornare indietro e adeguarsi alla figura della donna tradizionale che dona tutta se stessa alla famiglia, impavida e ineluttabile, nonostante tutte le delusioni, le mancanze, le frustrazioni. Nonostante tutto, quella matrice le era dentro.
Lei era come un organismo estremofilo, una tardigrada, un orso delle acque, in grado di resistere dieci anni senza bere, in grado di resistere al freddo estremo: la qual cosa era provvidenziale, perché il calore dell'affetto non sembrava qualcosa che i suoi familiari erano in grado di fornirle, darle, portarle, consegnarle, regalarle.
E ora era sparito anche suo marito.
Continua...
Jonathan Coe, "La pioggia prima che cada"

Il dottore della Morte

Un'altra giornata. Addensata di plumbeo. La finestra irradiava solo grigio.
Sembrava di vivere sotto strati di sporco, polvere, smog e pioggia nera coagulata.
Si liberò in qualche modo, e suo malgrado, dai tentacoli del sonno, ed emerse dal piacevole bacino dell'oblìo.
Preparò il pranzo per sua madre. Ella tornò a pomeriggio inoltrato. Aveva ormai perso conto dei suoi anni, probabilmente volontariamente. Secondo leggi ormai antiche, e altrettanto incrostate di sporco, polvere, smog e pioggia nera, sarebbe dovuta essere in pensione da lustri. Ma non funzionava più così. Si poteva andare in pensione solo un paio di anni dopo il decesso. Difatti, attualmente i contributi si pagavano anche dalla tomba, attraverso la propria decomposizione.
Utilizzavano l'energia liberata dal processo di dissolvimento, con essa si alimentavano gli uffici pubblici, i palazzi governativi, e il sovrappiù era venduto dallo stato sul mercato libero dell'energia. Il ricavato e il risparmiato andavano, forse, a mitigare il debito pubblico, e di certo nella compravendita d'armi e negli appalti gonfiati di milioni. Il cittadino doveva donare se stesso alla comunità, e doveva farlo con generosità e partecipazione – anche da morto. In effetti, lo stato era diventato così zelante nel procurarsi nuovi cadaveri da drenare, che tendeva a seppellirli persino prima del tempo: era conveniente.
Ecco perché alcune famiglie facevano installare telecamere e strumenti di comunicazione nelle bare, nel caso si scoprisse che in realtà il caro defunto fosse ancora vivo. A loro era capitato.
Videro una prozia muoversi attraverso lo schermo sulla lapide. La tirarono fuori e le diedero un tè.
Madre stava consumando il suo pasto, quando suonò il campanello. Coincidentalmente, era il Dottore della Morte. Ogni tanto passava.
«Come si sente oggi, signora?»
«Meglio di quel che lei spera, immagino»
«Orsù, faccio solo il mio lavoro, signora, non la prenda sul personale. È sicura di essere ancora viva?»
«Proprio sicura no – dato che per certo sono stanca morta. Ma nel dubbio rimanderei la sepoltura»
«Ci pensi bene, sono arrivate delle nuove bare che sono uno splendore, gliel'assicuro, e siamo in periodo di saldi»
«Sembra allettante»
«Può dirlo forte. Ne ho fatta provare una alla signora del piano di sopra e ne è rimasta entusiasta»
«Capisco. Mi lasci il catalogo.»
Voleva intervenire per confermare che sua madre non era ancora morta, ma era troppo timido e titubante. Inoltre, sapeva bene che il Dottore della Morte gli avrebbe risposto che quella del cadavere parlante era una sindrome certificata dall'Organizzazione Galattica della Sanità, e quindi non provava niente. Ora le auscultava il battito con lo stetoscopio elettronico.
«Io non sento niente»
«Faccia provare a me» disse Madre, prendendogli gli auricolari.
«Non sento niente nemmeno io. Devo proprio essere morta»
Lui si fece finalmente avanti e premette un pulsante sullo strumento.
«Prova ora, madre»
«Oh. Ora va meglio. Mi sento. Un vero sollievo. Per un attimo avevo davvero creduto di essere morta.»
«Bel tentativo, dottore» disse lui rivolgendosi al medico, superando con difficoltà la propria introversione.
«Oh, che sbadato» rispose il Dottore della Morte con una risatina un po' imbarazzata.
Ma non troppo.
Continua...
Lorenzo Barbieri, "Rione Sanità"

Rione Sanità
Lorenzo Barbieri
LFA Publisher, 2018
pp 167
16,00
Leggendo Rione Sanità, di Lorenzo Barbieri, mi è venuto naturale ricordare una visita fatta al quartiere insieme alla mia amica napoletana, scrittrice di talento, Ida Verrei, e anche ricollegare questo testo (si badi bene, solo per contenuto e non per stile, essendo quello della Verrei di molto superiore) al suo Arassusia, ambientato nei medesimi luoghi e nel famoso Cimitero delle Fontanelle.
Come il suo protagonista, anche l’autore non abita più a Napoli, ma da ragazzo ha vissuto addirittura dentro il Palazzo Reale, dove ha sede la biblioteca Nazionale. La Napoli di cui parla non è quella di Saviano, delle stese e della paranza dei bambini, non è quella anonima e fredda de L’amica geniale, ma è quella calda, pastosa e sanguigna della grande tradizione partenopea, di Totò, Eduardo, (e anche Ida Verrei).
La città è misteriosa, sotterranea, superstiziosa, legata al senso della morte. Il rione vive di luci e ombre, fatto di vicoli ripidi, di porte che sprofondano direttamente nell’Ade, fra catacombe e teschi. Contiene fatiscenti palazzi settecenteschi, nobili chiese ma anche bassi poveri e bui dove vive gente misera e dura.
“I vicoli sono poesia, fetore, umore di vita, giochi di ombre e raggi di sole, desideri, speranze, rumori, nostalgie e sogni in attesa di realizzarsi.” (Pag. 92)
Il protagonista, Enzo, è un anziano giornalista che rientra a Napoli dopo una lunga assenza, e lo fa solo per seppellire in fretta la madre, con l’intento di tornarsene prima possibile al suo lavoro milanese. Percorre strade, piazze, vicoli insieme al notaio Oreste, sorta di guida dantesca.
In realtà la città lo ri-cattura, l’antico rione, in cui è vissuto da bambino, lo riacciuffa col suo fascino, col gusto dolceamaro della nostalgia. Da una parte egli mantiene lo sguardo distanziato di chi ormai non fa più parte di quel mondo, dall’altra si abbandona alla memoria, ripopolando ciò che vede con figure scaturite dal passato.
A parte le consuete imprecisioni di Barbieri nell’uso della punteggiatura e dei tempi, e la sua scrittura un po’ distratta, il difetto maggiore sta nell’aver voluto, credo, inserire nel romanzo alcuni racconti precedentemente scritti, non riuscendo ad amalgamarli come si deve nella trama. Il pregio, invece, è l’aver puntato un faro sul Rione Sanità, mostrandocelo com’è ora e com’era un tempo, in una narrazione sempre in bilico fra visione attuale, riscoperta e ricordo, come se il tessuto della realtà presentasse dei vuoti che solo la memoria può riempire, ricomponendo il mosaico.
Ma sul finale del libro c’è un ribaltamento, si esce repentinamente dal sogno con una doccia gelata e la realtà ha il sopravvento sulla deformazione consolante del ricordo. Le persone che sembravano genuine, vergini, povere ma innocenti, si rivelano grette, interessate, persino truffaldine, a conferma che nessuno fa niente per niente.
“È vero, il napoletano è uno di buon cuore, disponibile e altruista, ma sotto, sotto, ci deve sempre ricavare qualcosa, è nel suo Dna, non lo fa per cattiveria.” (Pag. 135)
Non solo, il malaffare prospera e la filosofia generale, l’unica possibile, è “far finta di niente e tirare a campare”. Ne esce, perciò, un ritratto della napoletanità a chiaroscuro, una specie di odio e amore, disprezzo e meraviglia, curiosità e ribrezzo. La parte migliore del romanzo è quella iniziale, quando, suo malgrado, il protagonista subisce il fascino del quartiere e riscopre le figure che anticamente lo avevano animato.
Poi, purtroppo, c’è un crescendo di delusione, di meschinità e spilorceria, di fatalismo e rassegnazione che ci lasciano con la bocca amara e coinvolgono lo stesso protagonista il quale, alla fine, non ci sembra poi tanto migliore dei personaggi da lui incontrati.
Il gigante di smeraldo e La Storia di Pyotr Arlanovich

Il Gigante di Smeraldo
Lentamente, gocce dalle vaste foglie tropicali convergevano.
Gradualmente, una forma da esse nutrita cresceva
- il gigante di smeraldo.
La Storia di Pyotr Arlanovich.
Nacque nella casa colonica dei nonni materni, nella stanza in cui si diceva avesse per una notte riposato il principe di Metis, sceso in Stivalonia per guidare le truppe gioviane sull'Altopiano delle Sette Supernova, durante la prima Guerra Astrale.
Visse qualche mese lì, poi un anno e mezzo nella casa dei nonni paterni. In seguito si trasferirono nella cittadina di Sciame d'Asteroidi, in via Matilda Maggio.
Era appassionato di allevamento di girini, a causa del quale il suo cane si suicidò gettandosi sotto ad una macchina, sentendosi trascurato.
Sviluppò un interesse per la scienza e per il conflitto con l'autorità paterna, che aveva cromosomi Imperialisti maligni nel sangue. A scuola era distratto, a parte momentanei sprazzi di lucidità in cui stupiva qualche insegnante con intuizioni risolutive sfuggite al docente stesso. Era anche esperto nell'infrangere sogni altrui, come dimostrò durante il Caso dei Triangoli d'Oro, in cui il club di giovani scienziati locali aveva stabilito che, per un mistero insondabile, sommando quattro particolari triangoli rettangoli per formare un parallelogrammo, si otteneva un'area maggiorata tale che stavano cominciando a sfregarsi le mani pensando di applicare il trucco a materiale aureo – ma lui dimostrò loro l'amara fallacia dei loro calcoli. O forse era unendo due triangoli e due trapezi. Ad ogni modo, non importa.
In età adulta la sua maggiore ambizione era subire un incidente sul lavoro, cosa verso cui si adoperava in tutti i modi, in ciò molto aiutato dagli incarichi commissionati dalla fabbrica che l'aveva assunto, la Cometh, sita a Sanobiwan, e dall'ambiente di lavoro da essa fornitogli.
Alcune notevoli esperienze furono: strisciare immerso in polvere di ferro lungo una trave sospesa a diversi metri dal pavimento, con fili scoperti fulminanti mezzo metro sopra di lui.
Poi c'erano vasche alte un metro, piene di acido, e lui e il suo compare dovevano tirare fili sopra di esse, appendendosi e appigliandosi ovunque possibile. Il mestiere era il suo pericolo.
In un'altra occasione lo misero per così dire in castigo per aver partecipato ad una vertenza sindacale. Per un periodo fu incaricato di fare i raggi X a delle tubature, come forma di controllo qualità, e per evitare le radiazioni dovevano attivare il macchinario e poi spostarsi celermente nella gabbia di piombo a ripararsi, con un contatore Geiger per controllare i livelli di radioattività. Poi sarebbe dovuto andare a lavorare nella nuova sede, la Second Cometh, appena costruita, ma si licenziò prima che accadesse. Poco prima avevano assunto un nuovo elettricista, per sostituire un altro sottrattosi allo sterminio, o forse a sua volta caduto e scioltosi in una vasca d'acido, e insieme lasciarono il lavoro e formarono una società. Ma non prima di aver passato una settimana in ospedale in seguito a un incidente - uno scoppio in faccia lavorando sulla linea, una pinza che si stava fondendo, diventando incandescente, a causa di un inappropriato contatto tra fasi. Il bagliore fu talmente forte che non vedeva più niente, e rimase accecato per un paio di giorni.
Gli infortuni erano pressoché quotidiani.
In una occasione morirono tre operai in un solo giorno, alla Happy Factory.
Pyotr, inoltre, preparò l'impianto elettrico per la sede dell'Istituto Sottocromosomico della Città di Ciubecca, con momenti di grande acrobazia circense, sospeso fuori dal quinto piano su una tavola appoggiata in un angolo tra un paio di davanzali perpendicolari.
Diventò quindi un Condivisionista Universale. Il proletariato galattico doveva ribellarsi all'oppressione della borghesia interstellare, quando i tempi sarebbero stati maturi e sarebbero caduti come frutti dall'albero della storia. Così aveva predetto il profeta scienziato Karl Mars, dal pianeta rosso.
Svariati anni dopo, il giorno prima che venisse spiaccicato qualche manifestante all'infame e infausto Summit del Grand Guignol 8, convegno tra i presidenti dei pianeti del sistema solare, cadde in bicicletta e traumatizzò le proprie chiapposità.
Si gonfiarono eminentemente. Fece cinque sedute in ospedale per drenare via il siero, il liquido che s'era formato tumefacendolo posteriormente. Nella sua mente, il personale ospedaliero pensava lui fosse un reduce del Grand Guignol 8, che, tornato a casa dopo il pestaggio, non si era recato nell'ospedale della città del vertice, per non essere piantonato dalle forze dell'ordine, le quali peraltro avrebbero senz'altro pensato, data la sua novella voluminosità, stesse nascondendo qualcosa nel didietro – una spranga quantistica, una catapulta molecolare, un fucile laser. Ma stiamo forse divagando con un aneddoto non particolarmente fondamentale.
Circondato da questo vociferare, nella fabbrica dove lavorava fu licenziato a causa di uno sciopero che gli avevano imputato, e lui se ne andò. Salvo poi ricordarsi, qualche tempo dopo, che in effetti non aveva organizzato alcuno sciopero - ma era timido e non aveva voglia di farlo presente alla direzione. Diventò quindi un Eroe della Classe Proletaria, nomina per la quale non gli veniva però corrisposto alcuno stipendio – la qual cosa non era molto auspicabile. Divenne dunque un artigiano elettronico iscritto regolarmente all'Associazione, cosa che gli drenava un po' tutto in tasse – la qual cosa non era molto anelabile.
Di conseguenza, s'inabissò nelle turpi profondità del lavoro grigiastro, per quanto fosse pseudo-illegale, e non fosse molto consigliabile. Era un vero criminale.
Ma ciò non era abbastanza sedizioso. Il suo progetto era demolire l'Impero. Il suo scopo era soppiantarlo e instaurare un governo Condivisionista – l'ideologia osteggiata a cui si attribuivano miliardi di miliardi di vittime, che si paragonava all'Impero del Male, e che altri, invece, vedevano come l'unica soluzione dall'oppressione di tutti gli imperi.
Continua...
Fabio Izzo, "Consigli dalla punk caverna"

Quel fenomeno di Fabio Izzo
Consigli dalla punk caverna
Terra d'Ulivi, 2019
Fabio Izzo è uno dei tanti autori che posso vantarmi di aver scoperto in vent’anni di attività editoriale. Non ha avuto ancora la possibilità di uscire con un grande (grosso?) editore distribuito su vasta scala, è tra gli scrittori che mi rende più orgoglioso e che ben rappresenta il poco che ho cercato di fare in questi anni. Fabio Izzo è nato nel 1977, vive ad Acqui Terme, scrive da tempo immemore, ché il suo primo libro - Eco a perdere - lo pubblicammo quando ancora Il Foglio Letterario stampava i libri artigianalmente, in fotocopia. Ricordo di aver fatto il lavoro di editing personalmente, con carta e penna, ai giardini vicino casa mia, vista mare, mentre facevo giocare mio figlio al parco. Poi ne sono venuti altri: Balla Juary, Il nucleo (straziante e stupendo), Doppio umano, soprattutto To Jest, presentato al Premio Strega (2014), niente meno che da Pedrag Matvejevic, ovviamente ignorato dal Comitato Direttivo, a caccia dello Scurati o del D’Amicis di turno. Non dimentico Ieri, Eilen, storia d’amore non convenzionale degna di selezione presso il Club di Giulietta per il concorso Scrivere per amore 2017. In mezzo a tutto questo Fabio ha pubblicato libri con altri editori, ha affinato lo stile, ha tradotto poesia polacca, ha vinto premi più o meni importanti, infine è uscito con l’ultimo romanzo: Consigli dalla punk caverna: A noi punk non ci resta che Al Bano (Terra d’Ulivi Edizioni, pag. 140, euro 14). Il tema di fondo dello scrittore piemontese - con sangue meridionale - non cambia, a parte l’ambientazione salentina, ché alla base c’è sempre il male di vivere, l’insoddisfazione di far parte di una terra di sconfitti, popolata da giovani in fuga o che si adattano con due lauree a fare le notti per dieci euro al distributore. Il romanzo è una storia d’amore alla Izzo, tipica del suo stile, una storia di disamore, di uomini lasciati soli da una stronza a caccia di successo e in cerca di un’occasione migliore. Incipit straordinario: “L’amore è una bufala, nemmeno buono per la mozzarella della pizza. L’amore eterno è una bufala cosmica. Si tratta solamente di scegliere, come in pizzeria”. E quel che ne consegue è un’ode al disamore, dissacrante e ironica, sarcastica, vibrante, contro la donna perduta, contro quel tipo di donna che non si dovrebbe mai incontrare. Il personaggio principale è un punk coltissimo (chi ha detto che i punk sono ignoranti? afferma Izzo), persino raffinato, sincero, come ogni vero punk dovrebbe essere, che sogna il perduto amore mentre vive di eccessi alcolici e musicali contemporanei. Stile molto diretto ed essenziale, per niente letterario, nel senso stretto del termine, classico romanzo in prima persona che consente un’immedesimazione totale tra lettore e autore. Io ve lo consiglio, poi fate un po’ voi, per me potete anche andarvi a leggere l’ultimo inutile saggio travestito da romanzo di Antonio Scurati.
Grumpama
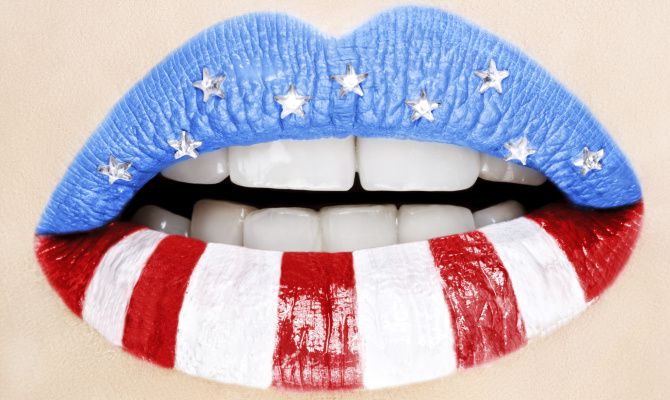
Grumpama regnava sulla galassia.
Grumpama era diviso in due. Era un organismo con due facce, o con una faccia divisa in due, ma un unico cervello. Aveva un vestito a strisce rosse e blu, cosparso di hamburger d'oro. Era il presidente di Hamburgerlandia, a capo della Federazione dei Super Stati – dominatrice dell'Impero. La faccia destra era Grump, la faccia sinistra era Bombama. La faccia destra era cattiva, la faccia sinistra era buona. La faccia destra era conservatrice e tradizionalista, chiusa, proiettava uno sguardo arcigno. La faccia sinistra era progressista, liberale, aperta, indossava un sorriso accogliente. Si rivolgevano a due tipi di target diversi del mercato elettorale. Che venisse votato uno, o venisse votato l'altro, veniva sempre eletto lo stesso organismo, rappresentato da una faccia differente. Per quanto i nomi cambiassero, i finanziatori complessivamente coincidevano – e così i loro scopi.
Tra il buono e il cattivo, la principale divergenza era l'utilizzo del vocabolario, dell'arte oratoria, della grammatica. L'apparenza della decenza contro un crudo analfabetismo dal capello posticcio. Il secondo veniva accusato di razzismo, ma il primo aveva deportato duecento milioni di immigrati. Il secondo veniva considerato pericoloso, ma il primo aveva bombardato sette pianeti. Nel mettere in rilievo o nel sottocomunicare, i media interplanetari contribuivano a creare i loro personaggi.
Il buono e il cattivo. Il multiculturalista e il nazionalista.
Bushinton. Clintush. Bushama. Grumpama. Non faceva differenza.
Le politiche imperiali andavano avanti.
A sorpresa, era stato eletto Grump. La sua campagna, tra le altre cose, s'era basata sulla promessa di riduzione dello sforzo di conquista e distruzione, un tempo tema dei Democratici, sul risparmio a favore delle classi basse e della nazione, nonché sul descalare la tensione con la NovoVodka, un orso che aveva rialzato il muso dopo un lungo letargo, riconquistando la facoltà di ringhiare.
Aveva ringhiato, e stava ringhiando, contro l'avido approcciarsi del SuperHamburger e dei suoi SuperAmici, con il pretesto di abbattere un dittatore, su un pianeta nel sistema di Sirio, dove l'orso, a Tortosa, possedeva una base astronavale. Le fameliche mire erano state pressoché neutralizzate, con crescente accigliamento hamburgerstrisciato.
In precedenza, lo stato di Kievania aveva visto il proprio malcontento popolare sfruttato dalle forze della Lega per destituire il capo di governo filovodko, a cui era stato sostituito un pupazzo più consono alle politiche filoterrestri. Vittoria Nulla, assistente segretaria di stato superhamburgheriana, distribuiva biscottoni ai ribelli, inducendoli in tentazione, in ossequio all'ormai noto motto : “come to the Dark Side, we have cookies”. La penisola Taurica volle distaccarsi dalla Kievania e tornare verso la NovoVodka, a cui era etnicamente e culturalmente più affine. La NovoVodka difese la sua scelta. La Lega dei SuperStati stava sperimentando con fastidio diversi bastoni infilati tra le sue ruote dallo stesso dispettoso orso. Ma reagì. E con una serie di sanzioni fatali la spinse oltre i bordi della terra, inducendola a traslocare su Marte, insieme ad una quantità di altre nazioni poco gradite.
Ecco uno dei motivi per cui l'atteggiamento conciliante di Grump verso il rinnovato nemico sembrava scandaloso. Fu presto definito un tentativo di tradimento. La situazione non tardò ad estremizzarsi: ora la NovoVodka era accusata di ingerire nel processo democratico superhamburgheriano per favorire il candidato biondo posticcio, a sua volta imputato dai Paladini Democratici, insieme al suo entourage, di colludere e ricambiare segretamente.
La sua avversaria elettorale era Millie Tary Klingon. Una sorta di sociopatica afflitta da sporadici quanto inquietanti spasmi rivelatori che affioravano come una maschera contorta sul volto esasperato da espressioni eccessive, ghignanti, inquietanti. Durante un'intervista aveva riso istericamente parlando di un dittatore sodomizzato a morte con una spada laser dopo l'intervento imperiale – ferventemente favorito da lei, nel ruolo di Segretaria di Stato, presso la presidenza galattica di Bombama. Lì, proprio come in Uruk, la popolazione viveva meglio prima di essere salvata: persino un dittatore era preferibile alle liberazioni alla Terrestre, fondate su raggi al fosforo bianco, distruzione e caos. Nondimeno era considerata una Buona Democratica, perché rispettava i diritti di gay, donne, e minoranze - a parte, ovviamente, quelli dei gay, delle donne e delle minoranze che bombardava in altri pianeti.
Erano tutti certi venisse eletta. Rimasero di stucco quando non accadde. Crebbe il panico quando fu eletto il Cattivo Grump, che sembrava non voler andare più in guerra, ma che non rispettava i diritti di gay, donne e minoranze – a parte, ovviamente, di quelli che non avrebbe bombardato.
Si diffuse un'isteria tragicomica, un incendio su cui soffiavano i media, in maggioranza appartenenti all'area liberale. Il fascismo era arrivato. Si parlava di un aumento abnorme di casi di bullismo e violenza sui diversi. Ora i verdognoli sarebbero stati fucilati per le strade da poliziotti militarizzati. Ma, a ben pensarci, stava già accadendo da anni persino sotto Bombama, che, com'era noto ai più, era il primo presidente verdognolo. Il caso più menzionato riguardava una ragazza plutoniana che, in un campus, aveva subito l'assalto al proprio coprichele religioso, che le era stato strappato via, tra minacce e insulti. Qualche settimana dopo era indagata per falso e procurato allarme. Non era mai accaduto.
La cosa veramente tragica si verificò nei mesi seguenti: Grump – come previsto da molti – cominciò a rimangiarsi le promesse di cambiamento in politica estera. La tensione con la NovoVodka riprese. Ora spingeva per un'ulteriore militarizzazione, minacciava la NeoPersia, la Seul del Nord e chiunque gli capitasse a tiro, nei corridoi, nei bagni e per strada. Chiunque a parte la ASS, l'Agenzia Spionistica SuperHamburgheriana, principale fabbricatrice di pretesti per entrare in guerra – contro cui si era scagliato fino a dieci minuti prima di essere eletto. Una volta eletto andò da loro e disse: «Nessuno vi sosterrà quanto me. Vi sosterrò così tanto che finirete per implorarmi di smetterla di sostenervi».
Del resto, era solo l'altra faccia di Grumpama.
L'Impero continuava ancora.
Continua...

/image%2F0394939%2F20190531%2Fob_6113d1_61425960-10216728261030327-19684367693.jpg)


