Islanda, Finlandia e i miti cari a Tolkien
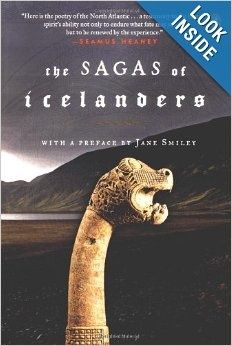
Thingvellir: alle spalle il contrafforte di basalto nero, davanti l’immenso prato ricoperto di lichene dove si svolgeva l’Althing, il parlamento a cielo aperto degli islandesi. Nell’aria fredda e odorosa di zolfo, in questa terra di lava color asfalto, fra dune di pomice e sbuffi di geyser, necessita compiere una classificazione di ricordi e associazioni mentali che ci si affastellano confusi nella testa.
Cominciamo con l’Edda.
Il termine Edda, al plurale Eddur, si riferisce a due testi in norreno entrambi scritti in Islanda durante il XIII secolo. L’Edda poetica, o Edda antica, e l’Edda in prosa, quella di Snorri.
L’Edda antica trae origine dal Codex Regius, manoscritto composto nel XIII secolo, di cui si sono perse le tracce fino al 1643. La parte iniziale è la nota Völuspa, la profezia della veggente, fonte preziosa di conoscenza della mitologia e della cosmogonia norrena. La veggente parla con Odino e gli narra della creazione del mondo e del Ragnarök, il suo catastrofico destino. All’interno della Völuspa sei stanze sono dedicate a un elenco di nomi di nani, da cui Tolkien ha attinto a piene mani per la sua trilogia. Nel 2009 la Harper e Collins ha pubblicato un lavoro postumo di Tolkien sull’Edda poetica, intitolato “La leggenda di Sigurd e Gudrun”, in un inglese che cerca di riproporre il metro allitterativo del norreno.
L’Edda in prosa, scritta attorno al 1220 da Snorri Sturluson, poeta e politico facente parte dl parlamento islandese, comincia con una rievocazione dei miti e delle leggende già presenti nell’Edda antica ma poi evolve in un manuale di poetica, mirato a far capire i meccanismi della poesia scaldica.
Derivata dalla voce islandese skald, cioè poeta, la poesia scaldica è complessa, intricata, allitterativa, spesso composta in lode di un particolare signore. Abbonda in Kenningar, cioè metafore ermetiche, perifrasi poetiche e immaginative che sostituiscono il nome di una cosa. L’uso della Kenning è comune nella letteratura norrena, celtica e anglosassone, se ne ritrovano esempi anche nel Beowulf, e la poesia scaldica si avvicina a quella trobadorica e provenzale.
Snorri è anche noto per aver sostenuto che gli dei non fossero altro che capi militari poi venerati (in questo riproponendo la teoria del filosofo Evemero).
Occupiamoci adesso delle Saghe degli islandesi.
La forma letteraria più vicina al romanzo moderno avutasi nel medioevo, capace addirittura di coniare un termine nuovo, è, appunto, la “saga”, che ha nella sua radice il verbo “dire”.
Le Islendigasögur sono storie di famiglia - scritte su velli di pecora in un periodo di che va dal dodicesimo al quattordicesimo secolo - che parlano di persone realmente esistite, di fatti accaduti alle prime generazioni di coloni trasferitesi dalla Norvegia in Islanda, di viaggi avventurosi in Groenlandia e Nordamerica (prima di Cristoforo Colombo), dell’insofferenza verso i re norvegesi e danesi, delle razzie compiute per conquistare terra, bottino e indipendenza.
La società descritta è simile alla borghesia del diciottesimo secolo in cui prenderà piede il genere del romanzo.
“The society imagined by the Islanding sour is as precisely observed as those of Daniel Defoe and Jane Austen”. (Robert Kellog)
Dalle saghe apprendiamo la storia, la geografia ma anche dettagli minuti della vita quotidiana dell’epoca, le complicate relazioni familiari, il concetto di onore, il potere dei godi, a metà fra preti e capi politici.
Sia i due libri dell’Edda che le Saghe Islandesi sono tentativi di conservare la tradizione del passato pagano operati durante un medioevo già cristiano.
Contemporanee di Chrétien de Troyes, di Chaucer e di Dante, non sono scritte per un pubblico aristocratico ma per gente comune, proprio come il romanzo. Le saghe sono il prodotto del popolo, di agricoltori e pescatori che sedevano attorno al fuoco la sera e rievocavano le gesta di antenati e persone famose. I protagonisti non sono eroi semidivini ma contadini e possidenti terrieri, un universo maschile di rudi combattenti e fuorilegge, sebbene alcune storie diano spazio anche ad eroine femminili.
Se in spirito ricordano l’epica, non sono in versi bensì in una prosa che mescola ironia, umorismo e nostalgia. Si differenziano dal romance medievale per la poca attenzione data alla fantasia e all’amor cortese e per la mancanza del lieto fine.
Ospitano, tuttavia, molti elementi magici e fantastici, alcuni dei quali sono stati ripresi da Tolkien: i trolls, i fantasmi, i Berserker, ovvero feroci guerrieri scandinavi che avevano fatto giuramento a Odino.
La più famosa è l’Egils saga, da molti ritenuta opera di Snorri. Egil Skallagrimsson fu il più grande scaldo islandese. Molti degli eroi di cui si narra nelle saghe erano anche poeti, capaci di recitare versi celebrativi, ma non falsamente adulatori, in onore dei loro sovrani. E tuttavia le parole erano usate anche come armi per ferire e umiliare.
Gli autori delle saghe sono ignoti e le storie sono state prima tramandate oralmente e poi, solo successivamente, raccolte in forma scritta, dopo l’ introduzione della scrittura sull’isola nel XII secolo ma, anche su questo, non c’è nessuna certezza. Lo stesso concetto di autore è molto diverso dall’attuale, indicando solo “l’iniziatore” di una storia, che non impronta di sé e del suo stile personale la materia trattata.
Una prosa come quella delle saghe era rara nella letteratura del periodo, se si eccettuano il Decamerone e la vulgata francese del ciclo arturiano.
“The development of a prose fiction in medieval Iceland that was fluent, nuanced and seriously occupied with the legal, moral and political life of a whole society of ordinary people was an achievement unparalleled elsewhere in Europe.” (Robert Kellog)
Le storie non iniziano mai in medias res ma cercano di raccontare gli eventi in ordine cronologico. Il linguaggio è diretto e semplice, grande spazio è dato al dialogo. I personaggi sono introdotti da una complicata genealogia e dal patronimico, che Tolkien riprenderà e svilupperà nelle appendici. Una delle funzioni delle saghe era anche la trasmissione di queste genealogie, ed esse avevano un intento didascalico oltre che d’intrattenimento.
Di solito la saga si apre bruscamente, con un’introduzione banale: “C’era un uomo di nome etc”. La precisione nella localizzazione geografica del racconto e nell’individuazione dell’esatto contesto storico è massima. La storia racconta di un conflitto, nato per questioni banali e comuni, del suo sviluppo sanguinoso e di faide e vendette successive. I personaggi, tuttavia, mantengono qualcosa di mitico, capacità magiche nel loro canto, potere divinatorio.
Sebbene, come abbiamo detto, siano in prevalentemente in prosa, contengono al loro interno anche dei versi, inizialmente visti come una fonte d’informazione e autorità storica, in seguito divenuti mezzo di espressione della mente e dei pensieri dei protagonisti.
Concludiamo con il molto più recente Kalevala.
Nel 1835 Elias Lönrot riordina e pubblica sotto forma di poema una vasta collezione di ballate eroiche in careliano. La versione successiva, del 1849, è più completa. I Careliani sono finnici che hanno avuto contatto – guarda caso – con i vichinghi. La loro lingua, appartenente al gruppo ugrofinnico, non è di origine indoeuropea. Kalevala significa “Terra di Kaleva”, ossia, appunto, Finlandia.
Anche in questo caso si tratta del recupero di antiche tradizioni e antichi canti. Il poema è tuttora cantato da alcuni anziani bardi con valenze sciamaniche.
Fu tradotto da Igino Cocchi nel 1909 e nel 1010 dal livornese Paolo Emilio Pavolini (padre del famoso gerarca Alessandro). Quest’ultima versione, in ottonari - il metro originale del testo finnico - è disponibile in un’edizione curata da Roberto Arduini e Cecilia Barella per la casa editrice Il Cerchio di Rimini.
La storia dell’eroe e poeta Väinamöinen, del fabbro Ilmarinen e del guerriero Lemminkäinen ha in parte ispirato il poeta americano Longfellow, il compositore Sibelius e, infine, Tolkien con “Il Silmarillion” e la struttura delle lingue elfiche. Tutto gira intorno alla ricerca di una sposa per gli eroi protagonisti, e del Sampo, un mulino magico che assicura ricchezza a chi lo possiede.
Molti gli adattamenti e riduzioni per ragazzi, in particolare ci piace ricordare quella edita nel 1961 per i tipi di Malipiero, di cui riportiamo uno stralcio:
“L’intrepido vegliardo Vainamonen, immensamente forte, era il cantore di Kalevala” (Per cantore intendiamo uno scaldo, un eroe poeta simile a quelli presentii nell’Edda e nelle Saghe islandesi, che ha nel suo canto anche capacità magiche e taumaturgiche). “Il suo canto era come il cielo: copriva tutta la grande regione di Kalevala, e la copriva di giorno e di notte, come un vento gagliardo capace di profferire parole musicate che tutti udivano anche chiusi dentro le capanne. La sua fama giunse lontano, come un’acqua che si spande nelle pianure. Giunse così fino alle terre di mezzogiorno, nei luoghi di Poiola.”
****
Riferimenti
Robert Kellog, Introduzione a “The Sagas of Icelanders”, Penguin 2000
Thingvellir: behind the black basalt spur, in front of the immense lichen-covered lawn where the Althing was held, the open-air parliament of the Icelanders. In the cold, sulfur-smelling air, in this asphalt-colored lava land, among pumice dunes and geyser puffs, it is necessary to make a classification of memories and mental associations that pile up confused in our heads.
Let's start with the Edda.
The term Edda, in the plural Eddur, refers to two Norse texts both written in Iceland during the thirteenth century. The poetic Edda, or ancient Edda, and the prose Edda, that of Snorri.
The ancient Edda originates from the Codex Regius, a manuscript composed in the thirteenth century, of which traces have been lost until 1643. The initial part is the known Völuspa, the prophecy of the seer, a precious source of knowledge of Norse mythology and cosmogony. The prophet talks to Odin and tells him about the creation of the world and Ragnarök, his catastrophic fate. Inside the Völuspa, six stanzas are dedicated to a list of dwarf names, from which Tolkien drew heavily for his trilogy. In 2009, Harper and Collins published Tolkien's posthumous work on the poetic Edda, entitled "The legend of Sigurd and Gudrun", in an English that seeks to re-propose the Norse alliterative meter.
The prose Edda, written around 1220 by Snorri Sturluson, poet and politician belonging to the Icelandic parliament, begins with a re-enactment of the myths and legends already present in the ancient Edda but then evolves into a poetic manual, aimed at understanding the mechanisms of heraldic poetry.
Derived from the Icelandic voice skald, i.e. poet, Scaldic poetry is complex, intricate, alliterative, often composed in praise of a particular gentleman. Kenningar abounds, that is, hermetic metaphors, poetic and imaginative periphrases that replace the name of a thing. The use of Kenning is common in Norse, Celtic and Anglo-Saxon literature, examples are also found in the Beowulf, and the scaldic poetry approaches the trobadoric and Provencal one.
Snorri is also known for claiming that the gods were nothing but military leaders who were revered (in this proposing the theory of the philosopher Euhemerus).
Let's deal with the Icelandic Sagas now.
The literary form closest to the modern novel that took place in the Middle Ages, capable of even coining a new term, is precisely the "saga", which has at its root the verb "to say".
The Islendigasögur are family stories - written on sheepskin in a period from the twelfth to the fourteenth century - that speak of people who really existed, of events that occurred to the first generations of settlers who moved from Norway to Iceland, of adventurous trips to Greenland and North America (before Christopher Columbus), of the impatience towards the Norwegian and Danish kings, of the raids carried out to conquer land, booty and independence.
The society described is similar to the eighteenth-century bourgeoisie in which the genre of the novel will take hold.
"The society imagined by the Islanding sour is as precisely observed as those of Daniel Defoe and Jane Austen". (Robert Kellog)
From the sagas we learn history, geography but also minute details of the daily life of the time, complicated family relationships, the concept of honour, the power of godi, halfway between priests and political leaders.
Both the two books of the Edda and the Icelandic Sagas are attempts to preserve the tradition of the pagan past operated during an already Christian Middle Ages.
Contemporary of Chrétien de Troyes, Chaucer and Dante, they are not written for an aristocratic audience but for ordinary people, just like the novel. The sagas are the product of the people, of farmers and fishermen who sat around the fire in the evening and recalled the deeds of ancestors and famous people. The protagonists are not semi-divine heroes but farmers and landowners, a male universe of rough fighters and outlaws, although some stories also give space to female heroines.
If in spirit they recall the epic, they are not in verse but in a prose that mixes irony, humour and nostalgia. They differ from medieval romance by the lack of attention given to imagination and courtly love and the lack of a happy ending.
They host, however, many magical and fantastic elements, some of which were taken up by Tolkien: the trolls, the ghosts, the Berserkers, or fierce Scandinavian warriors who had sworn an oath in Odin.
The most famous is the Egils saga, considered by many to be Snorri's work. Egil Skallagrimsson was the largest Icelandic skald. Many of the heroes mentioned in the sagas were also poets, capable of reciting celebratory verses, but not falsely flatterers, in honour of their sovereigns. And yet the words were also used as weapons to hurt and humiliate.
The authors of the sagas are unknown and the stories were first handed down orally and then, only later, collected in writing, after the introduction of writing on the island in the twelfth century but, even on this, there is no certainty. The same concept of author is very different from the current one, indicating only the "initiator" of a story, which does not mark the subject with his personal style.
Prose like that of the sagas was rare in the literature of the period, except for the Decameron and the French vulgar of the Arthurian cycle.
"The development of a prose fiction in medieval Iceland that was fluent, nuanced and seriously occupied with the legal, moral and political life of a whole society of ordinary people was an achievement unparalleled elsewhere in Europe." (Robert Kellog)
Stories never begin in medias res but try to tell the events in chronological order. The language is direct and simple, large space is given to dialogue. The characters are introduced by a complicated genealogy and surname, which Tolkien recovers and develops in the appendices. One of the functions of the sagas was also the transmission of these genealogies, and they had a didactic purpose as well as entertainment.
Usually the saga opens abruptly, with a banal introduction: "There was a man named etc". The accuracy in the geographical location of the story and in identifying the exact historical context is maximum. The story tells of a conflict, born out of trivial and common questions, of its bloody development and of feuds and subsequent vendettas. The characters, however, retain something mythical, magical skills in their singing, divinatory power.
Although, as we said, they are mainly in prose, they also contain verses within them, initially seen as a source of information and historical authority, which later became a means of expression of the mind and thoughts of the protagonists.
We conclude with the much more recent Kalevala.
In 1835 Elias Lönrot rearranged and published a vast collection of heroic Karelian ballads in the form of a poem. The next version, from 1849, is more complete. The Karelians are Finns who have had contact - coincidentally - with the Vikings. Their language, belonging to the Finno-Ugric group, is not of Indo-European origin. Kalevala means "Land of Kaleva", in other words Finland.
Also in this case it is the recovery of ancient traditions and ancient songs. The poem is still sung by some elderly bards with shamanic valences.
The story of the hero and poet Väinamöinen, the blacksmith Ilmarinen and the warrior Lemminkäinen partly inspired the American poet Longfellow, the composer Sibelius and, finally, Tolkien with "The Silmarillion" and the structure of the elven languages. Everything revolves around the search for a bride for the heroes and the Sampo, a magic mill that ensures wealth for those who own it.
There are many adaptations and reductions for children, in particular we like to remember the one published in 1961 for the types of Malipiero, of which we report an excerpt:
"The intrepid old man Vainamonen, immensely strong, was the singer of Kalevala" (By singer we mean a scaldo, a poet similar to those present in the Icelandic Edda and Sagas, who also has magical and thaumaturgical skills in his hand). "His hand was like the sky, covered the whole greater region of Kalevala, and covered it by day and by night, like a strong wind capable of uttering words to music that everyone could hear even locked inside the huts. His fame went far, like water spreading over the plains. Thus it reached the lands of midday, in the places of Poiola. "
My name is Tanino
My name is Tanino (2002)
di Paolo Virzì
Regia: Paolo Virzì. Soggetto: Paolo Virzì. Sceneggiatura: Francesco Bruni, Francesco Piccolo, Paolo Virzì. Produzione: Mario e Vittorio Cecchi Gori. Casting: Lisa Parasym. Suono in Presa Diretta: Mario Iaquone. Costumi: Alex Reda. Scenografia. Ian Brock, Sonia Peng. Montaggio: Jacopo Quadri. Fotografia: Arnaldo Catinari. Musiche: Carlo Virzì. Canzoni: Cello Song (Nick Drake), La descrizione di un attimo (Tiromancino), That's Amore (Warren/ Brooks), You Make Mee Feel So Young (Gordon/ Mirow), You Won't See Me Cry (Sinclair/ Falsia), Moonlight Kisses (Ron Goodwin), Va' Pensiero Sull'Ali Dorate - dal Nabucco (Giuseppe Verdi). Organizzatore Generale: Giovanni Lovatelli. Aiuto Regia: Rocco Gismondi, Francesco Pavolini, Marco Limberti. Direttori di Produzione: James Power, Vincenzo Testa, Carlo Carpentieri. Operatore alla Macchina: Michael Carella. Interpreti: Corrado Fortuna, Rachel McAdams, Jessica De Marco, Frank Crudele, Barry Flatman, Lori Iallier, Don Francks, Mary Lons, Robert Bockstael, Daniele Bouffard, Beau Starr, Marina Orsini, Salvo Compagno, Licinia Lentini, Mimmo Mignemi, Domenico Starnone, Frank Falcone, Genio Carbone, Jerry Sprio, Roy Meleca, Neville Edwards, Benedetto Raneli, Paride Benassai, Faro Como, Frank Alonzi, Craig Lund, Meredith Ostrom, Giovanna Criscuolo, Stefania Biandeburgo, Caterina Romano, Benedetta Di Chiara, Luca Michele Cirasola, Sascia Ugenti, Antonio Palumbo, Giuseppe Sollecito, Rodolfo Statte, Johnie Chase, Rothaford Gray, Gerry Salsberg, Francesco Sineri, Ilke Hinger, Luba Schiller, Julian Grant, Eric McNabb, Alexander Chapman, Giorgio Catalano, Ornella Giusto, Irene Lopez Kuchilan, John Suresh, Peter Marino, Carmela Albero, Anna Starnino, Pietro Giammanco, Francesco Confalone, Gaspare Magaddino, Barbara Bacci, Giovanni Cipolla.
Paolo Virzì afferma: "My name is Tanino è il mio film più stupido, ma forse anche il più lieto. Non è un romanzo di formazione perché il protagonista non cresce, anzi, tutte le volte che è sul punto di capire qualcosa della sua vita sviene oppure si dimentica". (Accardo - Acerbo "My name is Virzì", pag. 113).
A parte quel che dice il regista, la sola definizione che ci viene a mente a proposito di questo lavoro di Virzì è proprio storia di formazione, vicissitudini di un ragazzo che tenta di scoprire l'America. Valzerino americano è il racconto - scritto dal regista nel 2000 - dal quale Virzì, Bruni e Piccolo estrapolano la sceneggiatura di My name is Tanino. Le suggestioni sono nobili - Proust, Celati, Mark Twain - i risultati inferiori, anche se la storia tiene e il film risulta invecchiato bene. I nostri autori raccontano le avventure eroicomiche di Tanino Mandolia (Fortuna), figlio di una parrucchiera siciliana(Lentini), che prima parte per Roma con l'ambizione di fare il regista, poi opta per gli States alla ricerca del primo amore (McAdams). Un altro motivo di fuga, meno nobile, è quello di sottrarsi agli obblighi di leva. In America conosce un sacco di amici e parenti siciliani che si danno un gran da fare per il suo futuro, anche se lui non gradisce. Ne succedono di tutti i colori: la ragazza è fidanzata, la famiglia borghese che accoglie Tanino non è perfetta come sembra, il ragazzo conosce un'orrenda italoamericana che i parenti siciliani vorrebbero fargli sposare, ma lui fugge, incontra un regista in disgrazia che ammira da sempre e assiste alla sua morte, infine viene sbattuto in galera…In mezzo a tanti eventi paradossali ci sono gli svenimenti di Tanino, incapace di affrontare la vita e i problemi, sempre confuso e inadeguato. Alla fine viene rimpatriato in Italia e decide di scrivere un film su quello che gli è accaduto, anche se non l'ha ancora capito bene.
Bravissimo Corrado Fortuna, attore esordiente non professionista scoperto da Carlo Virzì (autore di splendide musiche), inventato protagonista da un Paolo Virzì capace di far recitare chiunque. Il film viene girato tra Trapani, Palermo, New York, Toronto, costa abbastanza, ma non moltissimo, il problema è che l'impero Cecchi Gori sta scricchiolando e la produzione si blocca ripetutamente. My name is Tanino viene girato proprio in mezzo alle beghe giudiziarie di Vittorio Cecchi Gori e per un certo periodo di tempo corre il rischio di non uscire. Per ultimare la pellicola, il regista spende il meno possibile, modifica il finale ed elimina una scena complessa ambientata nel porto di New York. Il film finisce sotto sequestro a causa del fallimento del produttore ed esce solo il 30 maggio del 2003, a fine stagione. Incassa poco, nonostante la distribuzione Medusa, supera appena un milione di euro. Negli Stati Uniti è un trionfo, anche se la distribuzione è indipendente.
My name is Tanino è raccontato con il consueto stile narrativo della voce fuori campo, con azzeccati riferimenti politici, accuse alla globalizzazione e ottime parti oniriche. Virzì cita persino Miracolo a Milano di De Sica e Zavattini immortalando il volo surreale del protagonista che ripercorre la sua infanzia.
Realistico e in linea con i tempi - pur con toni comici - il rapporto tra Tanino e il compagno politicizzato, un vero reduce del passato. Licinia Lentini proviene dalla commedia sexy e il suo ruolo ammicca a un blando erotismo, come madre di Tanino e amante di un personaggio che il figlio non sopporta. Lo scrittore Domenico Starnone è il professore di Storia del cinema che vorrebbe aiutare Tanino ma non ottiene nessuna risposta sufficiente. Tanino sviene, scappa dalla realtà, vola verso il passato, rivede la madre, il padre ucciso dalla mafia, vorrebbe sapere tante cose che non ha avuto tempo di chiedere. Le parti oniriche e i flashback sono la cosa migliore di un film dal tono dolce e romantico, stile commedia sofisticata nella parte americana, molto commedia all'italiana nei momenti di raccordo. Virzì critica la famiglia borghese statunitense, la facciata rispettabile che nasconde i problemi, fa capire che dietro l'apparenza si nascondono tradimenti e pulsioni distruttrici. Gli italoamericani vengono trattati da mafiosi e maneggioni e anche se il taglio è grottesco il regista coglie spesso nel segno. Alcune sequenze sembrano prelevate da un noir americano, un poliziesco rapido che fotografa le strade di New York in maniera essenziale. L'incontro con Chinasky (Franks), il regista in disgrazia che Tanino venera come un maestro è un momento molto poetico che termina con la morte del mito, in tutti i sensi. Un film non del tutto riuscito, ma che si rivede volentieri, spaccato di una società che cambia, ritratto di un personaggio inadeguato alla vita, incapace di affrontarla.
Rassegna critica. Pino Farinotti concede tre stelle: "Virzì fa viaggiare il suo personaggio dentro paesaggi da film, accompagnato dalla macchina da presa, come se, nel raccontare la vicenda di Tanino fosse riuscito a non mettere mai piede fuori dal cinema". Molto meno entusiasta Morando Morandini che assegna una stella e mezzo senza sprecare un briciolo di motivazione. Paolo Mereghetti arriva a due stelle: "Virzì aggiorna divertito una vecchia formula (l'italiano all'estero), facendo precipitare il suo antieroe in un mondo ancora più provinciale di quello che si è lasciato alle spalle. Nell'affollarsi di personaggi, si ritrovano pregi e difetti della commedia all'italiana di una volta: capacità di osservazione, talento per il bozzetto satirico, indugio caricaturale, tendenza a smussare gli angoli. Ma Virzì sa anche rappresentare in modo non acritico una certa disponibilità cialtrona, emblematica di una generazione". Il critico milanese è convincente nella puntuale analisi critica. Resta da dire - a parziale scusante del regista - che i guai produttivi comportano tagli, rapidità di esecuzione nella parte finale e contenimento dei costi per riuscire a terminare la pellicola. Tutto sommato My name is Tanino è una storia ben raccontata.
/http%3A%2F%2Fwww.livornomagazine.it%2FGordiano-Lupi%2Fcover%2FMy_Name_Is_Tanino.jpg)
Livorno Magazine - Periodico di Informazione
FILMOGRAFIA :. La bella vita (1994) :. Ferie d'agosto (1996) :. Intolerance (1996) :. (episodio "Roma Ovest 143") :. Ovosodo (1997) :. Baci e abbracci (1999) :. My nime is Tanino (2001) :. Caterina
http://www.livornomagazine.it/Gordiano-Lupi/Gordiano-Lupi-Cinema-Virzi-09-my-name-is-tanino.htm
Povera Sandy
Ho tenuto gli occhi aperti, ti ho visto uscire. Ti muovevi, eri vivo. Sei rimasto vivo finché il dottore non ha fatto l’iniezione, poi ti sei afflosciato come un polpo fuor d’acqua.
Devo telefonare a Frank, devo chiamare io, perché lui sta in riunione fino a tardi, e poi va a prendere sua figlia all’asilo. Frank ama sua figlia, parla sempre di come lei storpia la parola coccodrillo, dello spazio che ha fra i dentini, di quando gli corre incontro al rientro dal lavoro. Devo dirgli che non si dia più pena, che sua moglie non può fare uno scandalo, che nessuno gli toglierà la bambina. Non posso vederlo in quello stato, così cupo che non mi dà neppure un bacio.
Però giovedì è arrivato sorridente all’appuntamento. “Non ti preoccupare, Sandy, ho considerato tutto.”
Mi ha messo in mano un biglietto da visita con il nome di una clinica privata. “Il dottor Stone è un amico, con l’assegno che gli ho staccato non farà storie. Su, coraggio, Sandy, nella vita ci vuole buon senso”.
Ho annuito, poi mi sono guardata le scarpe.
Ha ragione lui, naturalmente. Frank ha sempre ragione.
Ti sei mosso parecchio nell’ultima settimana, il ginocchio contro il diaframma, il piede verso l’intestino. Sei cresciuto da un’ecografia all’altra.
Non è stato un aborto. Non al sesto mese.
“Sai che non devi chiamarmi quando sono in riunione.”
“Scusa, Frank, ti volevo avvisare.”
“Com’è andata?”
“Non c’è più.”
“Tu come stai?”
“Sto bene, Frank… ma…”
“Che c’è?”
“Era vivo, respirava.”
“Per l’amor di dio, Sandy, smetti di pensarci.”
Il dottore ti ha preso con due mani perché eri troppo grande per stare in una sola. Avevi le dita lunghe ed i piedi come quelli di Frank. Eri coperto da una peluria rossa.
Tua sorella Maddie, la figlia di Frank, doveva essere così, quando è nata
Stasera, dice Frank, non può passare a trovarmi in clinica. Devo fare la brava, devo capire che è un giorno speciale, perché nevica.
“Di sicuro Maddie vorrà far pallate. E’ incredibile come ogni cosa la faccia impazzire.”
E tu?
Tu che mi amavi solo perché ero tua madre, che ti fidavi di me, che ascoltavi battere il mio cuore all’unisono col tuo, che aspettavi di vedermi e di vedere tuo padre? Tu non avevi il diritto d’impazzire?
Domani mi alzerò da questo letto e troverò Frank giù in macchina. Mi dirà di aver sognato le mie labbra e che nessuna lo eccita come me.
Poi tornerà da Maddie.
Anch’io andrò a casa. Senza pancia, senza niente.
"Baci e abbracci" tra gli struzzi in Val di Cecina
Baci e abbracci (Italia - Commedia - 1999).
Regia: Paolo Virzì. Produzione: Rita e Vittorio Cecchi Gori. Soggetto e sceneggiatura: Francesco Bruni e Paolo Virzì. Direttore di produzione: Elisabetta Olmi. Aiuto regista: Gianluca Greco. Suono in presa diretta: Tullio Morganti. Scenografia: Lorenzo Baraldi. Costumi: Francesca Sartori. Fotografia: Alessandro Pesci. Montaggio: Jacopo Quadri. Operatori: Fabrizio Vicari, Giovanni Gebbia e Salvatore Anversa. Musiche originali: Gli Snaporaz. Produttore esecutivo: Alessandro Calosci. Supervisione: Lierka Rusic.
Interpreti: Francesco Paolantoni (Mario), Massimo Gambacciani (Renato), Piero Gremigni (Luciano), Paola Tiziana Cruciani (Tatiana), Daniela Morozzi (Ivana), Isabella Cecchi (Annalisa), Emanuele Barresi (Ennio), Rosanna Mazzi (Stefania), Samuele Marzi (Matteo), Emiliano Cappello (Gabriele), Maria Grazia Taddei (Bruna), Martino Cecconi (Nelusco), Sara Mannucci (Margherita), Edo Gabbriellini (Alessio) e il gruppo degli Snaporaz (Carlo Virzì - Stefanino - Toto Barbato - Poncino - Valerio Fantozzi - Chico - Gianluca Ferrara - Barsimpson - Matteo Pastorelli - Gigiballa - Geppo Gemini - Vustok - sono gli Amaranto Posse).
Dopo il trionfo di Ovosodo Paolo Virzì raduna ancora una volta un cast di dilettanti per girare una commedia all'italiana vecchio stile che entusiasma pubblico e critica. Il film a nostro avviso è riuscito solo in parte ed è il peggiore tra quelli realizzati da Virzì, soprattutto per la storia (di solito punto di forza dell'autore livornese) che a tratti zoppica e risulta frammentaria. Ma in definitiva resta un buon film.
Al centro della vicenda emerge la figura di Mario, un salernitano separato dalla moglie che vive a Cecina dove è proprietario di un ristorante in via di fallimento. Accanto a lui ci sono Renato, Luciano e Tatiana, tre ex operai livornesi che per sfuggire alla disoccupazione hanno deciso di aprire un allevamento di struzzi nelle colline tra Cecina e Volterra. I tre sono immersi in un mare di debiti e soltanto un assessore regionale dell'Ulivo potrebbe garantire una boccata d'ossigeno alla disastrata impresa elargendo un generoso contributo. La storia prende corpo da un equivoco. Il presunto assessore è Mario e i tre imprenditori lo trattano con ogni riguardo, addirittura gli mettono in braccio la procace Annalisa (amante di Renato) purché firmi il contributo. La trama pare uscita dal romanzo di Gogol "Il revisore" o dal vecchio film "Anni ruggenti" di Luigi Zampa, opere presenti a livello di ispirazione e in sede di stesura del soggetto. In mezzo a questi problemi e avvenimenti si inseriscono i giovani e incoscienti "Amaranto Posse" che si installano nel podere per provare la loro musica e fare un po' di pulizia. Il finale resta aperto a mille soluzioni. Mario viene scoperto, Renato dà in escandescenze, l'azienda pare andare a rotoli, però dalle ceneri del fallimento scaturisce una nuova idea, quella di aprire un ristorante nel vecchio casale di campagna. Il pranzo di Natale viene cucinato da Mario, chef d'eccezione, e l'atmosfera si stempera in una dolcezza quasi romantica. Dalle tragedie della vita ci si può risollevare, sembrano dire Virzì e Bruni, che utilizzano i vecchi schemi della commedia all'italiana per costruire un film corale a metà strada tra favola e racconto sociale.
Quando la vita è cattiva è bello sentirsi tutti più buoni, recitava la pubblicità del film, pure se la bontà è finalizzata alla concessione di un contributo ed è causata da un tragico sbaglio di persona. In ogni caso i buoni sentimenti trionfano lo stesso, perché una volta chiarito l'equivoco i protagonisti della storia si trovano riuniti davanti a una tavola imbandita. Virzì disegna un racconto corale vero, personaggi credibili, con esigenze sentimenti, emozioni palpabili, lavora sul dialetto e sulla recitazione spontanea di ottimi attori non professionisti. L'eccezione alla regola è Francesco Paolantoni che abbandona le macchiette televisive e ci consegna un'interpretazione da manuale di un fallito, un uomo che ha distrutto la sua famiglia e che non ha più un lavoro, disperato, sull'orlo del suicidio. Una figura malinconica e candida quella di Mario, così come Renato è un personaggio vulcanico e pieno di idee, ben tratteggiato dall'avvocato (nella vita di tutti i giorni) Massimo Gambacciani.
Il film conferma il talento di Virzì e la bravura di Bruni nello scrivere e sceneggiare storie tratte dalla vita quotidiana, nel condirle con quel gusto dolce-amaro che le rende simili a favole fantastiche.
Molte le scene da ricordare di una pellicola che presenta il solo difetto della frammentarietà. Si fa un po' fatica a stare dietro a tutto il concatenarsi di eventi e il disegno corale quasi da soap-opera realizzato dagli autori fatica a prendere corpo.
La prima scena è tragicomica. Si sottolinea la disperazione di Renato che telefona per chiedere una proroga ai termini di pagamento di duecento milioni di finanziamento e lo accompagna una musica da marcia funebre. Uno struzzo divora il suo cellulare e questo fatto è alla base dello scambio di persona perché il vero assessore non riesce a mettersi in contatto con loro. "Digeriscono tutto quelle bestie", dirà poi Renato. La televisione locale (Tele Granducato) si occupa dei neo imprenditori e quando viene sera la famiglia riunita davanti al televisore fa a gara nel rivedersi (scena già vista ne La bella vita). Virzì sa descrivere la vita di provincia dei ceti poveri e medi, per lui pregi e difetti non sono un mistero, indugia volentieri nel raccontare macchiette umoristiche e scene estrapolate dalla vita di tutti i giorni.
La macchina da presa passa dal dramma dei tre nuovi imprenditori in mezzo ai debiti a quello di Mario, sempre più solo in un ristorante che nessuno frequenta, a parte gli ufficiali giudiziari che cominciano a portare via roba. La tragedia di Mario è pure familiare, con una moglie che l'ha abbandonato, un figlio indifferente ai regali di Natale, che per giunta non sa fare, visto che compra la maglia di Ronaldo per un ragazzo juventino. Mario beve e tenta il suicidio dopo un mancato prestito in banca, il regista descrive bene quest'uomo provato dalle troppe delusioni e segnato da un tragico destino. I tentativi di suicidio rappresentano nuovi fallimenti che spingono a sorridere ancora su un uomo incapace persino di morire. In mezzo a questi piccoli drammi quotidiani si inseriscono gli Snaporaz capitanati da Carlo, fratello di Paolo Virzì, e la loro incoscienza giovanile. Nella finzione scenica sono gli "Amaranto Posse" e insieme a loro c'è Alessio, il fratello di Renato, interpretato dal bravo Edo Gabbriellini che recita una parte secondaria rispetto a quel che aveva fatto in Ovosodo. C'è pure la tresca destinata a essere scoperta, tra Renato e la procace Annalisa, spacciata per segretaria con il presunto onorevole e per la donna di Luciano con la moglie. Poi ha inizio la commedia degli equivoci quando Renato e Luciano scambiano Mario per l'onorevole e lo portano al vecchio casolare. Pensare che Mario era alla stazione solo per suicidarsi. Accade di tutto e il povero Mario viene scorrazzato per l'allevamento a vedere struzzi, uova che si stanno per schiudere e incubatrici. Mario non è indifferente alla bellezza di Annalisa e i tre soci gliela gettano tra le braccia, ma il sentimento che nasce tra i due è sincero. Di nuovo Virzì insiste nel dire che dalle cose negative può nascere qualcosa di buono. Resta lo spazio per un minimo di critica politica e sociale che non manca mai nei film di Virzì, qualche stoccata alla nuova sinistra che non si sa bene cosa sia diventata. "E se è dell'Ulivo ma non è comunista? Tipo del PPP, PPC o roba così…", fa Luciano parlando dell'assessore. E infatti poco dopo si mettono tutti a pregare prima di mangiare, equivocando su un gesto di Mario, ma nessuno sa recitare il Padre Nostro. Apprezziamo richiami a Tangentopoli, al fatto che tutti più o meno rubavano, c'era poco da fare. Non è qualunquismo, si descrive il sentimento dell'uomo della strada, le cose che ragionando al bar o tra amici tutti dicevamo. Altri drammi particolari si uniscono alla tragedia generale, Annalisa si confida con Mario sulla storia di uno zio che da piccina la toccava, racconta pure di Renato, afferma che con lui non sarà mai felice. Mario confessa che è separato e che soffre molto. Tutto molto bello. Proseguono gli equivoci con le battute sul ristorante di Mario che "era caro appestato", il regalo di Natale inatteso e Mario che dice: "Questo è il più bel Natale della mia vita", per poi scoppiare in un pianto nervoso. Mario è un bel personaggio, a tratti patetico, ben disegnato dalla penna di Bruni e Virzì, ben interpretato da Paolantoni. Sdrammatizzano gli Snaporaz con un "Non si soffre più!" intonato in coro. Bella pure la fotografia lunare e la nevicata improvvisa che chiude la pellicola.
Ottimo il personaggio di Luciano reso da Piero Gremigni con flemma da tontacchione di provincia. Brava anche la solita Paola Tiziana Cruciani nella parte di Tatiana, l'unica che sospetta, la prima a capire che Mario non è un assessore ma un disgraziato come loro. Pure i bambini hanno un ruolo. Uno è ipertecnologico e distruttivo, un'altra ama leggere fiabe e romanzi e addormenta il padre Luciano con una storia intitolata Matilde. Da ricordare pure una parte onirica con Mario che sogna il matrimonio finito male per un suo tradimento. Nell'incubo il bambino indossa la maglia della Juventus.
Il finale da buona commedia all'italiana risolve tutti i fili disseminati nel corso della storia e gli equivoci si dipanano. Mario è maltrattato da Renato che esplode in una collera irrefrenabile, ma in fondo la bontà del gruppo e l'atmosfera natalizia trionfano. Tutti si ritrovano davanti a una mensa imbandita a festeggiare il Natale proprio mentre le prime uova di struzzo si stanno schiudendo. Particolare il finale che ricorda una chiusura di un vecchio film di Francesco Nuti (Tutta colpa del Paradiso - 1985) con una componente degli "Amaranto Posse" che mette una mano davanti alla telecamera e interrompe la visione.
Baci e abbracci si doveva intitolare Struzzi e forse il titolo sarebbe stato più calzante, perché ispirato a una storia di provincia che si dipana in uno dei tanti allevamenti di struzzi che sono sorti nella zona di Guardistallo (dove si fa addirittura una sagra dello struzzo). Ma nello stesso periodo di uscita saltò fuori una commedia con lo stesso titolo e c'era il timore di fare pubblicità o di avere problemi di copyright. La storia si svolge in mezzo a una varia umanità di umili e ingenui operai ed ex operai, vinti di verghiana memoria, gente presa a schiaffi dalla vita che però si risolleva ed è capace di lottare. Un film buonista e di buoni sentimenti, certo, mai melenso e stucchevole, al contrario vero e profondo, che sa dare una luce di speranza allo spettatore. Il cinema di Virzì è cinema d'autore che racconta bene le sue storie e che ha per teatro sempre la provincia, vista come luogo che mantiene caratteristiche profonde di diversità.
A parte Francesco Paolantoni, che per la prima volta recita qualcosa di diverso da una macchietta comica, e Paola Tiziana Cruciani (molto brava), sono tutti dilettanti. Ma che dilettanti! Diretti con bravura da Virzì i terribili attori per passione ci lasciano un'interpretazione memorabile. Massimo Gambacciani, di professione avvocato, Isabella Cecchi, barista, Daniela Morozzi, attrice per l'hobby, Piero Gremigni è veterinario, Sara Mannucci è una studentessa, poi ci sono i bambini e c'è pure Edoardo Gabbriellini che dopo Ovosodo si può dire quasi un veterano. Infine gli Snaporaz di Carlo Virzì che compongono e suonano in presa diretta la colonna sonora e recitano la parte di loro stessi. Un film garbato, scanzonato, poetico, a tratti pure malinconico, un'opera delicata che si muove tra la fiaba e la farsa, dipingendo con efficacia luoghi e caratteri, sentimenti e solitudini, verità e bugie.
/http%3A%2F%2Fwww.livornomagazine.it%2FGordiano-Lupi%2Ffoto-articoli%2Fbaci-e-abbracci-1999.jpg)
Livorno Magazine - Periodico di Informazione
Per conoscere Paolo Virzì Ottava puntata "Baci e abbracci" tra gli struzzi in Val di Cecina FILMOGRAFIA :. La bella vita (1994) :. Ferie d'agosto (1996) :. Intolerance (1996) :. (episodio "Roma ...
http://www.livornomagazine.it/Gordiano-Lupi/Gordiano-Lupi-Cinema-Virzi-08-baci-e-abbracci.htm
MEMORIE DI UN PAZZO di L. TOLSTOJ (1828 – 1910)
MEMORIE DI UN PAZZO di L. TOLSTOJ (1828 – 1910)
Il racconto che abbiamo letto nell’edizione Garzanti risale al 1884. I temi espressi sono nettamente legati alla vita personale dello scrittore e ai suoi tormenti etico-religiosi.
Il protagonista della vicenda narrata ammette subito la sua pazzia, nonostante il responso dei medici sia diverso. Lo considerano “predisposto all’emotività”, ma “sano di mente”. La medicina del suo tempo lo giudica guaribile.
L’uomo parte da lontano per parlarci dei suoi disturbi. Ci narra due episodi della sua infanzia che lo hanno turbato. Nel primo la governante accusa con forza la balia di essersi appropriata di una zuccheriera. Basta questa scena per far sprofondare il bambino nell’agitazione; “ … tutto mi sembra doloroso … incomprensibile … e io nascondo la testa sotto la coperta”.
Un altro ricordo è quello del racconto della Passione di Cristo, fatto dalla zia. Il ragazzino non capisce il motivo di tanto accanirsi su un uomo buono: “Per quale motivo lo battevano? Lui aveva perdonato, ma quelli lo battevano. Faceva male? Zia, gli faceva male?”. Non c’è una risposta e il bambino singhiozza e sbatte la testa contro il muro.
Da adulto le cose sembrano migliorare. Il protagonista si sposa. Ha una famiglia, delle proprietà, un certo prestigio sociale e una carica pubblica. Si occupa razionalmente di aumentare le sue ricchezze; punta ad acquisire altre terre, non senza malizia e astuzia. Viaggiando però ritrova le sensazioni di tormento dell’infanzia. Dapprima, una notte, si sveglia spaventato e si chiede: “Per quale motivo sono in viaggio? Dove vado?”. Improvvisamente tutto quello che aveva in programma di fare si rivela insensato. I bisogni autentici sembrano essere altri.
Si arriva allora alla terribile notte di Arzamas, cittadina in cui l’uomo si ferma col suo servo, agognando riposo e serenità. Sono cose piccole ad angosciarlo subito: un rumore di passi, la macchia sulla guancia di un lavorante, la forma quadrata della stanzetta in cui si ritira. Il viaggiatore non dorme e si domanda: “Da cosa, dove scappo?”. Due domande profonde nel medesimo quesito. La paura che lo assale è quella della morte: “Tutto il mio essere sentiva la necessità, il diritto alla vita e nel contempo la morte che sopraggiungeva”.
Poco oltre aggiunge: “Non c’è niente nella vita, c’è invece la morte, ma non ci deve essere”. Cerca di pensare agli affari, agli acquisti, alla moglie, ma senza ricavarne conforto. Il vuoto della vita sembra portarlo a subire un profondo senso di orrore. A questo punto inizia a pregare, cosa che non faceva da una ventina d’anni e questo gli da un piccolo sollievo.
Quell’angoscia è sempre in agguato e per sfuggirle l’uomo si getta nel fare e nel correre: “Dovevo vivere senza fermarmi”. Conduce la sua esistenza come sempre, ma ora prega e va in chiesa. Riprende coraggio e ricomincia a viaggiare, diretto a Mosca. E’ di buon’umore quando si ferma a dormire in una locanda. Ancora una volta sono piccole cose a scatenare il dramma: un vecchio che tossisce in una stanza vicina, la fiamma della candela che illumina tra le altre cose un tavolo scrostato, la ristrettezza dell’ambiente. La notte è peggiore di quella di Arzamas; il viaggiatore prega e chiede ripetutamente a Dio le ragioni del suo turbamento.
Nella sua vita appare l’apatia: non si occupa più degli affari e la sua salute peggiora. L’unica manifestazione di vitalità è la caccia, ma durante una battuta si perde e prova un’angoscia cento volte più grande di quelle di Arzamas e di Mosca. Quando torna a casa, capisce che non avrebbe dovuto mettersi sullo stesso piano di Dio, interrogandolo riguardo ai suoi tormenti. Comincia a leggere la Bibbia, i Vangeli, le vite dei Santi. Sta cambiando anche nella sua interiorità, ma il percorso non è ancora completo.
Il protagonista sta per comprare un fondo a un prezzo fin troppo vantaggioso. Ma dopo aver parlato con una povera vecchia, capisce che il suo successo non può avvenire a spese degli altri. Anche i contadini devono vivere e meritano rispetto. La moglie non apprezza questa conversione che lui stesso definisce come l’inizio della sua pazzia. Poi si arriva alla svolta che coincide con la follia totale. L’uomo sta assistendo alla messa; improvvisamente gli portano la comunione. Gli viene quindi offerto il Corpo di Cristo, non è lui a chiederlo ed esso è come un dono inatteso (“improvvisamente mi portarono la comunione”). Troviamo quindi delle frasi piuttosto oscure, originate anche dalla presenza di alcuni mendicanti fuori dalla chiesa: “E improvvisamente mi divenne chiaro che tutto questo non doveva essere. Non solo non deve essere e non c’è, ma se non c’è, allora non c’è né morte né paura, e non c’è più in me il precedente sgretolamento, e ormai non ho più paura di niente”. Ora il tormentato cessa di essere tale; dona dei soldi ai poveri e torna a casa a piedi parlando con le altre persone.
Il percorso di crescita è stato molto lento e segnato da alcuni passaggi; la riscoperta della preghiera, il riavvicinamento alla chiesa e ai sacramenti, cose importanti ma non essenziali. Il cambiare luogo, il muoversi, lo spostarsi non giovano, come ci ricorda la saggezza di Orazio: caelum, non animun mutant qui trans mare currunt. La svolta c’è, invece, quando il protagonista rinuncia a un acquisto che avrebbe causato sofferenza ad altri. Questa è la vera follia; rinunciare al proprio interesse in favore di persone sconosciute e non in grado di ricambiare. La moglie non è d’accordo e ciò fa pensare ai contrasti che Tolstoj ebbe con la consorte nell’ambito delle sue scelte.
Il percorso si completa nel finale del racconto. La presenza dei poveri deve essere percepita come un’iniquità da eliminare; non bastano la preghiera e l’osservanza dei precetti. Ci vuole infatti azione concreta; il decidere di intervenire è in prospettiva una vittoria sulla povertà (così ci spieghiamo quel “non solo non deve essere e non c’è”). Quindi il ricco lascia i suoi rubli ai mendicanti e torna a casa a piedi, non in carrozza, “parlando col popolo”; è un segno di apertura, di voglia di parità. D’altronde Tolstoj nell’organizzare scuole per i figli dei contadini, si chiedeva cosa avesse lui da dare ai suoi servi, ma anche cosa avesse da imparare da loro. Per un certo periodo si accostò ai mestieri manuali, lavorando in età già matura presso un calzolaio.
L’autore sembra con questa storia dal sapore molto autobiografico, indicare un percorso agli uomini, dalla compiaciuta cura di sé alla scoperta degli altri attraverso il Vangelo e l’azione concreta (da non confondere con la mera elemosina o la paternalistica filantropia).
Un percorso di crescita e redenzione, nella consapevolezza di dover molto patire e fare prima di diventare veramente se stessi. Questa consapevolezza, fatta di preghiera, concretezza, impegno verso gli altri, coincide con una forma di follia. Solo un pazzo, d’altronde, rinuncerebbe a un vantaggio personale per non arrecare danno a un altro.
Pic nic
Mi allontano dallo spiazzo, mi accuccio per un bisognino, a ginocchia larghe, culo in giù, coso che penzola fra le gambe. Mi concentro, perché non è che sia proprio un bisognino da nulla, insomma, è impegnativo sto stronzo.
Vedo se esce, guardo anche il rivolo di pipì che corre sugli aghi di pino, secchi e gialli. Noto il picciolo che hanno in cima, in colonia ci avevano insegnato ad intrecciare le collane, bastava prendere la punta e infilarla proprio nel picciolo.
Poi, visto che si va per le lunghe, alzo la testa.
E la vedo. Vedo la pineta per la prima volta dopo ore, dopo averci mangiato dentro gli zerri sotto il pesto, forse perché da questa posizione, a faccia in su, si sente il vento che muove le cime, e la luce piove dai rami, e scaglie di sole mi squamano la pelle come fossi anch’io uno zerro.
Mi pulisco con una foglia, tiro su i pantaloni con una certa urgenza, come se mi premesse d’andare, di camminare, di non tornare dalla Mariuccia e dai figlioli.
E cammino, difatti. Cammino con le ciabatte di gomma sugli aghi di pino, cammino giù per le vallette e su per i monticelli, tocco le cortecce resinose, ascolto i gabbiani che urlano, oltre gli ombrelli, negli squarci di cielo. Il mare, di là, respira salmastro.
Scendo e risalgo, con la zucca vuota di pensieri.
Sento che mi chiamano, che hanno smesso di tirar pedate al pallone.
“Fra un minuto sono lì, ci sto io in porta, ciccetti miei.”
***
Chissà quanto mi avranno cercato. Ma poi, in qualche modo, si saranno arrangiati, la Mariuccia è una donna forte.
Uno qui ci sta bene e non ha bisogno di nulla
Hanno forse bisogno di qualcosa gli alberi?
Un "Ovosodo" che non va né su e né giù
/image%2F0394939%2F201310%2Fob_fb78f6e69775d3ac35f0670a0d9257db_ovosodo-jpg.jpeg)
Ovosodo (Italia - Commedia - 1997).
Regia: Paolo Virzì. Soggetto: Furio Scarpelli e Paolo Virzì. Sceneggiatura: Francesco Bruni, Furio Scarpelli, Paolo Virzì. Fotografia: Italo Petriccione. Musiche: Battista Lena e Snaporaz. Montaggio: Jacopo Quadri. Scenografia: Giancarlo Basili e Sonia Peng. Produzione e distribuzione: Cecchi Gori Group Tiger.
Interpreti: Edoardo Gabbriellini (Piero adulto), Nicoletta Braschi (Professoressa Giovanna Fornari), Matteo Campus (Piero A 7 Anni), Malcom Lunghi (Piero A 13 Anni), Enrica Pandolfi (Susy A 13 Anni), Claudia Pandolfi (Susy adulta), Marco Cocci (Tommaso), Alessio Fantozzi (Ivanone), Salvatore Barbato (Mirko), Monica Brachini (Mara), Pietro Fornaciari (Nedo), Daniela Morozzi (Luana), Regina Orioli (Lisa), Barbara Scoppa (Bianca).
Piero Mansani (Edoardo Gabriellini), nato nel 1974, cresce in un quartiere popolare di Livorno chiamato "Ovosodo". I problemi in famiglia non gli mancano. Sua madre muore quando lui è ancora un ragazzino. Ha un fratello down, Ivanone (Alessio Fantozzi), e un padre ricercato dalla polizia per spaccio di stupefacenti che finisce in galera dopo essersi sistemato con una nuova compagna che resta con i ragazzi e mette al mondo una bambina. Piero, nonostante la precaria condizione familiare, se la cava bene al Liceo Classico ed entra nelle simpatie della giovane professoressa di Lettere Giovanna Fornari (Nicoletta Braschi) che diviene sua amica prima ancora che insegnante. Al liceo Piero conosce il misterioso Tommaso (Marco Cocci) un ragazzo che racconta poco della propria famiglia e che sembra un irrequieto squattrinato anarchico, ribelle ed esibizionista. In realtà è figlio di un ricco industriale proprietario di una fabbrica chimica che inquina la zona dove abita Piero. Una sera Piero è invitato a casa dalla professoressa Giovanna (che vive da sola con un gatto), in compagnia dell'amico Tommaso. Dopo una cena piena di allegria le cose precipitano quando Tommaso segue Giovanna in cucina (mentre Piero resta in sala da pranzo) e cerca di baciarla. Il resto della cena si svolge in un silenzio tombale e quando i due ragazzi se ne vanno Giovanna invita Piero a non riportare mai più a casa sua Tommaso. In seguito Piero incontra Giovanna davanti alla scuola. Lei chiede se Tommaso è stato di nuovo assente e se sa dove può trovarlo. Piero capisce che tra Giovanna e Tommaso c'è stato qualcosa e prova un sentimento di rabbia e di rancore per l'amico, facendo intuire di essersi preso una cotta per la professoressa. Tommaso sembra sparito.
Piero ritrova l'agenda di Tommaso sotto il banco di scuola e grazie a quella risale all'indirizzo di una villa dove apprende che Tommaso è il figlio dell'ingegner Paladini della Palchimica S.p.a. Quando Piero lo scopre cerca l'amico, inviperito perché questi gli ha mentito, forse è pure geloso di lui per quel che c'è stato con la professoressa… Piero viene a sapere che Tommaso è a Roma e lo raggiunge nella Capitale a casa dei suoi zii per prenderlo a pugni, cosa che avviene puntualmente. Dopo aver fatto pace Tommaso racconta a Piero cosa successe la sera della cena a casa di Giovanna e del suo tentativo di baciarla. Gli rivela di averla poi richiamata la sera dopo per scusarsi del suo comportamento, di essere andato di nuovo a casa della donna, di aver fatto l'amore con lei. Piero a Roma conosce anche Lisa (Regina Orioli), cugina di Tommaso, e se ne innamora ma deve tornare a Livorno e, nonostante chiami ripetutamente la ragazza al telefono, non riesce più a rintracciarla. Tempo dopo, casualmente, Piero incontra Giovanna in un bar, sola e triste ma non la avvicina.
Attraversando un periodo di incertezza per via dei suoi problemi di cuore Piero arriva all'esame di maturità impreparato e viene bocciato. L'amico Tommaso invece ottiene il diploma, forse raccomandato dal potente genitore. Piero passa un periodo di malinconia accentuato dalla notizia che Giovanna è ricoverata in una clinica per problemi di esaurimento nervoso. Il ragazzo va a farle visita e tenta di confortarla. Giovanna lo rassicura di stare bene è che è solo il "primario presuntuoso" che vuole farle una serie di inutili accertamenti. Ma nel salutare il ragazzo lo abbraccia forte lasciando intuire di avergli mentito. Tempo dopo Piero riceve la cartolina dal Distretto Militare e parte soldato. Tornato a casa una tragica notizia lo attende, la sua amica Giovanna si è suicidata. Al cimitero sulla sua tomba Piero incontra di nuovo Tommaso. Tra alti e bassi la sua vita continua finché trova lavoro proprio nella fabbrica del padre di Tommaso (che invece parte per gli USA per motivi di studio). Piero riallaccia i rapporti con Susy (Claudia Pandolfi), una ragazza vicina di casa che era innamorata di lui fin da quando erano bambini, ma che Piero aveva sempre trattato solo come un'amica. Per ironia della sorte Susy trova a buon prezzo una casa dove andare a vivere da sola. Piero la aiuta nel trasloco e quando i due si recano all'indirizzo Piero scopre che si tratta proprio dell'abitazione della professoressa Giovanna, rimasta libera dopo la sua morte. Per quelle stanze si aggira affamato solo il gatto della donna. Proprio nella casa di Giovanna scocca la scintilla tra Piero e Susy e finalmente lui se ne innamora. Susy rimane incinta. I due ragazzi decidono così di sposarsi ed alla bambina che nasce nove mesi dopo Piero dà il nome di Giovanna.
Il film ha conquistato il Gran Premio Speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia ed è un premio più che meritato perché si tratta senza dubbio del miglior film italiano della stagione. Pubblico e critica sono stati concordi nel decretarne il successo.
Ovosodo è la storia semplice e piuttosto comune di un ragazzo della Livorno popolare, raccontata in prima persona e scandita da lapidarie annotazioni su un diario di scuola. Protagonista è Piero, un adolescente un po' timido e sognatore con la faccia segnata dai brufoli,
uno dei tanti ragazzi che, zaino in spalla, vediamo ogni mattina recarsi a scuola. Di Piero, detto "Ovosodo" (da qui il titolo del film), Virzì racconta i primi anni di vita, quelli passati al fianco della madre malata, l'adolescenza,
segnata dai primi amori e dai travagli esistenziali, e l'ingresso nell'età adulta, foriero di sogni infranti ma anche di grandi conquiste. È con uno stile asciutto e grande garbo che Virzì affronta l'argomento. È con grande semplicità e senza falsa retorica che parla dei ragazzi di oggi ed è forse questo ad aver suscitato alla Mostra del Cinema di Venezia le simpatie del pubblico, in gran parte formato da giovani. Infatti Virzì, rispetto ai precedenti "Jack Frusciante" e "Tutti Giù Per Terra", "romanzi di formazione" un po' sguaiati, prigionieri di un pessimismo da luogo comune e popolati da figurine opache prive di ogni sprazzo vitale, restituisce al periodo adolescenziale la sua gioiosità, pur documentandone i dolori e i tormenti, e ai ragazzi l'energia vitale tipica della loro età.
Non sono "i giovani della generazione X" quelli che Virzì ci propone, ma i ragazzi veri, quelli che popolano le nostre scuole, le nostre città... Tutti conosciamo un Piero timido e con i brufoli, o un Tommaso anarchico e miliardario, o una Susy goffa e con l'apparecchio... Insomma, una volta tanto il riferimento è a ragazzi reali, tanto più reali perché interpretati da giovani presi nelle scuole o per la strada. Virzì infatti ha voluto nel suo film per i ruoli principali tutti attori non professionisti, una scelta questa che ha dato ottimi risultati. Infatti da Edoardo Gabbriellini, il protagonista, a Alessio Fantozzi, fratellone ritardato, gli attori sono tutti straordinari. Oltre al protagonista, degni di nota sono Marco Cocci, rampollo ribelle sullo schermo come nella
vita, e i giovanissimi Matteo Campus e Malcom Lunghi che vestono i panni di Piero all'età di sette e tredici anni. Poi c'è Claudia Pandolfi, unica professionista del gruppo insieme a Nicoletta Braschi, che con un intenso cammeo dimostra di essere, malgrado la giovane età, un'attrice matura.
Un film godibile, dunque Ovosodo, con un cuore tenero.
Un critico inflessibile come Massimo Bertarelli su "Il Giornale" del 3 settembre 2001 ha definito il film come "una brillante, amara e spiritosa commedia sociale del toscano Paolo Virzì, che nella natia Livorno mette in scena con grande acutezza psicologica malinconie e disagi giovanili, eleggendo la fabbrica a fucina dei veri uomini. Tutto bene, anche se si fatica a seguire la voce narrante che parla a raffica con marcatissima inflessione toscana". Avrà faticato lui, aggiungo io. Noi che siamo livornesi no. E comunque il vernacolo in un film come questo è più che dovuto. Da segnalare poi che per questo film Nicoletta Braschi ha vinto un David di Donatello nel 1998 come migliore attrice non protagonista e Tullio Morganti è stato premiato come migliore fonico di presa diretta.
Piero Mereghetti definisce Ovosodo (tre stellette) come "un racconto di formazione ed educazione sentimentale, commedia sulle classi sociali ambientata in un'inedita Livorno, un acuto spaccato del presente cui manca solo lo scatto morale e la ribellione: descrive, sorride e assolve. Come la classica commedia all'italiana". Che poi è solo quello che Paolo Virzì vuol fare. Mereghetti riconosce la grande validità del Virzì narratore che in questo caso si fa dare una grossa mano dagli ottimi Bruni e Scarpelli. Alla fine resta solo il dubbio a Piero Mansani che la felicità sia la malattia degli idioti e come sempre la favola è a lieto fine ma dolce amara. Torna l'"ovo sodo", leit motiv del film, bloccato a metà dell'esofago per lui che si è contentato di fare l'operaio a Livorno e di sposare Susy invece di continuare gli studi. Da Ovosodo quartiere di nascita di Piero nella finzione e di Virzì nella realtà, a un "ovo sodo" nella bocca dello stomaco che non va né su e né giù. Meno entusiasta Pino Farinotti che nel suo Dizionario assegna tre stelle al film ma lo definisce "un progetto forse troppo organizzato e furbesco" pure se poi ammette che Virzì funziona e che la sceneggiatura è molto letteraria. Non è poco.
Un film che non ci stanchiamo di vedere e rivedere.
/http%3A%2F%2Fwww.livornomagazine.it%2FGordiano-Lupi%2Ffoto-articoli%2FOvosodo-1.jpg)
Livorno Magazine - Periodico di Informazione
FILMOGRAFIA :. La bella vita (1994) :. Ferie d'agosto (1996) :. Intolerance (1996) :. (episodio "Roma Ovest 143") :. Ovosodo (1997) :. Baci e abbracci (1999) :. My nime is Tanino (2001) :. Caterina
http://www.livornomagazine.it/Gordiano-Lupi/Gordiano-Lupi-Cinema-Virzi-07-Ovosodo.htm
Nessun dolore
È spaventoso come una persona ti esce dal cuore. La guardi e capisci che hai rinunciato a sperare. Non sarà mai come vorresti che fosse. C’è un ponte fra voi, che ogni giorno tu fatichi ad attraversare, ma lei non si sporge mai verso di te. Ti cresce il vuoto dentro, vedi l’abisso che si scava, e ti senti impotente.
Certo, avvocato, certo, lo so che divago, lo so che devo essere precisa. Ricordo bene quando Francesco è venuto a prendermi al lavoro.
Ci siamo fermati alla gelateria Primavera. Mentre io ordinavo due paste, lui si è messo a leggere la Gazzetta dello Sport.
“Ti devo dire una cosa”, ho cominciato. Rigiravo le analisi fra le dita, sotto il tavolino, mi tremava la voce.
“Uhm”, ha fatto lui, senza alzare gli occhi dal giornale. E’ quello che dice quando non mi sta ascoltando.
“Vaffanculo, France”.
“Eh, dicevi?”
“Niente.”
In quel momento gli è squillato il cellulare. Ha risposto piegando appena la testa di lato, come fa quando mi sta raccontando una bugia. “Sì, sì”, ha detto, “ne parliamo con calma domani”, poi ha chiuso la comunicazione.
L’ho guardato senza dire nulla e lui ha abbassato gli occhi. “Chi era?”, ho domandato alla fine.
“Nessuno, la solita grana di lavoro.”
Ho osservato la sua figura, che conosco in ogni minimo particolare, tanto che potrei disegnarla ad occhi chiusi. I bei capelli neri, le lunghe ciglia quasi femminee, l’aria elegante e svagata. “Andiamo a casa”, ho detto, “sento freddo.”
A casa abbiamo parlato del dentista, del lavandino intasato e del veterinario per Bingo, poi, di nascosto, gli ho preso il cellulare dalla tasca e ho premuto ultima chiamata.
Una voce di donna, assonnata e roca. E’ stata la banalità di quella voce ad offendermi.
E poi ricordo anche quella sera, mesi dopo, che sono tornata a casa ed in camera c’era il letto smosso, nel bagno il mio accappatoio non stava dove di solito lo lascio. Lei si era gingillata con i miei trucchi, li aveva aperti, spostati, aveva spruzzato il mio profumo per divertirsi o forse per nascondere il suo odore. Ho trovato Bingo rintanato sotto il letto, l’ho preso in braccio, “mami è qui, è tutto a posto.” Ma non era tutto a posto, no, affatto.
Ancora il telefono, sempre quel cazzo di telefono. “Che succede, France?
“Niente, vai di là, lasciami in pace.”
Sono andata in cucina ed ho cominciato a lavare l’insalata. Lo sentivo camminare in su ed in giù per il soggiorno, sentivo le sue imprecazioni soffocate. “Non puoi farmi questo”.
“Ci sono problemi?” ho domandato. “Nulla che non si possa risolvere, Chiara. Lascia stare quella roba, ti porto fuori a cena.”
Siamo andati al solito posto, lui ha ordinato il pesce ma poi l’ha lasciato nel piatto. Parlava poco, teneva la testa bassa. Gli è squillato ancora il cellulare e ho riconosciuto la voce alterata di quella donna. Ho sentito chiaramente le parole incinta e divorzio.
“Non ci lascia più neppure cenare?” ho domandato. Stranamente, lui non ha negato. Ha calato la testa nel piatto, ha sospirato. “Chiara, sistemerò le cose, dammi un po’ di tempo.”
C’è un tempo per tutto, Francesco, avrei voluto dirgli, e quel tempo per noi è passato. Ma ho imparato che tacere è la via migliore, che è così che si sopravvive.
A casa mi sono piazzata davanti allo specchio e mi sono guardata tutta, dalla testa ai piedi, come per rendermi conto che ci sono. Ho lisciato la pancia che cominciava a soffocarmi. “Cerca di essere felice, Chiara”, mi sono detta, “fallo per te e per il bambino.”
Vede, avvocato, non riesco a provare tenerezza per mio figlio, sono svuotata d’ogni sentimento. L’unica cosa che davvero vorrei è tornare a casa. Se mi permettessero di rientrare, metterei tutto a posto, laverei via quelle macchie. Ho lasciato troppe cose a metà, ci sono ancora le camicie di Francesco da stirare, i pantaloni da portare in tintoria. Mi serve qualcosa di lui da toccare, da annusare.
Tiro fuori di tasca una sua foto e la liscio. E’ più giovane, più magro, con più capelli, sorride a me che lo inquadro. Forse quando gli hanno fatto l’autopsia, mi ha chiamato, forse ha avuto paura. Mi passo la foto sulla guancia ed è fredda.
Perché cazzo non si può piangere un morto da soli?
I morti vanno piombati nelle casse, archiviati in fretta, perché la vita continui, perché si torni al lavoro, a scuola, allo stadio.
Sa, al funerale, la gente passava, posava fiori ai piedi della bara, mi stringeva le mani. “Coraggio, Chiara.” Ma non mi guardavano negli occhi. Qualcuno mi baciava, lasciandomi una scia di saliva sulla guancia che mi pulivo subito, di nascosto, col dorso della mano.
Mia madre parlava con la gente. “Abbiamo preso l’avvocato migliore, questa non mi doveva capitare, non ce la faccio alla mia età.” Mia madre mette sempre se stessa al centro, come se Francesco fosse morto per dare un dispiacere a lei, come se il dolore non fosse mio ma suo.
Io fissavo Francesco, le palpebre semiaperte, le guance incavate, la barba che continuava a crescere anche nella bara. Cosa aveva a che fare col ragazzo che mi mandava mazzi di rose per farsi perdonare, che mi lasciava bigliettini teneri in giro per casa?
Ma sarà vero che i morti sono in pace ?
Gli parlavo. Sai, France, dicevo, sono stata da lei, al suo negozio. Ha detto che mi volevi lasciare dopo la nascita del bambino. Non le ho creduto.
Sì, lei, proprio lei, appoggiata al bancone, indaffarata con i saldi di fine stagione, ha stirato le labbra gonfie, ha strinto gli occhi truccati, ha detto che non eri felice con me.
Dicono che il bambino ha bisogno di sentire il mio affetto, ma che non devo attaccarmici troppo perché me lo toglieranno. Vorrei che fosse ancora dentro di me.
Ho letto articoli su bambini cresciuti in prigione, che chiamano cella la casa, che hanno terrore del mondo di là dalle sbarre, che vengono strappati alle madri in una data ora e in un dato giorno stabiliti dalla legge. Bambini insicuri, traumatizzati, segnati per tutta la vita. Risparmierò questo a mio figlio, lo lascerò andare. Non gli darò nemmeno un nome.
Francesco ed io ci siamo amati, cosa crede, avvocato, i ricordi belli sono tutti lì, se non ne fossi convinta, impazzirei.
Ora vorrei trovarmi al suo posto, senza più pensieri sotto la terra fresca, solo l’odore d’acqua ferma nei vasi e, tutt’intorno, i morti immemori, senza ricordi, senza speranze inutili
Ma, in fin dei conti, si tratta solo di mettere un piede di fronte all’altro, nello spazio ristretto di questa cella, far passare il tempo. Ho persino il lusso di poter piangere da sola, quando le altre sono fuori per l’ora d’aria. Piango solo un poco, piango di nascosto e poi vado avanti. Mi piego ma non mi spezzo, avvocato, tanto, lo sa anche lei, ormai non c’è più niente da spezzare.
Sento le donne che gridano, che si disperano. Io non grido mai, sto sempre zitta, ascolto le voci nella mia testa. “Francesco, Francesco, Francesco”.
Francesco dovrebbe essere anche il nome di mio figlio, ma mi mordo le labbra per non dirlo a voce alta, per non chiamare un bimbo che non mi appartiene, che un’altra alleverà.
Di là da queste sbarre, sento il fischio delle rondini che si abbassano per rincorrere i moscerini. Sono sola, in balia di me stessa. E’ un dato di fatto, avvocato, non c’è niente di male. Nessun dolore, anzi, quasi un senso di trionfo.
Ida Verrei - Recensione
“Peccaminosa”
Di Sandro Capodiferro
Edizioni Libreria Croce
p.p.194
Recensione di
Ida Verrei
…Sono entrata nelle cellule di uomo per vedere come sarebbe andata a finire e lui mi ha riprodotto all’infinito…(pag.10)
…Sono quel peso instabile e controverso, sono lo specchio del gioco perverso, sono la neve che le anime solca, ho solo un nome io, sono la colpa. (pag.194)
E la colpa, il vizio, è il motivo dominante di questa silloge, una colpa letta secondo una prospettiva psicologica, il peccato come riflesso di esistenze strane e remote, quasi sospese in una sorta di sogno o incubo.
Sette donne, sette vite poste a contraltare l’una dell’altra, eppure lontane nel tempo e nello spazio, dall’inizio dell‘800 al secolo attuale, dall’Impero Ottomano, al Cile, passando per Europa e Stati Uniti; sette universi, sette percorsi di peccato e redenzione, destini che si intrecciano legati dalla sottile simbologia di una spilla che intride con delicatezza il tessuto dell’intera narrazione e veicola una carica emotiva che esplode in tutta la sua forza.
Peccaminosa di S.Capodiferro è un libro che racconta storie, ma che soprattutto analizza viaggi interiori, scava nell’animo delle diverse figure femminili, ognuna delle quali incarna un vizio, un peccato, una delle sette P incise sulla fronte di Dante, in un purgatorio fatto di espiazione, riflessione e pentimento.
Abiti del male, li aveva definiti Aristotele; spiriti e pensieri malvagi, li considerava il primo Cristianesimo, causa e origine di tutte le azioni peccaminose. Non è così per l’Autore: ogni peccato, ogni vizio capitale, è espressione della condizione femminile in epoche diverse; affreschi sociali, percorsi, episodi che riflettono mondi ed età lontani, ma con valori universali riconosciuti, appunto, nel momento del riscatto.
Sette i peccati e sette le storie.
Fatma (1809), l’accidiosa: “Qualsiasi cosa accada non voltarti indietro figlia mia. Non farlo mai…”(pag.11) E lei ubbidisce, si lascia trascinare dagli eventi, prigioniera dell’harem e della sua stessa inerzia; rinuncia alla bellezza, alla gioia, all’amore. Una non-vita, sino a condannarsi, infine, ad un triste destino di solitudine e romitaggio: “Passerò i miei giorni nell’attesa che qualcosa accada, spaventata dal solo pensiero che quel qualcosa possa trovarmi tragicamente viva…”(pag.33)
Emily (1854), superba e altera, che scopre nel riconoscimento dell’altro e del diverso la propria fragilità negata e ritrova un’autentica umanità;
E ancora: Ivette (1879) che finisce col comprendere che “l’invidia è l’anestetico dei deboli. Disciolto in rabbia si inetta dritto al cuore dei propri limiti per non continuare a sentirne il dolore”(pag,86)
E poi Mirosalva (1919), la cui ingordigia diviene parossismo anoressico, che la travolge in un “balletto della morte”, nel tentativo di fuggire a se stessa: “Ho cercato di riempire negli anni il vuoto incolmabile nel quale ho sempre navigato…” (pag. 115) ;
E Allison (1947), trascinata allo sbaraglio e alla distruzione dall’ira.
Conchita (1980), l’insolita suora messicana, posseduta dalla brama di possedere, in “ un delirio di riservatezza e di avarizia nel quale nascondeva tutta se stessa, come a proteggersi dal mondo che la voleva sopraffare.” (pag.166)
E infine, Carmela (2007), la lussuriosa, forse la più forte delle figure femminili, quella che incarna il più oscuro dei peccati, ma anche il più seducente; il vizio che avvolge e sconvolge poiché cela abissi, voragini di dolore e solitudine. “Cercare di riempire quei vuoti con i sospiri avidi di tutti gli uomini che mi hanno avuta, è stato come ogni volta scavare ancor di più il fossato tra ciò che non ho mai avuto e ciò che avrei desiderato avere”. (pag. 191)
Storie di donne, abbiamo detto, ma i veri protagonisti sono: amore, distacco, speranza, delusione, rinascita. È la suggestione delle emozioni e dei sentimenti che risolve la disperazione, la rovina, in una voglia di riscatto catartico. Il peccato, umanissimo, è descritto con una sorta di levità, quasi con reticenza. Peccati da compatire, da comprendere, poiché sempre viene riconosciuto il diritto di risalire, di risollevarsi dopo la caduta. Il gioiello che viaggia nel tempo e nello spazio è il simbolo di questo diritto.
Ancora una prova di abilità narrativa da parte di Sandro Capodiferro, un’ulteriore verifica della sua profonda conoscenza dell’universo femminile; un libro singolare che, sino dall’incipit, suscita turbamenti, ma sollecita anche alla riflessione, all’analisi e all’autoanalisi.
I.V.
Marta ci vede
Ore tredici, silenzio rovente, canicola. Pensieri come mosche in una giornata umida.
Mentre parcheggio all’ombra dei pini, mi rendo conto di essermi spinto fino al mare. Da quanto non vengo? Forse dall’ultima volta che ci ho portato Marta.
I pini esalano odore di resina riscaldata, di aghi schiacciati sotto le ciabatte di gomma, di polvere. Se fosse qui, Marta berrebbe l’aria con le narici come una puledra, piegherebbe la testa di lato per ascoltare, toccherebbe la corteccia degli alberi, riderebbe se la resina le incollasse le dita, abbraccerebbe il tronco per capirne l’età. “Questo è proprio tanto vecchio”, direbbe, “ne sento l’energia. Gli alberi sono creature vive ed antiche.”
Come due anni fa, in Sicilia. Sudava sotto il sole, mentre visitavamo la Valle dei Templi. Io leggevo le spiegazioni della guida e lei ascoltava, assorta, rapita.
“È assurdo, a che cazzo serve”, pensavo, ma lei era raggiante mentre allargava le braccia e si distendeva sulle rovine del capitello, per afferrarne l’ampiezza, l’asperità del tufo. “E’ incredibile cosa riuscivano a fare a quei tempi.”
Mi sorrideva dietro gli occhiali da sole grandi e neri. La fotografavo perché era lei a chiedermelo, e intanto pensavo che quelle foto non le avrebbe viste mai, non avrebbe saputo che il naso le si era arrossato, che il petto le si era coperto di efelidi, che il gelato le aveva macchiato la maglietta.
È sempre così entusiasta di tutto, lei.
Mi faccio a piedi il viale fino alla spiaggia infuocata, affollatissima, stringo gli occhi nella calura tremolante. Quasi non vedo il mare, oltre le file degli ombrelloni, ma c’è odore di salmastro, di abbronzanti, di ghiacciolo, di scarpe abbandonate al sole.
Chiudo gli occhi, provo a sentire le cose come le sente lei, ma la tristezza mi chiude la gola. Se fossi un insetto, penso, vedrei il mondo attraverso occhi dalle mille sfaccettature. Non sarebbe il mondo che conosco io.
Mi spoglio. Gli slip neri possono sembrare un costume, e comunque me ne frego. Cammino a lungo prima che l’acqua mi arrivi al petto. Nei passi faticosi verso il largo, rivedo mio padre che fa arselle col setaccio grande, e mia madre col costume intero, i piedi larghi e forti, le spalle fiere. Mi sento solo, come non lo sono mai stato, solo con tutte le responsabilità.
Mi tuffo, l’acqua mi fa rabbrividire, avanzo a bracciate verso il nulla, nuoto fino a che il bagnino non comincia a fischiare per richiamarmi indietro.
Sono disperato, non c’è nulla che voglia fare, nulla che ami, nulla che desideri.
“E’ depressione, Gianfranco”, mi ha detto Roberto, che è medico ed anche mio amico. “Stare accanto ad una moglie non vedente è difficile, lo capisco. Ora ti segno delle pillole, ma tu fatti forza.”
“Maledizione, Roberto. Non mi servono farmaci. Non sono depresso.”
Roberto ha scosso la testa. “Pensa a Marta, Gianfranco. E’ cieca da dodici anni, dal giorno dell’incidente, ma non ho mai conosciuto qualcuno con tanta voglia di vivere. Lei ti ama, non dimenticarlo.”
Marta mi ama. Sono fortunato. Quella sera guidavo io.
Non riesco più ad alzarmi la mattina ed in quest’acqua ci vorrei annegare.
Marta è cieca. No, non è vero. Marta vede in un altro modo, vede col cuore, con l’anima, con i sensi. Lei vede più di me, vede tutto quello che io non so più vedere. Lei vede il bene della vita che io ho perso.
Mi volto e torno a riva così veloce da sfiancarmi, fino a che i miei piedi non toccano di nuovo la sabbia piena di buche, di mulinelli, di tracine brucianti. Piena di cose vive.
Mi rivesto senza nemmeno asciugarmi.
Chissà, magari, sulla strada del ritorno mi fermerò in farmacia.

/image%2F0394939%2F20190531%2Fob_6113d1_61425960-10216728261030327-19684367693.jpg)



