saggi
Tolkien e la critica
/image%2F0394939%2F201302%2Fob_1874419f680ae797238da06ce1f59964_download-1.jpg)
Dalla sua pubblicazione (1954) fino a oggi, The Lord of The Rings di Tolkien ha suscitato opinioni controverse riguardo al genere letterario cui l’opera appartiene.
Fra coloro che lo ritenevano attribuibile a un genere specifico e soltanto a quello, il critico di maggior rilievo è senz’altro il canadese Northrop Frye che in The Secular Scripture del 1976, all’interno di una rivalutazione e delimitazione della tradizione del romance inglese, affermava: “Nel ventesimo secolo, il romance ritornò di moda dopo la metà degli anni 50, con il successo di Tolkien e l’ascesa di ciò che comunemente viene denominata fantascienza”. Frye quindi considera sia le opere tolkieniane sia quelle di scrittori di fantascienza alla stregua di sottogeneri del romance, per la presenza in essi di meccanismi tipici del romance stesso quali la polarizzazione (netta divisione fra personaggi positivi e personaggi negativi), la quest, il lieto fine.
Edmund Wilson, nel famoso articolo apparso su Nation nell'aprile 1956, OO those Awful Orcs, che ne ha fatto il caposcuola di una serie di detrattori, considerava The Lord of The Rings un libro per bambini, attribuendo a tale definizione tutte le valenze negative possibili. Per Wilson, The Lord of the Rings non era che una “fiaba” leggera e fatua. Sulla scia di Wilson, un recensore del Times Literary Supplement prediceva nel 1955, per altro con scarse capacità divinatorie,
this is not a work that many adults will read right through more than once
relegando anch’egli l’opera nella stanza dei bambini.
Altri commentatori, pur inserendo The Lord of the Rings nel solo genere della fiaba, non davano a questo inserimento valore spregiativo. Fra questi, Michael Tolkien, secondogenito dello scrittore, che così si esprimeva sul Daily Telegraph:
I feel certain that it was, in the first place, on account of our enthusiasm for story told and invented by my father, that the inspiration came to him to put in permanent shape what he so rightly regarded as the type of fairy story real children really want.
Un’opera diretta ai bambini dunque, ma quelli che ragionano e sentono come adulti. Un contributo italiano è l’opinione di Oriana Palusci, secondo la quale Tolkien ha compiuto una “ricerca attraverso i materiali della fiaba” per giungere a qualcosa di differente.
Un altro gruppo di critici evita di inserire The Lord of the Rings in un genere preciso, considerandolo un’opera sincretica che riunisce caratteristiche di generi disparati. Leggenda e fiaba, tragedia e poema cavalleresco, il romanzo di Tolkien è in realtà un’allegoria della condizione umana che ripropone in chiave moderna i miti antichi. Ecco cosa si legge sulla copertina dell’edizione Rusconi di The Lord of the Rings curata da Elemire Zolla, il critico italiano che maggiormente ha preso in considerazione Tolkien. Qui, arbitrariamente e confusamente, si parla di un “romanzo” che avrebbe come argomento una “leggenda” ma che può essere anche considerato una “fiaba”, o una “tragedia” (senza considerare che, a causa del lieto fine la fiaba esclude la tragedia) o, infine, una “allegoria” basata su di una “mitologia” riproposta in chiave moderna. Che esista un sincretismo nell’opera di Tolkien è evidente, ma la definizione di Zolla, pur contenendo un innegabile nucleo di verità, così come si presenta, ingenera più confusione che chiarezza. Più cauta e precisa Verlyn Flieger che, fra i critici che si sono interessati all’opera di Tolkien ha dato, secondo noi, le interpretazioni più sottili, raffinate ed esaurienti. Questa la sua opinione:
I do not propose to assigne The Lord of the Rings to a particular genre such as fairy tale, epic, or romance. The book quite clearly derives from all three, and to see it as belonging only to one category is to miss the essential elements it shares with the others.
Simile a quella della Flieger l’opinione di J. Mc Kellan
The Lord of the Rings is a special kind of fiction, midway between medieval romance and modern novel.
“A special kind of fiction”: ecco la chiave per l’interpretazione dell’opera di Tolkien. The Lord of the Rings appartiene a un genere nuovo che nasce dall’unione di caratteristiche di più generi, quali la fiaba popolare, l’epica medievale, il romanzo (inteso nei suoi due sottogenri di romanzo d’avventure e romanzo psicologico moderno) il tutto tenuto insieme e amalgamato da uno spirito moderno che dà importanza ai problemi e ai valori dell’uomo.
Una categoria di critici individua questo genere nuovo nel fantasy e costruisce una tradizione di opere fantasy in cui inserire quella di Tolkien. Così Irwin accomuna Tolkien ai suoi amici “Inklings”, C. Williams e C.S. Lewis, sostenendo che
all have (…) a way of absorbing variant straints of myth into a general Christian oriented pattern, which reveals a clear artistic, and perhaps also doctrinal syncretism.
Manlove, dopo aver dato una definizione del fantasy molto accurata, e aver individuato altri scrittori afferenti allo stesso genere, analizza purtroppo l’opera tolkieniana in modo piuttosto superficiale, e sembra non raggiungere un’effettiva comprensione della sua portata fondamentale proprio all’interno del genere che egli va individuando.
A sua volta, Patrick Grant costruisce una tradizione inglese in cui inserire Tolkien, che spazia dalle Nursery Rhymes di Mother Goose ad Alice in Wonderland di Carrol, ai Jungle Books di Kipling e afferma che:
Fantasy in The Lord of the Rings has been pushed to its logical limits, beyond Kipling, and beyond Carrol too, finally presenting itself to itself as a peculiar combination of literary conventions.
Ma qual è l’opinione di Tolkien? Nel 1950 così egli presentava il suo libro agli editori:
il mio lavoro è sfuggito al mio controllo e ho prodotto un mostro: un romance estremamente lungo, complesso, piuttosto amaro e piuttosto terrificante, inadatto a ragazzi (ammesso che sia adatto a qualcuno).
E ancora, in una lettera a Manlove del 1967, affermava
The Lord of the Rings fu un tentativo intenzionale di scrivere una fiaba per adulti.
Queste due definizioni indicano l’incertezza di Tolkien stesso riguardo all’attribuzione della sua opera a un genere preciso. Ciò conferma il carattere sincretico di tale opera che usufruisce di stili, motivi e tecniche propri di generi diversi. La seconda affermazione poi, contiene un elemento fondamentale per la nostra ricerca. “Una fiaba per adulti” dice Tolkien. Da questa definizione partiremo per vedere in cosa quest’opera magmatica possa essere considerata una fiaba e come Tolkien abbia sfruttato il materiale fiabesco indirizzandolo ad un pubblico adulto. The Lord of the Rings è complesso, sfaccettato, concerne valori esistenziali di notevole profondità, tali da avvicinare l’opera al romanzo moderno.
/http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-sUuBdq0lSKs%2FT3BIseCs1-I%2FAAAAAAAABMs%2Fttq_SFxJESQ%2Fs400%2Fsig1%2B%281%29.JPG)
CriticaLetteraria: #TolkienWeek: Una fiaba per adulti. 1. Tolkien e la critica
Dalla sua pubblicazione (1954) fino a oggi, The Lord of The Rings di Tolkien ha suscitato opinioni controverse riguardo al genere letterario cui l'opera appartiene. Fra coloro che lo ritenevano ...
http://www.criticaletteraria.org/2012/03/criticalibera-una-fiaba-per-adulti-1.html
I MITI DEL MEDITERRANEO
I miti del Mediterraneo
Il presente col suo pesante bagaglio (minacce di guerra, guerre in atto, profughi, esiliati, condizione dell’extracomunitario, donne tradite e violentate, bambini vilipesi) rispecchiandosi nei drammi del passato, può trovare nel racconto degli anziani l’anello di congiunzione sulle tematiche in questione e i giovani grazie sia all’autorità dei testi classici, sia al racconto (storia, favola, leggenda) spesso vibrante di emozionanti ricordi di chi ha vissuto in prima persona esperienze dolorose potranno trovare nella “memoria” appunto, se non la soluzione ai loro interrogativi, almeno una spinta a far meglio.
Ma più di ogni altro oggi è gravemente presente, anche nel nostro Paese, il fenomeno degli immigrati, una moltitudine di persone che per vari motivi abbandonano il loro paese d’origine e cercano una vita migliore altrove solcando le onde del Mediterraneo. Non sempre trovano accoglienza, non sempre raggiungono altre terre dove vivere e lì fondare casa, famiglia, futuro.
Non sempre si ravvisano in questi popoli in movimento i segni del nostro passato.
A questo punto ci soccorre il mito: il mito è la memoria, il riferimento unico quando si voglia scoprire il senso delle radici, come senso di appartenenza. Ma il mito è anche favola dalle valenze simboliche e sacrali. Il mito è la speranza che si tramuta in sogno, è il sogno che perpetua la speranza. Il mito permette di andare oltre la cronaca, di superare le barriere del Tempo, costruendo un bagaglio di ricordi che costituiscono la memoria storica, senza la quale non solo non è l’uomo, ma neppure una società, un popolo.
L’andare verso terre è penetrare il senso della storia. Una storia che si raccoglie appunto nella nostalgia perché è fatta di mito, di simboli, di echi. E di quel mondo noi abbiamo raccolto i profili, il sentimento del destino, il sacro e le proiezioni della divinità, l’amore e l’eros, l’eroismo, l’attesa. Si tratta solo di riconoscersi in esso.
Forse la perdita di senso dell’età contemporanea è anche nello smarrimento delle radici primordiali a cui la vita tende. I conflitti che agitano l’uomo contemporaneo forse dipendono anche dalla perdita della fantasia, quella che sconfigge la storia e quindi la morte, creando personaggi e racconti nella favola, che, proprio perché tale, ritorna sempre nel suo tessuto poetico, passando di generazione in generazione e coltivando così la memoria.
Pertanto solo attraverso il recupero di una dimensione mitica si può penetrare la crisi dell’uomo e superarla. Perché il mito è oltre la storia, è la sacralità che vive il tempo abbandonandolo e ritrovandolo. Non può esserci memoria senza mito. I popoli e gli uomini si ritrovano allora soltanto nella memoria.
Questo è vero per ogni latitudine, dovunque ci sia un territorio da dove uomini e donne sono partiti, lasciando lì le loro radici per piantare germogli altrove. Spesso il percorso lungo il quale interi popoli si sono mossi è stato un percorso di acqua, di fiumi, più spesso di mari.
Anche il Mediterraneo è stato ad un tempo elemento di approdo e di partenza. Il Mediterraneo non solo viaggio; soprattutto attesa.
Il Mediterraneo ha conosciuto e conosce tuttora l’incontro e lo scontro tra civiltà. Il Mediterraneo antico fu greco, fenicio-punico, romano. Tutto un mondo arabo si trovò a fare i conti con diverse identità. Bisogna saper cogliere quella eredità: un’eredità la cui chiave di lettura è nell’interpretazione dei miti, che ci raccontano delle avventure dei popoli.
E il mito mediterraneo per eccellenza è quello di Ulisse, seguito da quello di Enea. Il loro viaggio si compie per mare, esso rappresenta il futuro. Entrambi gli eroi hanno in comune l’esperienza di navigazione, dei ritorni avventurosi e delle sofferenze sia di chi anela a ritornare nella propria patria lontana, sia di chi, sopravvissuto alla guerra, desidera trasmigrare in nuove sedi.
Sono essi dunque i simboli che ci permettono di captare il nostro essere nel tempo, che custodiscono la memoria delle nostre radici mai recise, e che attraverso le epoche tramandano, come onde sonore, suoni di viaggi, di naufraghi, di migranti.
L’eredità è saper riconoscere queste voci che ci suggeriscono nuovi percorsi, che dentro la memoria ridisegnano il futuro. Un futuro che ora come allora è dipinto di nostalgia, che contrappone al canto delle Sirene il muto dolore dei naufraghi che a migliaia tentano di approdare a nuove rive.
Ma c’è di più. Non interessa sapere se Ulisse sia un personaggio reale o frutto di fantasia. Ci appassiona la nostalgia del suo nostos, che è testimonianza di un tempo archetipale che traccia misteri, segni, luoghi e fa della nostra ricerca un viaggio per tentare di catturare i segreti di quell’isola che è il nostro destino, dei destini che diventano avventure. Gli eventi condizionano tutto il percorso. Il mito allora come rivisitazione degli eventi.
Il viaggio di Ulisse si risolveva in un’avventurosa peregrinazione per i mari le isole i porti del Mediterraneo; Enea, viceversa, edifica nel suo itinerario una biografia etico-religiosa con finalità politico-universalistiche.
L’ Odissea insegna negli avvenimenti di Ulisse, e nella sua saggia condotta, la sapienza privata appresa dalla lunga conoscenza del mondo e dalla conoscenza della fortuna, le cui vicende, come spesso dal sommo della felicità ci urtano nel sommo delle disgrazie, così dal fondo delle disgrazie ci sollevano al sommo della felicità; in modo che né sicuri delle cose prospere dobbiamo vivere, né abbandonarci nelle avversità; ma piuttosto armarci di fortezza, per resistere e riservarci allo stato migliore. Perciò Ulisse sbattuto dai venti, minacciato dai pericoli, allontanato dalla patria da tante tempeste, pur non si perde mai d’animo: come avvenne quando, partito da Calipso, scampato agli inganni di Circe, all’empietà di Polifemo, alla crudeltà dei Ciconi, alle lusinghe delle Sirene, e ad altri travagli, fu alla fine della tempesta portato alla regione dei Feaci dove, ristorato da Nausicaa, fu accolto dal re Alcinoo e rimandato felicemente a casa.
Ora le avventure di Ulisse possono ben rappresentare il repertorio più completo della realtà umana: un inventario della vita e del destino, che si esplicano in esperienze e caratteri d’apertura universale. E dietro le figure e le peripezie di Ulisse e dei compagni, nella parabola delle sorti individuali, si riflette l’infinita trama dell’essere.
A distanza di tanti secoli la vetusta poesia omerica continua a trasmettere gli “esemplari” dell’umanità; e alla nostra sensibilità palesa una vigorosa dimensione di realismo proiettata in una dimensione leggendaria. Secondo Manara Valgimigli Ulisse rimane “la figura più ricca di umanità che la poesia greca abbia creato, nella sua ricchezza singolarissima di prudenza e di coraggio, di curiosità e di intelligenza, di generosità impetuosa e di calcolata freddezza, di fiducia e di dubbio, di caldissima e nobilissima astuzia”.
Egli ha capito che la vita è conoscenza, ma anche memoria e rispetto della propria intimità, degli affetti originari, della casa avita.
All’opposto di Ulisse che circumnaviga le terre mediterranee per concludere la vita nel ritorno, il destino di Enea nasce dalla distruzione, dalla fuga e dall’esilio definitivo. Troia brucia, c’è il massacro dei vinti. Enea fugge dalla sua terra e comincia a percorrere una nuova rotta; perduta ogni speranza cerca nuove radici. La patria, i Penati, gli affetti se li porta con sé verso l’ignoto, ma con l’idea della terra promessa e l’occulto progetto di fondare una nuova patria e un nuovo ordine.
Nell’Eneide il destino si fa storia e civiltà, e queste sono dirette da un’idea di progresso e d’universalità. È la prima volta che un organismo mitico-letterario si assume il ruolo della missione storica e si ipostatizza a capostipite di una tradizione secolare.
L’esperienza dell’eroe non può dissociarsi da un significato simboleggiante che la supera. È la prima volta che il personaggio incarna un’idea e si identifica con lo spirito della storia. Egli edifica nel suo itinerario una biografia etico-religiosa con finalità politico-universalistiche.
Gli incontri che Enea fa nel panorama geografico non hanno più nulla della curiosità leggendaria implicita nei viaggi di Ulisse. Il rapporto che egli inaugura con la realtà si fonda ogni volta su una situazione di coscienza. Enea compie il suo viaggio non per cercare la morte, ma per impossessarsi della vita attraverso il Tempo. Non aveva un’Itaca da ritrovare ma una patria da rifondare. Anch’egli però si trova tra le acque a remare e, una volta approdato in terraferma il suo destino è quello di creare la dimensione della rinascita., di costruire il futuro con dentro gli occhi l’identità della perdita.
Rileggere oggi questi miti non è soltanto un tuffo in una visione archeologica, ma è sostanzialmente qualcosa di più. È un viaggio nel quale l’appartenenza oltre ad essere una metafora è una costante nostalgia.
L’uomo di una civiltà perduta (orfano e senza progetti) va alla ricerca della sua identità. Ma la sua identità è nella storia del tempo.
Enea ed Ulisse lo hanno testimoniato. L’uno, andando alla ricerca di una nuova patria da edificare sull’immagine di quella distrutta. L’altro andando alla ricerca del ritorno. Ma in entrambi il ritorno alle antiche origini ha rappresentato l’asse dominante intorno al quale far ruotare la coscienza dell’essere e del tempo.
Enea ed Ulisse navigano ancora le acque di questa civiltà? O vanno alla ricerca, come noi, di una nuova età?
L’anima del mondo ha sempre più bisogno di restare fedele a un’identità. La certezza dell’identità sta nel saper riandare alle origini della coscienza. Enea ed Ulisse sono i simboli dell’esistenza e del destino dell’uomo e della sua capacità di essere e di comprendere la solitudine e l’angoscia del tempo, ma anche le ragioni della rinascita di questa coscienza.
Se li rimeditiamo, forse saremo in grado di meditare noi stessi, dispersi nella civiltà della non identità e del progresso, incapaci di comunicare in una stagione della società definita troppe volte della comunicazione totale.
Abbiamo tutti bisogno di radici perché “siamo tutti inseguiti dalle nostre radici” (E.M.Cioran).
E abbiamo bisogno di memoria per capire ciò che siamo stati e per identificare ciò che siamo.
La nostalgia di una civiltà! Una nostalgia che i popoli mediterranei rincorrono. Una nostalgia che è dentro il viaggio di quelle culture e il vivere di quelle culture che hanno avuto e hanno come riferimento il mare.
Il mare è il punto di contatto certo dell’identità della mediterraneità. I popoli che costeggiano il mare sono popoli che hanno conosciuto l’attesa, la partenza e il ritorno. Sono popoli che non dimenticano. La continuità tra i popoli è la riaffermazione di quei valori che hanno fatto del Mediterraneo un centro di culture.
Riscoprire i miti significa dunque riappropriarsi degli archetipi che mancano ad una società ormai desacralizzata. I miti sono la decodificazione di un vissuto, sono nel fascino e nel mistero, sono quella quotidiana attesa nella quale ci ritroviamo.
E l’Europa sarà capace di rispondere alle sfide del mondo moderno solo se sarà capace di difendere la sua cultura. E la sua cultura si difende se tutti saremo capaci di riappropriarci della tradizione e rendere questa tradizione identità del (e per il) futuro.
Mostre: Il viaggio nel Mediterraneo di un Ulisse clandestino - Albania - ANSAMed.it
(di Luana De Micco) (ANSAmed) - MARSIGLIA, 14 GEN - Un Ulisse clandestino dei giorni nostri, senza nome e senza documenti, si imbarca per un viaggio nel Mediterraneo, facendo scalo nelle sue citta'
Rai Eri: la televisione da leggere
/image%2F0394939%2F201302%2Fob_e1ac89faaca67cbdfe5690c0549ce3e6_img.jpg)
Chi ha una nonna con il grembialetto come armatura e il mestolo brandito a mo’ di spada, si sarà forse accorto che il leggendario Artusi è stato sostituito ormai ai fornelli dai libri de La prova del cuoco, a marchio Eri Rai. Eri è il marchio editoriale con il quale la Rai pubblica libri, riviste e prodotti multimediali connessi con la sua programmazione, sfornando una media di cinquanta testi l’anno e definisce se stessa “La Rai da leggere”.
L’inizio dell’attività editoriale della Rai risale al gennaio del 1925, con la pubblicazione del settimanale “Radio Orario” che riportava i programmi delle stazioni radio italiane ed europee. Nel 1930, “Radio Orario” con l’EIAR divenne il Radiocorriere e nel 1954 il Radiocorriere TV.
Il 15 settembre del 1949 si costituì la società ERI Edizioni Radio Italiana che produsse molte collane. Si spaziava dall’arte alla letteratura, dai libri per ragazzi ai corsi di lingue. Scrissero per la Eri autori del calibro di Emilio Cecchi, Carlo Emilio Gadda, Mario Praz, Folco Quilici, Natalino Sapegno, Giorgio Saviane, Giani Stuparich, Demetrio Volcic. Al Radiocorriere si aggiunsero riviste specializzate fra le quali “L’Approdo letterario” e “L’approdo musicale”.
Dagli anni 90 Eri pubblica i libri delle trasmissioni più importanti e reportage giornalistici a firma Enzo Biagi, Bruno Vespa, Sergio Zavoli, Piero Angela, Antonio Caprarica. Dal 1996 ha ceduto l’attività editoriale alla capogruppo Rai.
In particolare vogliamo riferirci qui a un periodo in cui la Rai ancora assolveva diligentemente il suo compito di funzione pubblica, di alfabetizzazione di massa, di didattica popolare.
Nel 1970 uscì un libro collegato strettamente a una trasmissione molto seguita dagli adulti ma anche da qualche bambino curioso e precoce. Il testo s’intitolava En Français, era una coedizione con Le Monnier, e si legava all’omonimo corso di lingue, basandosi su una serie di film pedagogici prodotti dal Ministero degli Affari Esteri francese per l’insegnamento della lingua nel mondo.
Era un’epoca, quella, in cui il francese ancora contendeva il primato all’inglese come lingua straniera indispensabile, sebbene l’inglese cominciasse ad avere quell’ammiccante bagliore di modernità che tanto ci affascinava, collegato alla swinging London, ai Beatles e alle minigonne di Mary Quant.
Il libro si articolava in due volumi, riportando i dialoghi dei micro film della trasmissione, piccoli sketch ambientati nella Francia tradizionale. C’era un intermezzo in cui veniva illustrato il contenuto lessicale del testo e una parte successiva in cui i vocaboli erano inseriti in un contesto più moderno. Seguivano poi esercizi linguistici e grammaticali.
“Né le trasmissioni, né il libro”, è spiegato nell’introduzione, “hanno lo scopo di insegnare una grammatica. Gli esercizi stessi non sono esercizi grammaticali, ma tendono, attraverso la ripetizione, alla “fixation”delle forme studiate.” (pag. 4)
Pur con molta cautela, possiamo trovare qui il nucleo del moderno insegnamento delle lingue, quello che non si basa più sull’apprendimento di regole grammaticali, bensì sull’immersione con uso contestuale delle formule linguistiche. A nostro avviso, questo metodo, portato poi alle estreme conseguenze, ha creato più danni che benefici, impedendo la destrutturazione delle frasi, l’analisi logica e grammaticale, la distinzione fra soggetto, predicato e complemento, riportando l’apprendimento a un pre-razionale incamerare frasi fatte, valido per chi operi davvero in un contesto di full immersion (o per i bambini molto piccoli dal cervello plastico) ma non nelle poche, sbrigative, ore concesse dal ministero alla didattica delle lingue straniere.
Il corso di francese andava in onda nel primo pomeriggio ed univa adulti e bambini, le mamme lo seguivano rispolverando ricordi di scuola, ai ragazzi piacevano le scenette - fra pecorelle e fiere di paese, fra trattorie campestri e ricette di cucina – guardandole assorbivano parole e modi di dire, affascinati dalle storie ironiche, dalla vita quotidiana, dal ragazzino che nell’intermède girava le caselle del quadro a pannelli mobili.
Non mancavano, alla fine di ogni lezione, pezzi scritti in italiano (per essere ben comprensibili a tutti) sulla Francia contemporanea, volti ad attirare il turismo internazionale, denunciando forse quale fosse, in realtà, il vero scopo della pur lodevole iniziativa. Ma a noi non interessa questo, a noi piace ricordare l’ansia con la quale aspettavamo l’inizio della trasmissione nel dopopranzo, la gioia con la quale prendevamo in mano il librone ad essa collegato – pesante tomo bianco bordato di giallo col profilo della Francia in copertina – la soddisfazione quando riuscivamo a capire tutti i brani che ritrovavamo scritti dopo averli uditi in televisione, arrivando a leggerli, a pronunciarli correttamente, a ricordarli, a farne un patrimonio personale al quale poi avremmo sempre attinto.
Insomma, il corso di francese Eri Rai (Le Monnier) appartiene al quel bagaglio di conoscenze che, una volta acquisite, non ci lasciano più per la vita.
/http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-IKRbWEJFV1U%2FUIplI8uP4XI%2FAAAAAAAAAJY%2FCgOx-hxaGa4%2Fs320%2FIMG.jpg)
CriticaLetteraria: Come eravamo: Rai Eri, la televisione da leggere
Chi ha una nonna con il grembialetto come armatura e il mestolo brandito a mo' di spada, si sarà forse accorto che il leggendario Artusi è stato sostituito ormai ai fornelli dai libri de La prova...
http://www.criticaletteraria.org/2012/11/come-eravamo-rai-eri-la-televisione-da.html
Liala, un caso editoriale del tempo che fu

Dopo il 1950 viene a cadere il disprezzo vociano per il romanzo borghese, che aspira ormai a far parte della letteratura. Ma prima, nel periodo fascista e anche oltre, si ha una netta divisione fra letteratura di massa e d’intrattenimento, con romanzieri a grande tiratura (Zuccoli, D’Ambra, Pitigrilli, DaVerona) e romanzi scritti da intellettuali per altri intellettuali (Gadda, Landolfi, Bilenchi, Vittorini, Bersani).
Si ha così la formazione di un doppio mercato della letteratura. Mentre Guido da Verona vende due milioni e mezzo di copie, grazie soprattutto al successo di Mimì Bluette fiore del mio giardino, Palazzeschi, Moravia de Gli indifferenti, e Bontempelli restano sempre sotto le centomila copie. Solo Sorelle Materassi sfiora quota duecentomila.
Nella prima metà del secolo, la narrativa di successo continua a praticare strutture già sperimentate alla fine dell’ottocento, con l’aggiunta di nuovi generi come il romanzo eroico fascista, quello “pornografico” di Pitigrilli, quello umoristico di Achille Campanile e, infine, quello rosa.
È del 1931 il primo romanzo di Liala, pseudonimo di Liana Cambiasi, Negretti Odescalchi. (1897 – 1995)
“Nacqui a Carate Lario”, ci dice, “nella bella villa che i nonni avevano sul lago.” Si sposa giovane col marchese Cambiasi ma il matrimonio non funziona e Liala trova l’amore in un giovane aviatore, Vittorio Centurione Scotto, dal quale ha una bambina. Purtroppo, nel 1926, l’ufficiale muore in un incidente, precipitando nel lago con l’aereo, e Liala sfoga il suo dolore scrivendo il suo primo romanzo: Signorsì, “per non impazzire”, dice. Il romanzo ha per argomento l’aviazione, tema mai trattato da una donna prima di allora e ha un immediato successo di pubblico.
“Al mio pilota devo la celebrità. Fu per essere ancora con lui che scrissi Signorsì, che mi rese subito celebre, perché parlavo di quei voli che lui amava tanto. Ma il nome “Liala” lo ebbi da d’Annunzio. Prima ancora che Signorsì uscisse, il grande Arnoldo Mondadori aveva parlato a d’Annunzio di una giovane donna che aveva scritto un romanzo aviatorio, cosa eccezionale per quei tempi. Il Comandante volle conoscermi: andai al Vittoriale con Mondadori e, firmandomi una sua fotografia, immediatamente d’Annunzio mutò il mio Liana in Liala: perché, disse, un’ala sta bene nel nome di chi parla con tanto amore di ali. Vi mise un’ala e io volai.”
Dopo venti giorni l’editore le telefona sconvolto: la prima edizione è già esaurita.
Dal 1930 al 48 si lega sentimentalmente ad un altro ufficiale, Pietro Sordi, sebbene il marito l’abbia riaccolta e le abbia dato un’altra figlia.
Oltre all’ambiente militare, ai singoli personaggi, come Lalla Acquaviva protagonista dell’omonima trilogia, oltre alle trame, ciò che ci resta dei suoi romanzi è più l’immagine di uno stile, fatto di molteplici sfumature.
Innanzi tutto i personaggi. Che siano ufficiali come Furio di Villafranca, oppure pittori come Milo Drago o scultori, sono sempre aristocratici, alti, belli - mori con gli occhi azzurri o biondi con gli occhi neri - capaci di dominarti con lo sguardo (niente a che vedere col sadico Christian Gray) di corteggiarti con gesti galanti che hanno nel loro stesso dna.
Le donne sono modelle dai capelli color fuoco e gli occhi verdi, oppure timide fanciulle pudiche, con le trecce e lo sguardo basso. Hanno nomi altisonanti e strani – si dice presi da riviste d’ippica: Beba, Coralla, Pervinca, e aspetto più sanguigno e d’Annunziano che preraffaelita.
“Diede un’ultima spazzolata ai capelli vaporosi, leggeri e ondulati, che le sfioravano le spalle, si umettò le labbra. Infilò il soprabito. Sul turchino scuro della stoffa pesante, sfavillarono i meravigliosi capelli fulvi, d’un bel fulvo cupo, che incorniciava divinamente il volto bianco, sul quale le labbra rosse, colme di sangue sano e violento, mettevano una viva nota di ardente colore.” (Da L’Arco nel cielo)
Gli ambienti sono descritti con visiva ed estetizzante minuzia che fa appello a tutti e cinque i sensi. Di architetture, arredamenti, abbigliamento, cibo, è mostrato ogni particolare. Le tavole sono apparecchiate sontuosamente, oppure in modo campestre, il pane è fragrante, il pollo croccante. Si sentono profumi penetranti, rumori, odori, si vedono i colori risaltare l’uno sull’altro come in un quadro.
“Sopra una tovaglia bianca, di bella tela di Fiandra, aveva messo piatti e bicchieri quasi lussuosi, le posate erano di metallo vile, ma lucenti e deterse. Soltanto, in mezzo alla tavola, si ergeva un vasetto d’argento, in cui era immerso un crisantemo viola.” (da Melodia dell’antico amore)
“Un gran silenzio pesò su tutte le cose, dominò nella sala. E in quel silenzio, s’udì il ticchettio di due orologi. Quello piccolo che stava su una tavola dall’opalina color topazio, e quello grande, elettrico, incastrato nel muro dell’anticamera. Due suoni cadenzati e dissimili che davano il senso della fugacità del tempo.” (Da Come i baci sull’acqua)
La sensualità che trasuda dalle scene è prepotente quanto trattenuta.
“Camminavano vicini, vicini, quando il vento sollevava il soprabito di Mabel lo portava a sfiorare le gambe di Arno Dala. E lui, per quella carezza dell’abito della donna amata, godeva.” (Da Come i baci sull’acqua)
L’erotismo si concretizza in “sangue che scorre più veloce nei polsi”, in torbidi sguardi, in un desiderio represso ma tangibile, che faceva temere a quelle stesse madre e nonne - che ci passavano i libri sui quali avevano pianto e sognato di nascosto - che la lettura fosse troppo azzardata per delle signorinette, volendo restare in tema e citare Wanda Bontà.
“Il suo viso portava le tracce della lunga notte d’amore, ma gli occhi erano pieni di gioia. Mai, come quella notte, Beba era stata sua, mai aveva avuto così forte e terribile la sensazione del possesso. La placida sensualità di Beba aveva avuto guizzi e fremiti, le belle carni s’erano insolitamente animate, e mai il viso di Beba era stato così sciupato e devastato dai baci.” (Da Signorsì.)
Lo stile è pulito ma ridondante, pletorico, giocato sui sinonimi: “Voglio sapere che lingue parlate, quali idiomi conoscete.”
Liala è una scrittrice sottovalutata, una narratrice abile, capace di farti vedere, sentire e toccare ciò di cui racconta, capace di creare atmosfere che non si dimenticano. È esponente a tutti gli effetti del decadentismo, colto nei suoi aspetti estetizzanti, barocchi, a tinte forti fatte di sesso, di amore e morte, di grandi passioni ultraterrene (Lalla che torna), di uomini libertini alla ricerca di fanciulle pure, di vergini da sgualcire.
After 1950 contempt the bourgeois novel fell, the same that now aspires to be part of literature. But first, in the fascist period and beyond, there is a clear division between mass literature and entertainment, with large-scale novelists (Zuccoli, D'Ambra, Pitigrilli, DaVerona) and novels written by intellectuals for other intellectuals (Gadda , Landolfi, Bilenchi, Vittorini, Bersani).
Thus there is the formation of a double market for literature. While Guido da Verona sells two and a half million copies, thanks above all to the success of Mimì Bluette flower of my garden, Palazzeschi, Moravia de Gli indifferenti, and Bontempelli always remain below one hundred thousand copies. Only Sorelle Materassi touches two hundred thousand.
In the first half of the century, successful fiction continues to practice structures already tested at the end of the nineteenth century, with the addition of new genres such as the heroic fascist novel, the "pornographic" novel by Pitigrilli, the humorous one by Achille Campanile and, finally , the pink one.
Liala's first novel - pseudonym of Liana Cambiasi, Negretti Odescalchi - is from 1931. (1897 - 1995)
"I was born in Carate Lario", she tells us, "in the beautiful villa that the grandparents had on the lake." She marries with the Marquis Cambiasi but the marriage does not work and Liala finds love in a young aviator, Vittorio Centurione Scotto, from whom she has a baby girl. Unfortunately, in 1926, the officer died in an accident, crashing into the lake by plane, and Liala vented her pain by writing her first novel: Signorsì, "not to go crazy," she says. The novel has aviation as its subject, a theme never discussed by a woman before and has immediate public success.
“I owe celebrity to my pilot. It was to be with him again that I wrote Signorsi, which made me immediately famous, because I was talking about those flights that he loved so much. But I got the name "Liala" from d'Annunzio. Even before Signorsì came out, the great Arnoldo Mondadori had spoken to d'Annunzio about a young woman who had written an aviation novel, something exceptional for those times. The Commander wanted to get to know me: I went to the Vittoriale with Mondadori and, by signing a photograph of me, immediately d 'Annunzio changed my Liana to Liala: because, he said, a wing is well in the name of those who speak with love of wings. He gave me a wing and I flew. "
After twenty days the upset publisher calls her: the first edition is already sold out.
From 1930 to 48 she was romantically linked to another officer, Pietro Sordi, although her husband accepted her again and gave her another daughter.
In addition to the military environment, to individual characters, such as Lalla Acquaviva the protagonist of the trilogy with the same name, in addition to the plots, what we have of her novels is more the image of a style, made of multiple shades.
First of all the characters. Whether they are officers like Furio di Villafranca, or painters like Milo Drago, or sculptors, they are always aristocratic, tall, handsome - dark-haired with blue eyes or blond with black eyes - capable of dominating you with their eyes (nothing to do with the sadistic Christian Gray) to woo you with gallant gestures that have in their own DNA.
The women are models with fire-colored hair and green eyes, or shy modest girls with braids and a low gaze. They have high-sounding and strange names - they are said to be taken from horse racing magazines: Beba, Coralla, Periwinkle, and look more sanguine and d’Annunzian than Pre-Raphaelite.
"She gave one last brush to the fluffy, light and wavy hair that brushed her shoulders, she moistened her lips. She put on hes overcoat. On the dark blue of the heavy fabric, the wonderful tawny hair shone, of a beautiful dark fawn, which divinely framed the white face, on which the red lips, full of healthy and violent blood, put a lively note of ardent color. " (From The rainbow in the sky)
The environments are described with a visual and aestheticizing minutia that appeals to all five senses. Every detail of architecture, furnishings, clothing, food is shown. The tables are set sumptuously, or in a rural way, the bread is fragrant, the chicken crispy. You can feel penetrating perfumes, noises, smells, you can see the colours stand out as in a painting.
“On a white tablecloth, made of fine Flanders, she had placed almost luxurious dishes and glasses, the cutlery was of base metal, but shiny and clean. Only, in the middle of the table, stood a silver jar, in which a purple chrysanthemum was immersed. " (from Melody of ancient love)
“A great silence weighed on all things, dominated the room. And in that silence, the ticking of two clocks was heard. The small one that stood on a topaz-colored opal table, and the large, electric one, embedded in the wall of the anteroom. Two rhythmic and dissimilar sounds that gave a sense of the transience of time. " (From Like the kisses on the water)
The sensuality exudes from the scenes:
“They walked close, when the wind lifted Mabel's overcoat it brought her to touch Arno Dala's legs. And he, for that caress of the beloved woman's dress, rejoyed. " (From Like the kisses on the water)
Eroticism takes the form of "blood that flows faster in the wrists", in murky glances, in a repressed but tangible desire, which made those same mother and grandmothers - who passed the books on which they had cried and secretly dreamed – fear that the reading was too risky for “Signorinette”, wanting to stay on topic and quote Wanda Bontà.
"Hes face bore traces of the long night of love, but hes eyes were full of joy. Never, like that night, had Beba been his, never had the feeling of possession been so strong and terrible. Beba's placid sensuality had flickered and quivered, the beautiful flesh had unusually animated, and never had Beba's face been so wasted and devastated by kisses. " (From Signorsì)
The style is clean but redundant, pletoric, played on synonyms: "I want to know what languages you speak, which idioms you know."
Liala is an underrated writer, a skilled narrator, capable of making you see, hear and touch what she tells, capable of creating atmospheres that are not forgotten. She is an exponent to all effects of decadentism, captured in his aestheticizing, baroque aspects, with strong colours made of sex, love and death, of great otherworldly passions (Lalla who returns), of libertine men looking for pure girls and virgins to crease.
/http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-j3Aw8Nw7tGc%2FUJabgd5FtZI%2FAAAAAAAAAJo%2F2M8FP_ssyRs%2Fs320%2Fimages.jpg)
CriticaLetteraria: Pillole d'Autore: Liala
Dopo il 1950 viene a cadere il disprezzo vociano per il romanzo borghese, che aspira ormai a far parte della letteratura. Ma prima, nel periodo fascista e anche oltre, si ha una netta divisione fra
http://www.criticaletteraria.org/2012/12/pillole-dautore-liala.html
"Cime Tempestose" di Emily Brontë, l'amore come ossessione

A tre anni Emily Brontë aveva già perso la madre e cresceva nel ricordo delle due sorelline scomparse, Maria ed Elisabeth. La zia allevò lei, Charlotte, Anne e Patrick (detto Branwell dal cognome materno) col metodismo wesleyano, nelle riunioni di famiglia un tema consueto era il resoconto di morti edificanti. Il padre era irlandese, la madre della Cornovaglia, più che inglesi erano celti, e questo retaggio di miti e folklore, unito alla natura selvaggia in cui crebbero, esaltò l’immaginazione dei fratelli.
Emily (1818-1848) era una ragazza dalle braccia lunghe, dal passo elastico, dalla figura regale, anche quando correva nella brughiera fischiando ai cani. Nel ritratto che le fece Patrick Branwell, "gli occhi sono notturni, occhi che mettono a disagio, che non accettano la realtà solare e non rifiutano alcun orrore tenebroso "(introduzione a Cime tempestose, Garzanti 1965)
Come afferma Charlotte (l’autrice di Jane Eyre), "mia sorella non ebbe per natura un’indole socievole, le circostanze favorirono e alimentarono un’inclinazione alla solitudine: tranne che per andare in chiesa o per fare una passeggiata sulle colline, ella raramente varcava la soglia di casa.
Il fratello Patrick era pittore e poeta, dedito all’alcol e all’oppio, perfetta incarnazione dell’eroe byronico. Lui ed Emily erano legatissimi, vagavano insieme per la brughiera, paghi l’uno dell’altra; morì alcolizzato nel '48 fra le braccia di Emily. Lei non gli sopravvisse, o meglio non gli volle sopravvivere, si abbandonò con voluttà alla tisi che la corrodeva da tempo. Prese freddo durante il funerale, cominciò a tossire, non volle curarsi, spirò tre mesi dopo il fratello. In testa al corteo funebre camminava Keeper, il selvaggio bulldog che lei sola sapeva ammansire. Dopo la sua morte, Charlotte distrusse tutti gli scritti che avrebbero potuto comprometterne la reputazione ma anche illuminarci sull’origine dei suoi versi e del suo romanzo.
Cime tempestose (1847) è un’opera, come la definisce il Praz, "fra le più tumultuosamente romantiche di tutta la letteratura inglese". Il titolo originale è Wuthering Heights. Wuthering è variante regionale dell’aggettivo scozzese whither, parola che indica il tumulto atmosferico cui è soggetta la casa degli Earnshaw. I paesaggi e la meteorologia sono esasperati, come esasperati sono i caratteri dei protagonisti. Più che romanzo, Cime tempestose è tragedia, poema epico. La filosofia che sottende l’opera è che tutto il creato, animato e inanimato, psichico e fisico, è mosso da due principi, lo spietato-selvaggio e il dolce-passivo, rappresentato dai due poli, le due magioni, Wuthering Heights e Thrushcross Grange con i loro abitanti, gli Earnshaw e i Linton. Ma c’è una seconda generazione, dove il contrasto fra figli della tempesta e figli della calma è smussato, si accavalla fino a confondersi, a trovare una forma di redenzione.
Heathcliff e Catherine sono i due personaggi principali, titanici e granitici, fatti della stessa sostanza della natura in cui vivono. Per loro, odio e amore, passione e vendetta, sono la stessa cosa. Heathcliff e Chaterine si compensano, come Emily e Branwell, sono cresciuti insieme, fratelli/amanti. Heathcliff è spesso descritto con termini che ricordano più la natura selvaggia che non l’essere umano, è l’eroe maledetto dalla risata diabolica. Cathy è donna ma anche spettro, incarnata in una progenie maledetta.
“I am Heathcliff”, dice Catherine, nella potente indimenticabile dichiarazione che racchiude l’essenza stessa dell’amore romantico.
Il mio amore per Heathcliff somiglia alle eterne rocce che stanno sottoterra: una sorgente di gioia poco visibile, ma necessaria. Nelly, io sono Heathcliff! Lui è sempre, sempre nella mia mente; non come un piacere, come neppur io son sempre un piacere per me stessa, ma come il mio proprio essere. (p. 95)
Secondo il poeta decadente Swinburne, Emily dipinge “l’amore che corrode la vita stessa, devasta il presente, distrugge l’avvenire, con il suo fuoco divoratore.” È l’amore ossessione, l’amore romantico, trascendente, violento e inarrestabile.
Ai personaggi di Emily Brontë non si applica l’ordinaria antitesi fra bene e male. Essi non si pentono dei loro impulsi distruttivi. Costretti a deviare dal loro corso naturale, come un fiume che esce dagli argini, devastano incolpevoli ciò che incontrano sul loro cammino. I loro atti spietati, la loro cattiveria, in una parola il male che essi compiono e rappresentano, fanno parte del creato, hanno una ragione d’essere e una posizione nel cosmo. Come sostiene il Praz, “il punto di vista di Emily Brontë non è immorale ma premorale”. Il contrasto non è quello vittoriano fra bene e male, ma fra simile e dissimile.
Lui è più di me stessa. Di qualsiasi cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono simili; e l’anima di Linton è differente come un raggio di luna dal lampo, o il gelo dal fuoco. (p. 93)
Questo concetto di premoralità, di bene e male come parte di un unico disegno divino, sarà la costante anche dei romanzi odierni di Anne Rice che molto derivano dall’atmosfera gotica, romantica, di Cime Tempestose. Come l’asessuato, eppur erotico, morso vampiresco, il sesso tradizionale ha poco a che vedere con l’attrazione inesorabile che unisce Heathcliff a Catherine e che è vicina alle forze sotterranee della natura, alle maree che trascinano, alle correnti, al magma.
Dov’è? Non là, non in cielo, non morta: dov’è? (...) E io prego, la ripeto la mia preghiera finché la mia lingua riuscirà a pronunciarla: Catherine Earnshaw, possa tu non riposare mai finché vivo io! Hai detto che ti ho uccisa io… perseguitami, dunque! Credo che gli uccisi perseguitino i loro uccisori. So di spiriti che hanno vagato sulla terra. Rimani con me sempre, prendi qualsiasi forma, fammi diventar pazzo! Soltanto non lasciarmi in questo abisso dove non posso trovarti! Oh, Dio; è indicibile! Non posso vivere senza la mia vita! Non posso vivere senza l’anima mia! (p. 183)
Riferimenti critici:
------------------------------------------------------------------------------
Mario Praz, Storia della Letteratura inglese, Sansoni editore, 1979
Introduzione a “Cime tempestose”, Garzanti, 1965
Eddie Flintoff, In the steps of the Brontës, Conuntryside Books, 1993
At three years old Emily Brontë had already lost her mother and was growing in memory of the two missing sisters, Maria and Elisabeth. Her aunt raised her, Charlotte, Anne and Patrick (called Branwell from the maternal surname) with the Wesleyan method, in family reunions a usual theme was the report of edifying deaths. The father was Irish, the mother of Cornwall, more than English, were Celts, and this legacy of myths and folklore, combined with the wild nature in which they grew up, exalted the imagination of the brothers.
Emily (1818-1848) was a girl with long arms, an elastic step, a regal figure, even when she ran on the moor whistling to dogs. In the portrait that Patrick Branwell made of her, "the eyes are nocturnal, eyes that make you uncomfortable, that do not accept the solar reality and do not refuse any dark horror" (introduction to Cime tempestuous, Garzanti 1965)
As Charlotte (the author of Jane Eyre) states, "my sister did not have a sociable nature by nature, circumstances favored and fueled an inclination to solitude: except for going to church or taking a walk on the hills, she rarely crossed the threshold."
Brother Patrick was a painter and poet, dedicated to alcohol and opium, the perfect embodiment of the Byronic hero. He and Emily were very close, they wandered together on the moor, happy to be toghether he died an alcoholic in '48 in Emily's arms. She did not survive him, or rather she did not want to survive him, she reluctantly abandoned herself to the phthisis that had been corroding her for some time. She caught cold during the funeral, began to cough, did not want to be cured, expired three months later his brother. At the head of the funeral procession walked Keeper, the wild bulldog that she alone could tame. After her death, Charlotte destroyed all the writings that could have compromised hes reputation but also enlightened us on the origin of his verses and his novel.
Wuthering Heights (1847) is a work, as Praz defines it, "among the most tumultuously romantic of all English literature". Wuthering is a regional variant of the Scottish adjective whither, a word that indicates the atmospheric turmoil to which the Earnshaw house is subject. Landscapes and meteorology are exasperated, just as exasperated are the characters of the protagonists. More than a novel, Wuthering Heights is a tragedy, an epic poem. The philosophy behind the work is that all creation, animated and inanimate, psychic and physical, is driven by two principles, the ruthless-wild and the sweet-passive, represented by the two poles, the two mansions, Wuthering Heights and Thrushcross Grange with their inhabitants, the Earnshaw and the Lintons. But there is a second generation, where the contrast between the children of the storm and the children of calmness is smoothed out, until it gets confused, to find a form of redemption.
Heathcliff and Catherine are the two main characters, titanic and granitic, made of the same substance as the nature in which they live. For them, hate and love, passion and revenge are the same thing. Heathcliff and Chaterine compensate each other, like Emily and Branwell, they grew up together, brothers / lovers. Heathcliff is often described in terms that remind us more of the wild nature than the human being, he is the hero cursed by diabolical laughter. Cathy is a woman but also a ghost, embodied in a cursed progeny.
"I am Heathcliff," says Catherine, in the powerful unforgettable declaration that contains the very essence of romantic love.
"My love for Heathcliff resembles the eternal rocks that lie underground: a source of joy that is hardly visible, but necessary. Nelly, I'm Heathcliff! He is always, always in my mind; not as a pleasure, as I am not always a pleasure for myself, but as my own being".
According to the decadent poet Swinburne, Emily paints "the love that corrodes life itself, devastates the present, destroys the future, with its devouring fire." It is love obsession, romantic love, transcendent, violent and unstoppable.
The ordinary antithesis between good and evil does not apply to the characters of Emily Brontë. They do not regret their destructive impulses. Forced to deviate from their natural course, like a river coming out of the banks, they devastate innocently what they encounter on their way. Their merciless acts, their malice, in a word the evil they do and represent, are part of creation, have a reason for being and a position in the cosmos. As Praz argues, "Emily Brontë's point of view is not immoral but premoral". The contrast is not Victorian between good and evil, but between similar and dissimilar.
"He is more than myself. Whatever our souls are made of, his and mine are alike; and Linton's soul is different like a moonbeam from lightning, or frost from fire.
This concept of premorality, of good and evil as part of a single divine plan, will also be the constant of today's Anne Rice novels that derive a lot from the gothic, romantic atmosphere of wuthering Heights. Like the asexual, yet erotic, vampire bite, traditional sex has little to do with the inexorable attraction that unites Heathcliff with Catherine and that is close to the underground forces of nature, the tides that drag, currents, magma.
"Where is she? Not there, not in heaven, not dead: where is she? (...) And I pray, I repeat my prayer until my tongue can pronounce it: Catherine Earnshaw, may you never rest as long as I live! You said I killed you ... persecute me, then! I believe that the killed persecute their killers. I know of spirits who have wandered on earth. Stay with me always, take any shape, make me go crazy! Just don't leave me in this abyss where I can't find you! Oh God; it is unspeakable! I can't live without my life! I can't live without my soul!
/http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-em_60b-6Kko%2FT3xG0UTC_sI%2FAAAAAAAABNs%2F3tyO94IQEBc%2Fs200%2Femilybronte.jpg)
CriticaLetteraria: "Cime Tempestose" di Emily Brontë, l'amore come ossessione
Cime tempestose di Emily Brontë Garzanti, 1965 pp. 353 gli occhi sono notturni, occhi che mettono a disagio, che non accettano la realtà solare e non rifiutano alcun orrore tenebroso (introduzione a
http://www.criticaletteraria.org/2012/04/cime-tempestose-di-emily-bronte-lamore.html
I primi abitatori del Mediterraneo di Adriana Pedicini
/image%2F0394939%2F201301%2Fob_f70887_ob-13d72ed88baf876cab6df54ca41c5c47-mediterraneo-.jpg)
“Viviamo intorno a un mare -aveva detto Socrate, (470 / 469 a.C.) ai suoi amici Ateniesi- come rane intorno a uno stagno”.
In effetti circa cinque milioni di anni fa, il Mar Mediterraneo non era ancora un mare, bensì era una vallata profonda e arida che divideva tre continenti: Europa, Africa e Asia, fino a quando un cataclisma aprì un varco nel muro di contenimento dell’oceano Atlantico ad ovest, verso l’odierna Gibilterra. In un processo durato moltissimi anni, una gigantesca mole di acqua ha incominciato ad inondare l’intero bacino mediterraneo, dando vita a un nuovo mare che, per la verità, appare piuttosto formato da un insieme di mari: il mar Alboran, il Golfo di Lione, il Tirreno, lo Ionio, il mar Egeo, l’Adriatico, ognuno con caratteristiche proprie.
Settecento anni dopo Socrate, nel 200 d. C., il mondo classico se ne stava ancora intorno al suo “stagno”: si teneva aggrappato alle sponde del Mediterraneo, l’unico mondo possibile e sicuramente il migliore, se un senatore greco dell’Asia Minore, nominato governatore di una località sul Danubio, mondo definito barbarico, ebbe a dire lamentandosi: “Gli abitanti conducono l’esistenza più misera di tutta l’umanità, perché non coltivano olivi e non bevono vino”.
Con l’estendersi dell’Impero romano al mondo che esisteva già da secoli sulle rive del Mediterraneo, nel II secolo d. C., è straordinaria l’ondata di vita mediterranea che rifluisce nell’entroterra arrivando più lontano di quanto non fosse mai accaduto in precedenza.
In seguito numerose civiltà, diversi assetti politici, svariati predomini si susseguirono sulle terre circondanti questo Mare fino a giungere all’evo moderno.
Sicché, attraverso secoli di storia e mutamenti politico-religiosi-culturali, è possibile ricostruire la storia di uno spazio, il “bacino mediterraneo” ovvero dei “paesi mediterranei”, spazio nel quale si sono incontrate diverse civiltà e culture nel corso del tempo, che hanno influito sulla civiltà dell’Europa intera.
Anzi, solo in esse è possibile rintracciare l’identità complessa e contraddittoria della civiltà europea fin dalle sue origini, partendo dal formarsi dei primi nuclei di civiltà, molte migliaia di anni or sono, per giungere alla sua configurazione attuale, nella convinzione che «questa vicenda millenaria possa essere compresa soltanto nel quadro più ampio del bacino mediterraneo, col suo intreccio senza eguali di culture e di fedi diverse».
La storia d’Europa è dunque una storia che si è estesa per cinque millenni.
Ma quali furono i popoli che abitarono le rive del Mar Mediterraneo?
Solitamente si distingue un Mediterraneo romano e un Mediterraneo arabico.
All’origine dello sviluppo culturale “storico” dei paesi gravitanti sul Mediterraneo romano stanno grandi movimenti etnici, cioè due grandi migrazioni di popoli, le quali hanno contribuito a conferire a questa zona geografica quella fisionomia etnica che le fu propria in tutto l’evo antico e che in parte rimane tuttora.
Queste due migrazioni sono quelle degli Arioeuropei (o Indeuropei) o semplicemente Ari, e dei Semito-Camiti: ambedue si svolgono dentro l’area fin d’allora occupata dalla razza bianca o europida e a questa razza appartengono perciò i popoli che vi partecipano.
Quando iniziò lo svolgimento di queste due grandi migrazioni, e cioè alla fine dell’età neolitica, tutto il bacino del Mediterraneo risulta occupato da una stirpe umana che una sufficiente omogeneità di caratteri fisici ci permette di designare col nome di razza mediterranea; essa si trova allora a popolare le grandi penisole e le isole dell’Europa meridionale, l’Asia Minore, la fascia costiera dell’Africa settentrionale. Quali e quanti fossero i gruppi etnici, cioè i popoli appartenenti a questa stirpe, quali lingue parlassero, come si denominassero, possiamo dire di saperlo in modo vago e generico, solo per quelle genti la cui cultura e la cui lingua non rimase troppo presto eclissata da quella di posteriori invasori del loro paese e durò tanto da lasciare sicura notizia di sé all’indagine dello storico.
Compaiono tra questi antichi popoli del Mediterraneo gli antichi Iberi, i Sardi, i Corsi e quelli che col nome di Liguri ed Elimi abitavano agli albori della storia rispettivamente gran parte dell’Italia settentrionale e la Sicilia occidentale; i quali tutti conservarono la loro cultura e la loro lingua fino alla loro latinizzazione per opera di Roma. E se di questi popoli nessuno fu creatore di una grande civiltà, un altro ve ne fu invece, il cui incivilimento progredì fino a stadi elevatissimi: il popolo dei Cretesi, cioè gli abitanti dell’isola di Creta.
A sconvolgere tale sistemazione etnica del bacino del Mediterraneo sopraggiunsero le due migrazioni sopra ricordate: prima quella dei Semiti e Camiti, poi quella degli Ari.
I nomi di Semiti e Camiti derivano dalla ben nota “tavola dei nomi” inserito nel racconto dato dalla Bibbia (Genesi, X) delle prime vicende dell’umanità dopo il diluvio: qui sono distinti i popoli discendenti da Sem da quelli discendenti da Cam e da Jafet; di qui i nome di Semiti, Camiti e Giapeti per determinati gruppi di popoli corrispondenti più o meno alla tripartizione biblica.
In epoca storica i Semiti occupano un vasto territorio dell’Asia anteriore, etnicamente e linguisticamente compatto. Si distinguono quattro gruppi che vi svilupparono successivamente le loro civiltà:
1) le stirpi assiro-babilonesi stabilite nelle valli del Tigri e dell’Eufrate
2) gli Aramei dal golfo di Alessandretta al deserto siro-arabico
3) i Cananei estesi verso la costa ad occupare le zone del Libano e dell’Antilibano, la Siria e la terra di Canaan, e distinti in Fenici, Ebrei, Ammoniti, Moabiti, Edomiti
4) gli Arabi e gli Etiopi: i primi stanziati nella penisola arabica a sud dei territori sopradescritti, i secondi formati da una migrazione del ramo meridionale degli arabi, che li condusse nel territorio dell’odierna Etiopia.
I Camiti invece li troviamo nelle regioni costiere dell’Africa settentrionale, a cominciare dall’Egitto e poi via via verso Occidente.
Da dove e quando arrivarono questi popoli nelle loro sedi storiche?
È probabile che i Semiti abbiano occupato, in un tempo più remoto, una zona dell’Asia centrale insieme coi Camiti e in prossimità delle sedi degli Indo-Europei. Da queste zone verso la fine dell’età paleolitica, i Semiti e i Camiti migrarono nelle loro più tarde sedi: i Semiti nell’Arabia e i Camiti nell’Africa settentrionale, dove rimasero durante lo svolgersi della successiva età neolitica. Nel corso del IV millennio a. C. i Semiti iniziarono il movimento migratorio verso nord, occuparono prima la Mesopotamia meridionale (o Babilonide) dove si trovarono a contatto con il popolo dei Sumeri, creatore della civiltà mesopotamica.
Col nome di Accadi, i Semiti della Babilonide soggiogarono politicamente i Sumeri, ma assorbirono gli elementi della loro superiore civiltà, a cominciare dalla scrittura cuneiforme.
Nel corso del III millennio una seconda ondata migratoria portò nella parte settentrionale della Mesopotamia il popolo degli Assiri, il quale si estese a nord tanto quanto glielo permise la resistenza delle stirpi asianiche e indoeuropee dell‘Asia minore.
Una terza ondata semitica produsse la prevalenza della cosiddetta dinastia araba (a cui appartiene il famoso Hammurapi).
Frattanto avvenivano altre migrazioni semitiche verso i territori del Libano, della Siria e della Palestina: dopo vari spostamenti che si svolsero nel terzo e nella prima metà del secondo millennio, verso il 1500 a. C. Aramei, Fenici, Ebrei ed i popoli ad essi affini si trovavano stanziati nei territori in cui presero consistenza le loro caratteristiche nazionali e in cui essi assunsero assetto politico.
La denominazione di “Indoeuropei” o “Arioeuropei” invece (o semplicemente Ari) si dà a un gruppo di popoli che parlano lingue, la cui derivazione da un unico ceppo è ormai un fatto scientificamente dimostrato. In età storica e in parte ancora oggi troviamo questi popoli distesi su alcune zone dell’Asia occidentale (India, Iran, Asia minore) e su quasi tutta l’Europa da cui cominciarono a emigrare, al tempo delle grandi scoperte geografiche, in America e in Australia.
Gli Indeuropei o Ari, dunque, costituiscono una grande famiglia linguistica, non una “RAZZA” ma piuttosto un popolo la cui sede primitiva fu probabilmente in Asia, in quelle regioni note ora con i nomi di Turkestan e di Steppa dei Kirghisi.
Caratteristiche della cultura indeuropea erano, nella lingua, l’abbondanza delle radici e la complessità della flessione nominale e verbale; nella religione, il suo progresso fino a un livello molto avanzato del deismo e forse fino all’antropomorfismo, con la concezione di un dio supremo luminoso (il Dyaus Pitar degli Indiani, identico allo Zeus dei Greci e allo Iupiter dei Latini) e di numerose altre divinità minori, quasi tutte luminose e celesti, non intimamente legate alla tribù o alla nazione, ma intese come estrinseche ad essa e universali: nei rapporti sociali, il solidissimo fondamento rappresentato dalla famiglia, su base patriarcale e sulla convivenza, in seno ad essa, di liberi e servi.
Quando intorno al 3000 a. C. gli Indoeuropei cominciarono a spostarsi dalle loro sedi primitive in cerca di altre terre avevano già conosciuto il rame, erano pastori, allevavano oltre agli animali domestici noti a quasi tutti i neolitici (bue, pecora, capra) anche il cavallo; praticavano un’agricoltura assai primitiva, sapevano filare, tessere e fabbricare vasi di argilla. Avevano doti fisiche e spirituali tali da assicurare agli Ari il dominio su tutte le altre genti che avrebbero incontrato sulla loro strada; doti che peraltro erano destinate a svilupparsi in grado diverso e a dare frutti differenti a seconda che i singoli gruppi indeuropei, separatisi e differenziatisi l’un l’altro, risentirono più o meno profondamente degli influssi del nuovo ambiente geografico in cui vennero a vivere e dell’influenza che ebbero su di essi le popolazioni con cui vennero a contatto e con cui si amalgamarono.
Alcuni gruppi di essi si spinsero verso mezzogiorno penetrando nell’India, nell’Iran, nell’Asia Minore e sovrapponendosi alle popolazioni locali.
Nell’Asia Minore gli Ari penetrarono in tre ondate successive: la prima si fuse con i precedenti abitatori non ari; la seconda, verificatasi al tempo della grande espansione indeuropea (intorno al 2000 a. C.), fu quella degli Hatti o Hittiti, che si stanziarono in quella parte dell’Asia Minore chiamata Cappadocia; la terza migrazione avviene nel 1200 a. C. circa ed è quella che portò in questa regione i Frigi, i Lidi e gli Armeni, i quali penetrarono però nell’Asia Minore dalla Penisola Balcanica attraverso gli Stretti.
Mentre le grandi ondate europee ora descritte, allargandosi verso sud-ovest, portavano nelle loro sedi definitive le popolazioni indoiraniche e gli Hittiti, altre correnti migratorie procedevano più decisamente verso Occidente, popolando gradatamente quasi tutto il continente europeo.
A questo movimento migratorio si deve lo stanziarsi nelle loro sedi storiche dei Traci, degli Illiri, dei Celti, dei Letto-Slavi, dei Germani e, particolarmente dei Greci e degli Italici, destinati, insieme con gli Hittiti e gli Indo-Irani a dar vita alle quattro più antiche civiltà ario europee. Tra esse, quella che maggiormente influì sulla creazione di un’identità europea, fu senz’altro la civiltà greco-latina, che tanto comunque deve alla composita primitiva civiltà mediterranea, soprattutto grazie all’apporto dei Cretesi prima e dei Micenei dopo.
"A mille ce n'è..." Le fiabe sonore dei Fratelli Fabbri
/image%2F0394939%2F201301%2Fob_d799db5bc714f2ec51e15e8c3b952e71_images-4.jpg)
Quest'anno Fabbri editrice ha lanciato un'app per iOS (iPad e iPhone) da cui si possono scaricare dodici delle delle intramontabili "fiabe sonore".
Non molto prima del Natale 1966, i Fratelli Fabbri editori distribuirono gratuitamente nelle edicole un disco promozionale de Le Fiabe Sonore, con I tre Porcellini. La settimana seguente uscì il primo numero ufficiale, Il gatto con gli Stivali di Charles Perrault, corredato di un albo di grande formato (27x35) con splendide illustrazioni romantiche e tuttavia ironiche, ammiccanti, comunque moderne.
Molti di noi, all’epoca, non sapevano ancora leggere. Furono i nostri genitori, dunque, a iniziarci alla magia, a spalancarci le porte della fantasia, a introdurci in un mondo che ci avrebbe arricchito, ammaliato, incantato, spaventato, meravigliato. Settimana dopo settimana, avremmo imparato a leggere e scrivere anche grazie alle Fiabe Sonore, assorbendo parole nuove e sconosciute, non sempre facili.
Le fiabe uscirono ininterrottamente dal 1966 al 1970, incise su dischi a 45 giri e corredate da libri bellissimi, illustrati da pittori molto conosciuti: Pikka, Una, Ferri, Max e Sergio.
Dopo averle ascoltate dai nostri genitori, ci affidavamo poi alla voce profonda e rassicurante di Silverio Pisu (1937-2004) attore, doppiatore, cantante, scrittore e sceneggiatore. Ci raggomitolavamo sul divano nelle fredde sere d’inverno, col libro sulle ginocchia, rapiti dalle figure, con l’orecchio teso a cogliere la minima differenza fra testo scritto e voce narrante. Oppure, raffreddati e febbricitanti, spargevamo sul letto le fiabe a raggiera, estraevamo dalla custodia il disco di vinile, lo inserivamo trepidanti nel mangiadischi. Il ditino premeva, il tasto si abbassava e in quel piccolo gesto c’era un potere immenso, quello di far scaturire suoni e immagini, di evocare un intero universo parallelo. Eravamo noi a tenere la bacchetta magica, a chiudere e aprire a piacimento la porta fatata, a ogni rilettura, a ogni riascolto.
Con Silverio Pisu collaboravano molti altri attori professionisti tra cui Ugo Bologna, Sante Calogero, Pupo de Luca, Isa di Marzio. Le musiche furono commissionate a un famoso compositore dell’epoca, Vittorio Peltrinieri. Nessuno di noi potrà mai dimenticare la canzone introduttiva cantata dal Quartetto Radar, composto da Claudio Celli, Gianni Guarnieri, Dino Comolli e Stelio Settepassi, il cui stile voleva somigliare a quello del più celebre Quartetto Cetra.
Assieme alla canzoncina di chiusura alle fiabe, il memorabile jingle iniziale costituì un sicuro segno di riconoscimento della collana:
A mille ce n'è
nel mio cuore di fiabe da narrar.
Venite con me
nel mio mondo fatato per sognar…
Non serve l'ombrello,
il cappottino rosso o la cartella bella
per venire con me…
Basta un po' di fantasia e di bontà.
Dopo l’introduzione, cominciava la fiaba vera e propria, sceneggiata, riadattata, modernizzata senza toglierle fascino. Ogni sceneggiatura era caratterizzata non solo dalla voce narrante di Silverio Pisu, ribattezzato Cantafiabe, ma pure da vivaci dialoghi e canzoncine orecchiabili come quelle indimenticate di Cappuccetto Rosso, del Nano Tremotino, di Cigno Appiccica.
Pochi cenni magistrali erano sufficienti a creare l’atmosfera, come il passaggio del tempo segnato da un tocco d’arpa, capace di scatenare la fantasia, fare appello a più sensi contemporaneamente e rendere superflua qualsiasi parola. In tutto uscirono circa 150 fascicoli illustrati e altrettanti dischi. Vennero riproposte fiabe dei principali favolisti europei: i fratelli Grimm, Andersen, Perrault, Puŝkin e dei meno noti Bechstein, Leprince de Beaumont, Gianbattista Basile.
Grazie alle fiabe della Fabbri, un’intera generazione si è divertita con lo spassoso Vardiello, ed ha altresì imparato – come spiega Bruno Bettelheim – a gestire le proprie paure infantili, rielaborando interiormente, assorbendo e facendo proprie certe atmosfere gotiche. Come non ricordare la paura suscitata dalla spaventosa strega di Hansel e Gretel bruciata nel forno dai due fratellini, dall’Orco di Pollicino che taglia la gola alle proprie figlie, dall’ingiusta accusa di stregoneria rivolta alla protagonista de Gli undici cigni selvatici costretta al silenzio a causa dell’amore per i fratelli? Le fiabe sonore ci insegnavano la netta divisione fra male e bene, il confine fra lecito e illecito, il senso del dovere e lo spirito di sacrificio, parole che oggi sembrano ormai prive di significato.
Oltre alle fiabe singole, furono pubblicate anche magistrali versioni a puntate di Le avventure di Pinocchio, con Paolo Poli nel ruolo del burattino, di Alice nel paese delle meraviglie e di Peter Pan. Le fiabe sonore furono riproposte nel '77, negli anni '80, nel '90. Uscirono poi per la prima volta su CD nel 2003 e in allegato al Corriere della Sera nel 2007. Come abbiamo detto all’inizio, sono di quest’anno applicazioni scaricabili per iPhone e iPad con due fiabe gratuite e le altre a pagamento.
E ora ci congediamo da voi come faceva il Cantafiabe, con quella canzoncina che ci procurava tristezza e consolazione insieme, il senso di qualcosa che finisce e poi comincia di nuovo, in un infinito loop che ci aiutava a crescere, a sopportare il ritorno alla vita normale, alle nostre fatiche di bambini, simboleggiate dalla “cartella bella” dell’introduzione.
Finisce così
Questa favola breve se ne va
Il disco fa click
E, vedrete, fra un po’ si fermerà,
ma aspettate, e un altro ne avrete
“C’era una volta” il Cantafiabe dirà
E un’altra favola comincerà
/http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Zyf8IxU_-N4%2FUHSlNtFT3PI%2FAAAAAAAACCM%2FyaLGjMTGTAk%2Fs1600%2FFIABE%2BSONORE%2BAPP.jpg)
CriticaLetteraria: "A mille ce n'è...": le fiabe sonore dei Fratelli Fabbri
Quest'anno Fabbri editrice ha lanciato Non molto prima del Natale 1966, i Fratelli Fabbri editori distribuirono gratuitamente nelle edicole un disco promozionale de un'app per iOS (iPad e iPhone) da
http://www.criticaletteraria.org/2012/10/a-mille-ce-ne-le-fiabe-sonore-dei.html
"Piccole Donne", il trascendentalismo di Louisa May Alcott

Little Women, 1869
di Louisa May Alcott
Collins Classics 2010
pp. 286
3,50
La regione intorno a Boston era semplice e genuina campagna.“Lì”, afferma il Cunliff, “l’aspirante scrittore poteva vivere con pochissimo, coltivando un pezzo di terra per trarne il necessario al proprio sostentamento […] e facendo di tanto in tanto un viaggio a Boston per prendere libri in prestito, o incontrarsi con un editore.[…] fu in quella cerchia di comunità colte e intimamente collegate, nei dintorni di Boston, che apparve il fenomeno del trascendentalismo, termine impreciso e difficilmente attribuibile ad una qualsiasi fra le figure di maggior rilievo del tempo.”
Si tratta di scrittori imbevuti di filosofia kantiana, convinti di vivere in un universo benefico, in collegamento con la natura, di sostanziale stampo romantico ed in costante movimento verso la perfezione, ottenibile, per altro, solo in America. Fu Emerson a formulare con maggior completezza la teoria trascendentalista. Fra i tanti appartenenti al movimento, dallo stesso Emerson a Thoreau, a Hawthorne, a Whitman, c’era anche Amos Bronson Alcott, padre di Louisa May, l’autrice di Piccole Donne.
Louisa May nasce a Germantown in Pennsilvania nel 1832, poi si trasferisce a Concord, a ovest di Boston, con la famiglia, la seconda di quattro sorelle. Cresce in un ambiente “illuminato e progressista”, fieramente abolizionista e vive la realtà della Guerra Civile. Il padre fonda una scuola conosciuta per le sue idee rivoluzionarie, dove si applica il principio del rispetto della spontaneità del fanciullo.
Così Silvano Ambrogi descrive Louisa, come la si coglie in un ritratto:
“La vediamo all’angolo di una scrivania, con un vestito ad ampie, lunghissime gonne, una candida e voluminosa pettorina arricciata, capelli ondulati e gran crocchia alla nuca, insomma l’aspetto di una signora della buona società del tempo. Il braccio appare del tutto disteso, con languore quasi dannunziano, ma la grinta viriloide fa da aperto contrasto: lo sguardo infossato, che punta diritto davanti a sé e la bocca strettamente serrata. La penna appare fra le dita impugnata come fosse uno stiletto o una pistola.”
Amos Bronson trasforma la casa in un cenacolo trascendentalista, frequentano il salotto Thoreau, Hawthorne ed Emerson.
Louisa fa scuola alle figlie di quest’ultimo e ha libero accesso alla biblioteca, dove legge di tutto, da Platone a Dickens, il suo idolo, che incontrerà durante un viaggio sul vecchio continente e di cui ricreerà Il circolo Pickwick, attraverso la società segreta fondata per gioco dalle protagoniste del suo libro più famoso.
Lavora come infermiera, si ammala di tifo, scrive molti libri di successo, contenenti tutti gli elementi dei classici romanzi d'appendice ottocenteschi, con avventure gotiche ed eroine tragiche. Durante un viaggio in Europa come dama di compagnia - descritto nella seconda parte di Piccole donne, quella che in Italia è stata pubblicata come Piccole donne crescono – vive un amore con un musicista che diventa il Laurie del romanzo. Morirà nel 1888, per un’infreddatura, mentre corre al capezzale del padre senza sapere che egli è deceduto due giorni prima.
Pubblicato nel 1869, e poi nella versione completa nel 1880, Piccole donne si rifà alla vita che si svolgeva in casa Alcott/March, negli anni della formazione delle quattro sorelle e ci offre con immediatezza l’immagine dell’America nella seconda metà dell’Ottocento. Delle quattro ragazze, solo Beth conserva il nome originario e, come la sfortunata sorella minore di Louisa, anche lei morirà (anche se non nella prima parte).
Ognuna delle protagoniste ha una personalità spiccata e differente dalle altre, benché cresciute tutte nello stesso ambiente e sotto l’occhio vigile e saggio della madre. Fin dal loro primo apparire sulla scena, i termini usati per riferirsi a ciascuna di esse indicano subito i loro caratteri, le modellano e le fanno risaltare agli occhi del lettore.
“Christmas won’t be Christmas without any presents’ grumbled Jo, lying on the rug.
“It’s so dreadful to be poor!” sighed Meg, looking down at her old dress.
“I don’t think it’s fair for some girls to have plenty of pretty things, and other girls nothing at all”, added little Amy, with an injured sniff.
“We’ve got father and Mother and each other”, said Beth contentedly, from her corner.
In queste prime righe c’è già tutto il romanzo, i pregi e i difetti delle sorelle, le mancanze che condizioneranno la trama, il loro modo di agire, di porsi, le loro movenze.
Jo, il maschiaccio, sta sdraiata sul tappeto. Per lei l’autrice sceglie il verbo grumbled, brontolò, a fissarne fin dal principio il carattere bellicoso.
La romantica e saggia Meg, (sighed) sospira sulla ricchezza che non può avere che la condurrà in tentazione.
La viziata e capricciosa Amy si presenta con un injured sniff, “un offeso tirar su col naso”, mentre per la buona Beth, che timidamente se ne sta in un angolo, è usato l’avverbio contentedly, cioè con contentezza, appagamento, mansuetudine.
Il personaggio principale è Josephine (Jo) March, nella quale la Alcott si rispecchia. Tramite lei, l’autrice dà voce al suo femminismo, protestando contro le ingiustizie subite dalle donne. Jo è un ragazzaccio, la sua unica bellezza sono i capelli, di cui si priverà in un impeto di generosità. Goffa e sgraziata, impulsiva e furiosa, capace di alternare slanci e collere, sogna di andare all’università, di combattere al fianco del padre nella Guerra Civile. È l’intellettuale di casa, la scrittrice piena di fantasia che compone le sue novelle e le legge in soffitta alle sorelle.
Seguendo gli insegnamenti del padre Amos, la Alcott crede profondamente in Dio e nella possibilità di migliorarsi, di compiere una sorta di pellegrinaggio in vita verso la trascendenza, la sublimazione e il perfezionamento, di cui è simbolo il libriccino regalato a Natale dalla madre alle figlie. Ciò comporta una lotta per tutte e quattro le ragazze, ma soprattutto per Jo, che ha il carattere più difficile. Le sarà di grande aiuto e conforto scoprire che anche la madre, all’apparenza infallibile, ha dovuto come lei combattere e per tenere a freno e riformare la propria natura. Alla fine il bene trionferà sulle debolezze, sulle invidie, sui capricci e le sorelle si ritroveranno più unite che mai. Alla fine il cammino trascendente del pellegrino sarà compiuto.
The region around Boston was simple and genuine countryside. "There," says Cunliff, "the aspiring writer could live with very little, cultivating a piece of land to get what he needed for his livelihood [...] and doing occasionally a trip to Boston to borrow books, or to meet with a publisher. [...] it was in that circle of cultured and intimately connected communities, near Boston, that the phenomenon of transcendentalism appeared, an imprecise term and difficult to attribute to any among the most important figures of the time.”"
These are writers imbued with Kantian philosophy, convinced of living in a beneficial universe, in connection with nature, romantic and in constant movement towards perfection, obtainable, moreover, only in America. It was Emerson who formulated the transcendentalist theory more completely. Among the many members of the movement, from Emerson himself to Thoreau, Hawthorne, Whitman, there was also Amos Bronson Alcott, father of Louisa May, the author of Little Women.
Louisa May was born in Germantown in Pennsilvania in 1832, then moved to Concord, west of Boston, with her family, the second of four sisters. She grows up in an "enlightened and progressive" environment, fiercely abolitionist and lives the reality of the Civil War. The father founded a school known for his revolutionary ideas, where the principle of respect for the spontaneity of the child is applied.
This is how Silvano Ambrogi describes Louisa, as captured in a portrait:
"We see her at the corner of a desk, with a dress with large, very long skirts, a white and voluminous curled bib, wavy hair and a large bun at the nape of the neck, in short, the appearance of a lady of the good society of the time. The arm appears fully extended, with almost D'Annunzio's languor, but the viriloid determination makes an open contrast: the sunken look, which points straight ahead and the mouth tightly closed. The pen appears between the fingers as if it were a stiletto or a pistol. "
Amos Bronson transforms the house into a transcendentalist cenacle, frequenting Thoreau, Hawthorne and Emerson.
Louisa teaches the latter's daughters and has free access to the library, where she reads everything from Plato to Dickens, her idol, whom she will meet during a trip on the old continent and of whom she will recreate The Pickwick circle, through secret society founded as a game by the protagonists of his most famous book.
She works as a nurse, falls ill with typhus, writes many successful books, containing all the elements of the classic nineteenth-century appendix novels, with Gothic adventures and tragic heroines. During a trip to Europe as a lady of companionship - described in the second part of Little Women, the one that in Italy was published as Piccole donne, grow up - lives a love with a musician who becomes the Laurie of the novel. He died in 1888, from a cold, while running to his father's bedside without knowing that he died two days earlier.
Published in 1869, and then in the full version in 1880, Little Women refers to the life that took place in the Alcott / March house, during the years of the formation of the four sisters and offers us immediately the image of America in the second half of the Nineteenth century. Of the four girls, only Beth retains her original name and, like Louisa's unfortunate younger sister, she too will die (although not in the first part).
Each of the protagonists has a distinct and different personality from the others, although they all grew in the same environment and under the watchful and wise eye of the mother. Since their first appearance on the scene, the terms used to refer to each of them immediately indicate their characters, shape them and make them stand out in the reader's eyes.
"Christmas won’t be Christmas without any presents’ grumbled Jo, lying on the rug.
"It's so dreadful to be poor!" Meg sighed, looking down at her old dress.
"I don't think it's fair for some girls to have plenty of pretty things, and other girls nothing at all," added little Amy, with an injured sniff.
"We've got father and Mother and each other," said Beth contentedly, from her corner.
In these first lines there is already the whole novel, the strengths and weaknesses of the sisters, the shortcomings that will condition the plot, their way of acting, their movements.
Jo, the tomboy, is lying on the carpet. For her, the author chooses the verb grumbled, she grumbled, to fix its warlike character from the beginning.
The romantic and wise Meg, (sighed) sighs about the wealth she cannot have that will lead her into temptation.
The spoiled and capricious Amy presents herself with an injured sniff, "an offended sniffle", while for the good Beth, who shyly stands in a corner, the adverb contentedly is used, that is, with contentment, contentment, meekness .
The main character is Josephine (Jo) March, in which Alcott is mirrored. Through her, the author gives voice to her feminism, protesting against the injustices suffered by women. Jo is a bad boy, his only beauty is his hair, which she will deprive herself of in a surge of generosity. Clumsy and impulsive and furious, capable of alternating impulses and anger, she dreams of going to university, of fighting alongside his father in the Civil War. She is the intellectual of the house, the writer full of imagination who composes her stories and reads them in the attic to her sisters.
Following the teachings of her father Amos, Alcott believes deeply in God and in the possibility of improving herself, of making a sort of life pilgrimage towards transcendence, sublimation and improvement, which is symbolized by the little book given by her mother to the daughters at Christmas . This involves a fight for all four girls, but especially for Jo, who has the most difficult character. It will be of great help and comfort to discover that even the mother, apparently infallible, had to fight like her and to keep in check and reform her own nature. In the end, good will triumph over weaknesses, envy, whims and the sisters will find themselves more united than ever. Eventually the pilgrim's transcendent journey will be accomplished.
/http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-eZIb55Dt5JY%2FT_H8MYR4vGI%2FAAAAAAAAAFg%2FbeGdB9qKdzs%2Fs320%2Falcott2.jpg)
CriticaLetteraria: Invito alla lettura: "Piccole donne", il trascendentalismo di Louisa May Alcott
La regione intorno a Boston era semplice e genuina campagna. "Lì", afferma il Cunliff, "l'aspirante scrittore poteva vivere con pochissimo, coltivando un pezzo di terra per trarne il necessario al...
http://www.criticaletteraria.org/2012/07/invito-alla-lettura-piccole-donne-il.html
Da "Twilight" a "Cinquanta sfumature di grigio", dissoluzione di un mito

Per fanfiction s’intende la continuazione di una storia cult da parte degli appassionati. I lettori affamati di altro materiale possono proseguire la storia, colmare le lacune, resuscitare i loro beniamini, creare sequel o prequel. Nel caso della fanfiction di “Twilight” di S. Meyer, ovvero il famigerato, inflazionato, “Fifty Shades of Gray” - dove Gray sta per Grigio ma anche per il cognome dell’algido, imbalsamato, stoccafissico protagonista - più che di una continuazione si tratta, a quanto pare, di una parodia che ha preso la mano alla scrittrice Erika James.
Nell’introduzione viene spiegato che ella “dreamed of writing stories that readers would fall in love with”. Bene, ci pare che sia proprio ciò che non ha fatto, mentre l’operazione era perfettamente riuscita alla Meyer. E tuttavia, quando un caso editoriale assume tale portata, quando ogni persona che incontri, a qualsiasi latitudine, in qualsiasi studio dentistico o vagone ferroviario, tiene in mano una copia del romanzo incriminato, quando ogni libreria, ogni vetrina, ogni stand di autogrill trabocca di copertine tutte nere con un anodino groppo di cravatta, quando gli alberghi americani hanno sostituito la vecchia Bibbia con le Cinquanta Sfumature, allora non si può liquidare il fenomeno senza nemmeno tentare di capirci qualcosa.
Facciamo un passo indietro, torniamo all’originale, alla saga di Twilight, rivisitazione moderna ma ancora fascinosa del mito della Bella e la Bestia, dove la protagonista, appunto Bella Swan, è una ragazza qualsiasi, una Cenerentola capace di conquistare il principe dei vampiri, Edward, bello fino all’impossibile (cui l’attore del film omonimo non rende giustizia) non incenerito dal sole ma scintillante sotto di esso come un cristallo rifratto, puro di cuore, “vegetariano”, romanticamente lacerato fra i suoi istinti e l’input morale che lo spinge a sublimare il desiderio. Bella lo attira perché il suo sangue ha per lui il più dolce dei richiami, è nettare e delizia, è fragranza e rimorso. Pur di amarla, pur di starle vicino, soffocherà l’istinto omicida, lo trasformerà in protezione, che è poi quello che ogni maschio fa con la sua donna, tenendo a bada l’impulso sessuale, avvolgendolo di tenerezza. Bella Swan è vera, con problemi familiari tangibili, emozioni adolescenziali comuni a molte ragazze della sua età e una naturale propensione alla solitudine, alla malinconia.
Che resta di questi due personaggi in Fifty Shades? Edward Cullen diventa Christian Grey, privo di allure, sexy quanto un manichino da vetrina, maniaco sessuale sadico che si diverte a frustare le sue donne, ad appenderle al soffitto, a flagellarle, a inserire nella loro vagina sfere di piombo, a far loro firmare pedantissimi contratti sul ruolo Dominante/Sottomessa. Al contrario di Edward, Christian non sorride, ghigna, non è tormentato, non è romantico, “I do not make love”, dice, “I fuck hard”, ed è buono solo perché il suo maggiordomo compiacente ci dice che lo è. Christian Gray è un divoratore di fanciulle innocenti, come il suo ispiratore Alec Stoke in “Tess dei d’Urbeville” di cui, a quanto pare, la James è intenditrice. Christian regala alla sua vittima preziosissime edizioni del romanzo di Hardy forse per convincere lei (e pure noi) che nelle sue perversioni c’è qualcosa di letterario.
L’indomita, coraggiosa, Bella Swan diventa la brutta copia Anastasia Steele, un personaggio che non vediamo, che non ha volto, che è sempre tutto un bollore costante, che passa i suoi giorni ad arrossire, a mordersi il labbro e “andare in pezzi” per orgasmi multipli e stellari.
Quasi tutte le scene principali dell’originale Twilight sono fotocopiate nella fanfiction, stravolgendole e togliendo loro dignità. Non c’è trama, non c’è sviluppo, solo un susseguirsi di atti sessuali porno soft, sempre più ripetitivi al punto che, già al quarto o quinto, ci viene da sbadigliare: “oddio, no, lo fanno ancora.”
Bella Swan scopre, attraverso Edward Cullen e la sua gente, un mondo diverso, magico, sotterraneo, parallelo, dove vampiri e lupi mannari sono credibili e coerenti con questa nostra realtà moderna, con la realtà di tanti adolescenti americani.
La visita di Bella/Anastasia alla famiglia Cullen/Gray è un esempio di come l’inventiva, la fantasia e l’ironia della Meyer vengano trasformate dalla James in volgarità e pochezza. Persino i nomi dei padri dei protagonisti maschi si somigliano, Carrick, il padre di Gray, riecheggia Carlisle, il medico vampiro padre di Edward. Ma dove è finita la tensione morale, la lotta contro l’istinto che trasforma un vampiro potenzialmente letale in chirurgo compassionevole, sempre pronto ad aiutare chi soffre? Mentre Bella affronta con coraggio e ironia la famiglia vampira, sperando di non diventare lei la cena, confidando sull’istinto che le indica quelle persone come buone e capaci di proteggerla dal male, Anastasia Steele si presenta all’incontro senza mutande, fa piedino sotto il tavolo al suo dominante e sgattaiola appena può nella dependance per consumare l’ennesimo atto sessuale. Il divertimento è assente, il gioco è più osceno che erotico, la trama è solo un pretesto. Non c’è passione vera, solo l’iniziazione al sesso di una ragazzina che dice di volere di più dal suo mentore ma che, in realtà, ha in testa solo una cosa. Anastasia precipita in una spirale di perversione crescente, vittima consenziente di uno stalker, un uomo che gode a prenderla a cinghiate e la fa sentire umiliata e paga allo stesso tempo. Per riflettere, ella colloquia in continuazione con il suo subconscio e con la sua dea interiore, buona coscienza l'uno, cattiva l'altra, che sono, paradossalmente, forse i personaggi più vivi del libro, sebbene ce li immaginiamo come genietti saltellanti con un fumetto fuor dalla bocca.
Laddove l’originale vampiro sapeva commuovere, creare atmosfera, oscurità, amore, e dare corpi, volti e gestualità ai personaggi di una saga indimenticabile, qui tutto è narrato con un linguaggio ripetitivo, infarcito di una serie di mail soporifere, condito delle medesime esclamazioni infantili, “oh my”, dei medesimi aggettivi ed espressioni per descrivere scene ed emozioni sempre identici.
Quale sarà il motivo dell’incommensurabile successo planetario di una fanfiction, di una semiparodia nata su commissione? Per il primo libro la parte del leone la fa certamente la curiosità, stimolata dal passaparola, dalla sovrabbondanza di copie visibili ovunque, ma per arrivare a comprare il secondo e il terzo bisogna forse chiamare in causa lo stimolo sessuale cui si sottopongono le pruriginose lettrici, il voyerismo, il sadomasochismo latente in ognuno di noi. Oppure la voluta indeterminatezza della protagonista - la quale più che essere in realtà non è, non è bellissima, non è intelligentissima, non è brillantissima – fa sì che con lei si possano identificare milioni di donne anonime, desiderose di immaginarsi sessualmente irresistibili e capaci di catturare un bello-ricco-superfigo?
Non sappiamo la ragione di tanto furore e vorremmo che chi è arrivato alla fine della saga ce lo spiegasse perché, se errare è umano, perseverare fino al terzo libro pensiamo sia davvero diabolico.
By fanfiction is meant the continuation of a cult story by fans. Readers hungry for other material can continue the story, fill in the gaps, resurrect their favorites, create sequels or prequels. In the case of the fanfiction of "Twilight" by S. Meyer, or the infamous, inflated, "Fifty Shades of Gray" - where Gray stands for Gray but also for the surname of the icy, embalmed, stockfish protagonist - more than a continuation it is, apparently, a parody that took the hand of the writer Erika James.
The introduction explains that she "dreamed of writing stories that readers would fall in love with". Well, it seems to us that it is precisely what she did not do, while the operation was perfectly successful witht Meyer. And yet, when an editorial case takes on such significance, when every person you meet, at any latitude, in any dental office or railway wagon, holds a copy of the novel in your hand, when every bookstore, every showcase, every autogrill stand overflows of all black covers with an anodyne lump of a tie, when American hotels have replaced the old Bible with the Fifty Shades, then the phenomenon cannot be dismissed without even trying to understand.
Let's take a step back, go back to the original, to the Twilight saga, a modern but still fascinating reinterpretation of the myth of Beauty and the Beast, where the protagonist, precisely Bella Swan, is an ordinary girl, a Cinderella capable of conquering the vampire prince, Edward, beautiful to the impossible (to which the actor of the homonymous film does not do justice) not incinerated by the sun but sparkling beneath it like a refracted crystal, pure in heart, "vegetarian", romantically torn between his instincts and the moral input that pushes him to sublimate desire. Bella attracts him because his blood has for him the sweetest of calls, it is nectar and delight, it is fragrance and remorse. In order to love her, even to be close to her, she will suffocate the murderous instinct, transform it into protection, which is what every male does with his woman, keeping the sexual impulse at bay, enveloping him with tenderness. Bella Swan is true, with tangible family problems, adolescent emotions common to many girls of her age and a natural propensity for solitude, for melancholy.
What remains of these two characters in Fifty Shades? Edward Cullen becomes Christian Gray, free of allure, as sexy as a window mannequin, a sadistic sexual maniac who enjoys whipping his women, hanging them from the ceiling, scourging them, inserting lead balls into their vagina, making them sign very pedantic contracts on the Dominant / Submissive role. Unlike Edward, Christian does not smile, he grins, he is not tormented, he is not romantic, "I do not make love", he says, "I fuck hard", and is only good because his compliant butler tells us that he is. Christian Gray is a devourer of innocent maidens, like his inspirer Alec Stoke in "Tess of d'Urbeville" of which, apparently, James is an expert of. Christian gives his victim precious editions of Hardy's novel, perhaps to convince her (and we too) that there is something literary about his perversions.
The indomitable, brave, Bella Swan becomes the draft Anastasia Steele, a character we don't see, who has no face, who is always a constant boil, who spends her days blushing, biting her lip and "going in pieces ”for multiple and stellar orgasms.
Almost all the main scenes from the original Twilight are photocopied in the fanfiction, distorting them and taking away their dignity. There is no plot, there is no development, only a succession of soft porn sexual acts, more and more repetitive to the point that, already in the fourth or fifth, we are yawning: "oh god, no, they make sex again."
Bella Swan discovers, through Edward Cullen and her people, a different, magical, underground, parallel world, where vampires and werewolves are credible and consistent with our modern reality, with the reality of many American teenagers.
Bella / Anastasia's visit to the Cullen / Gray family is an example of how Meyer's inventiveness, imagination and irony are transformed by James into vulgarity and littleness. Even the names of the fathers of the male protagonists are alike, Carrick, Gray's father, echoes Carlisle, the vampire doctor who is Edward's father. But where is the moral tension, the fight against instinct that transforms a potentially lethal vampire into a compassionate surgeon, always ready to help those who suffer? While Bella faces the vampire family with courage and irony, hoping not to become their dinner, trusting the instinct that indicates those people as good and capable of protecting her from evil, Anastasia Steele shows up at the meeting without underwear, she caresses a foot underneath the table to its dominant and sneaks as soon as she can in the annex to consume yet another sexual act. Fun is absent, the game is more obscene than erotic, the plot is just an excuse. There is no real passion, only the initiation into sex of a young girl who says she wants more from her mentor but who, in reality, has only one thing in mind. Anastasia falls into a spiral of growing perversion, a willing victim of a stalker, a man who enjoys to make her feel humiliated. She continuously talks with her subconscious and with her inner goddess, good conscience, bad conscience, who are, paradoxically, perhaps the most alive characters of the book, although we imagine them as jumping little geniuses with a comic out of the mouth.
Where the original vampire knew how to move, create atmosphere, darkness, love, and give bodies, faces and gestures to the characters of an unforgettable saga, here everything is narrated in a repetitive language, stuffed with a series of soporific emails, topped with the same childish exclamations, "oh my", of the same adjectives and expressions to describe always identical scenes and emotions.
What is the reason for the immeasurable worldwide success of a fanfiction, of a semi-parody born on commission? For the first book, the lion's share certainly is curiosity, stimulated by word of mouth, by the overabundance of copies visible everywhere, but to get to buy the second and third, it is perhaps necessary to call into question the sexual stimulus to which the itchy readers undergo, and the voyerism, latent sadomasochism in each of us. Or the intentional indeterminacy of the protagonist – who, more than being, she “is not”, she is not beautiful, she is not extremely intelligent, she is not brilliant. This means that millions of anonymous women can be identified with her, eager to imagine themselves sexually irresistible and capable of to capture a handsome-rich-super-cool?
We do not know the reason for such fury and we would like those who arrived at the end of the saga to explain it to us because, if to err is human, to persevere until the third book we think is truly diabolical.
/http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-2Wx-dt3LKOc%2FUGatHfgcqaI%2FAAAAAAAAB_c%2F7lKuQP6D8XU%2Fs1600%2Ftwilight-series-covers-twilight-series-1381301-956-360.jpg)
Per fanfction s'intende la continuazione di una storia cult da parte degli appassionati. I lettori affamati di altro materiale possono proseguire la storia, colmare le lacune, resuscitare i loro ...
http://www.criticaletteraria.org/2012/09/criticalibera-da-twilight-cinquanta.html
Andersen a Livorno
/image%2F0394939%2F201301%2Fob_16302cdc2645c40fce3e1b40055f8279_andersen-top.jpg)
A cura di Vibeke Worm e Patrizia Poli
Hans Christian Andersen (1805 – 1875) è famoso in tutto il mondo per le sue fiabe, fra cui “La principessa sul pisello”, “La sirenetta”, “I vestiti nuovi dell’imperatore”, “Il Brutto anatroccolo”, “La piccola fiammiferaia”, “Il soldatino di stagno”, “La regina delle nevi”
Non tutti sanno che fu anche un instancabile viaggiatore e durante i suoi numerosi spostamenti scrisse molti diari di viaggio.
Nella Biblioteca reale di Copenhagen è possibile consultare le pagine che riguardano il suo passaggio nella nostra città.
La danese Vibeke Worm ha rintracciato per noi le pagine dedicate al soggiorno di Andersen nella nostra città e le ha tradotte dal danese ottocentesco in inglese. Noi abbiamo provveduto a ritradurle in italiano per voi. Lo stile è veloce, guizzante, incisivo.
1833 dal diario
6 ottobre. Abbiamo affittato un vetturino e guidato allegramente le sei miglia verso Livorno. Abbiamo incontrato parecchi cacciatori e ci siamo imbattuti in una bella foresta di querce e in filari di aranci.
Gli Appennini avevano un paio di picchi elevati, per il resto la zona era piatta, e a Livorno è stato tutto un po’ noioso. Una città sporca, con un bel porto dall’acqua verde. Abbiamo visto le coste della Corsica e dell’Elba, è capitato un vapore da Genova, abbiamo parlato con due svedesi e avuto un asino per Cicerone, che ci ha preso 4 franchi e non ci ha mostrato nulla. Ci ha detto cose come: “Ci dovrebbe essere un mercante turco, ma il suo negozio è chiuso, c’è una chiesa con un bel dipinto ma il dipinto manca.”
Il duomo non è niente di speciale, un soffitto carino, ma è tutto sudicio. La chiesa greca era chiusa. Il cimitero inglese fuori la città era tutto tombe di marmo di Carrara, abbiamo trovato anche un paio di sepolture Svedesi.
Per strada abbiamo visto molti greci. La sinagoga, che doveva essere una delle più belle e ricche d’Europa, mi ha fatto una brutta impressione. La gente saliva una scala in un albergo e nella chiesa che sembra la Borsa, tutti avevano il cappello e spettegolavano sulla bocca degli altri. Sudici bimbi ebrei stavano ritti sulle sedie e un Rabbi, su una sorta di pulpito, rideva e scherzava con degli anziani. Per avanzare, Tappernaklet si fece largo a gomitate come se dessero i biglietti per il teatro, nessuno pensava alla devozione. Sopra di noi, nella galleria, sedevano le donne nascoste da una grande griglia, qui dovevano essere trattate come in Spagna ed erano molto timide.
Al porto c’è una statua di marmo di Ferdinando I°, quello sopra il figlio Cosimo II°, con 4 schiavi di bronzo incatenati alla statua, uno, un negro, aveva uno sguardo molto malinconico, era orribile da vedere e sarebbe un onore aiutarlo!
La nostra finestra guardava il mare, il sole era piacevole, giù dietro il faro, era come una nave sull’orizzonte. Le colline erano grigio blu, e delle strane nuvole strappate erano appese in cielo come lance d’oro in cielo. Livorno è brutta, piatta e sporca, ma il cielo, il mare e le belle colline sono una cornice che rende degna la pittura, potrebbe anche essere piacevole stare qui un po’ di tempo.
La gente: specialmente le donne camminano per le strade in tale quantità che sembrano una processione, ho visto dei turchi con teste caratteristiche e bei ragazzi greci. Una spagnola, con neri occhi di fuoco e un velo sottile, mi è passata vicina, com’era bella!
Sul pavimento abbiamo tappeti brillanti, divani orientali, ma ci vogliono dai 5 ai 9 franchi per pranzare, siamo andati in trattoria e abbiamo mangiato con due franchi.
Non si sa se è più bello il cielo limpido e azzurro, il mare blu, o le montagne cerulee. È uno stesso colore in diverse espressioni, è come l’amore pronunciato in tre lingue differenti. (Oggi il nostro vetturino ha cantato una aria d’opera mentre ci guidava fuori strada.)
Lunedì 7 ottobre.
Questa mattina mi sono vegliato al rumore di catene, erano incatenati a due a due, uno rosso e uno giallo. […]
Siamo usciti sul porto. Il molo è coperto da blocchi di pietra color terra. A pranzo eravamo a Pisa. Sono andato alla torre e alla chiesa. Le strade erano un mortorio, mi sono ficcato in vicoli così stretti e silenziosi che mi era presa l’ansia, finalmente mi sono ritrovato in uno spazio verde, c’era una statua colossale di marmo del granduca Leopoldo I° con in mano uno scettro dorato.[…]
Martedì 8 ottobre.
Da Pisa a Firenze. Davvero un’ottima strada, guidavano come matti, siamo arrivati a Firenze in otto ore. Nell’Arno c’era poca acqua...

/image%2F0394939%2F20190531%2Fob_6113d1_61425960-10216728261030327-19684367693.jpg)


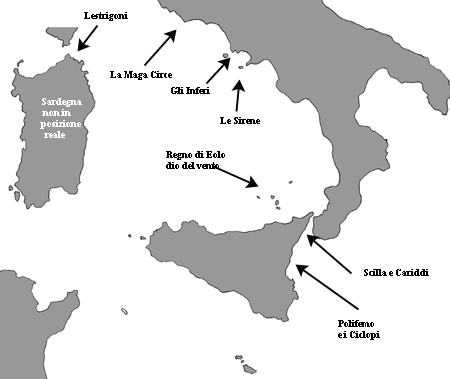
/http%3A%2F%2Fwww.livornomagazine.it%2FLivorno-arte-cultura%2FSCRITTORI%2Fandersen-brutto-anatroccolo.jpg)
