gianluca pirozzi
Libri sotto l'albero: Gianluca Pirozzi, "Come un delfino"

Come un delfino
Gianluca Pirozzi
L’Erudita, Giulio Perrone, 2019
Una storia di perdita, dolore e necessità d’essere forti. Un’angoscia che ti resta appiccicata addosso anche quando hai finito il libro, una sofferenza che senti tua, perché può capitare a tutti di non avere più improvvisamente qualcuno che si ama.
La storia comincia come un raffinato e colto bildungsroman, scritto con un bello stile quasi d’altri tempi. Vanni è figlio di uno scultore egocentrico e irascibile, che vive solo della propria arte e condiziona la famiglia con i suoi sbalzi di umore e le sue scenate. Bersaglio dei suoi malumori soprattutto la nonna Iole, a cui Vanni è molto affezionato. La prima perdita sarà proprio lei. Poi sarà la volta di Maso, il fratello minore amato e inseparabile. Un incidente con lo slittino lo porterà via troppo presto.
Vanni reagisce allontanandosi, non può respirare la stessa aria del padre, non può vivere nella stessa casa dove Maso e nonna Iole non ci sono più. Crescendo, viene a patti con la propria sessualità, prova a costruire dei legami stabili, prima con Federico e poi con Piermaria. La sua richiesta d’amore - la stessa che continua inconsciamente a porre a suo padre - viene disattesa finché non incontra lo spagnolo Tiago. Tiago è calmo, è sereno, prende la vita con naturalezza, ha fiducia che le cose vadano per il verso giusto se solo ci si lascia trasportare. Nonostante la lontananza, il loro amore è forte, è tenero, è complice. Fino alla scelta di diventare padri con l’aiuto di un’amica.
Ma la sorte ha in serbo ancora dolore, un’altra lacerazione straziante, un nuovo, tremendo squarcio che rimette in discussione tutte le certezze e tutta la felicità conquistata.
Un romanzo che si svolge su due piani: uno narrativo, costruito con sapienti balzi temporali e dialoghi perfetti, e uno centrale diaristico. Un racconto circolare, incentrato sui temi fondamentali della paternità e della morte. Vanni sente la mancanza di una figura paterna amorevole ma questo non gli impedirà di nutrire il desiderio di diventare padre a sua volta, affrontando il difficile compito di esserlo in una situazione estrema. E, dopo aver fatto per tutta la vita i conti con la morte prematura del fratello, alla fine dovrà imparare a convivere con le assenze, ricostruendo un nuovo centro.
Un romanzo delicato, bello e struggente, di quelli che vorresti leggere più spesso.
Radio Blog: Gianluca Pirozzi, "Nomi di donna"

"È così difficile trovare una raccolta di bei racconti e questi, contenuti in Nomi di donna di Gianluca Pirozzi, belli lo sono davvero, anzi di più. Sono originali, raffinati, scritti con maestria, sembra di avere fra le mani già un classico."
Una nuova recensione scritta da Patrizia Poli ci farà conoscere la raccolta di racconti di Gianluca Pirozzi Nomi di donna - L'Erudita edizioni.
Buon ascolto!
Lettura di Chiara Pugliese
Di buon'ora

Da oltre quaranta anni Gianni si alza di buon’ora. Negli ultimi anni poi, proprio quando la notte cede il passo alla prima luce del mattino, lui ha preso l’abitudine di indossare abiti comodi, ficcare i piedi nelle scarpe lasciate all’ingresso e far scattare un paio di volte il gancio del guinzaglio di Full, quel tanto che serve a svegliare il suo cane, per uscire di casa.
Giù in strada, lui e Full fanno quasi sempre lo stesso percorso: marciapiede di Via Ricasoli, portici intorno a Piazza Vittorio e, a meno che non piova al punto d’accorciare la passeggiata, arrivano a Via dello Statuto e, da lì, attraversando Via Merulana, raggiungono il Colle Oppio.
Sia all’andata che al ritorno, Gianni e Full si muovono in completa e silenziosa armonia. Nella passeggiata di mezzogiorno o in quella della sera, loro due conservano la propria, distinta, identità al punto che, sebbene si dirigano verso la stessa meta e da questa, ugualmente insieme, facciano ritorno, ciascuno pare animato da pensieri e movimenti che non sempre coincidono. Di buon’ora, invece, l’uomo e il cane si aggirano per le vie del quartiere come parti di uno stesso corpo: rallentano, si fermano e riprendono a camminare, senza che l’uno contrasti, neanche marginalmente, con l’altro. Gianni modera il passo come anch’egli desideroso d’annusare qualche ruota, un angolo di marciapiede o un avanzo di cibo e Full riduce la propria andatura, alcune volte scodinzolando, altre volte mettendosi seduto ad aspettare che Gianni abbia scattato, come ha preso l’abitudine di fare da qualche tempo, una fotografia ad uno dei tanti barboni che dormono sotto i portici della piazza o, quando la stagione è più calda, tra i giardini del Colle Oppio.
Gianni ha iniziato ad alzarsi di buon’ora al tempo in cui s’è trasferito a Roma, da quando, per evitare il traffico e la calura che ingabbiavano l’ultimo piano della casa di Largo Preneste, ha cominciato a puntare la sveglia alle cinque del mattino; qualche volta addirittura prima. È a quel periodo che risale la scoperta di un piacere di cui Gianni non si è più voluto privare. Anche negli anni seguenti, quando è diventato ricercatore dell’università e, più tardi, professore, Gianni ha rinunciato a questa abitudine solo in casi eccezionali. Negli ultimi anni, poi, alzarsi anche solo un’ora più tardi ma avere intorno a sé voci, rumori, immagini, tutto già nitido, gli è diventato insopportabile: è come se il suo cervello per mettersi in funzione, per esser in grado d’affrontare la giornata, il traffico, la metro, gli studenti e ogni altra quotidiana attività, avesse bisogno di far succedere al sonno una serie di istanti vuoti, uno spazio che, pur non rimanendo completamente astratto come nel sonno, venga a popolarsi a poco a poco.
Anche quando la sua casa si è andata progressivamente riempiendo di altre presenze, Gianni ha usato quelle prime ore del mattino per prolungare la dimensione ovattata in cui, mollemente e in solitudine, si è dedicato ad attività apparentemente inutili, come starsene seduto qualche tempo fuori sul terrazzino ascoltando i primi rumori della città mentre si fa giorno, oppure restare immobile contro lo stipite della porta, davanti ai letti dei suoi due figli, ancora addormentati. È stato proprio nei loro primi anni di vita che Gianni ha iniziato a osservare quelle creature così uguali immerse nel sonno e a domandarsi se potessero esser animati pure da sogni identici.
Molti anni più tardi, quando Lucia e i gemelli se ne sono andati, Gianni s’è disfatto definitivamente dell’orologio sul comodino, proprio come se tale gesto suggellasse la conquista di un piacere antico da cui, adesso, nessuno più avrebbe potuto distoglierlo: da quel momento è stato lui il signore assoluto di quello spazio e di quel tempo che iniziano quando non puoi dire se è ancora notte oppure è già mattino, e che vorresti prolungare all’infinito.
Di buon’ora, attraverso gesti lenti, articolando pensieri corti, Gianni è divenuto sempre più capace di assaporare ogni istante di tale dimensione: adesso sa riconoscere e assecondare i percorsi liquidi che la sua mente fa passando gradualmente dalla formulazione di idee pure, primo abbozzo di logica, ad un’articolazione appena più complessa, in cui la sintassi scivola da un’idea principale, nutrita al più da una dipendente, verso nuovi e inaspettati legami di coordinazione. In questa condizione, Gianni avverte sempre lo stesso stupore che s’accompagna al venire a galla dei propri sensi, uno ad uno senza fretta: a volte è il fruscio delle lenzuola sul pigiama, altre lo stridere di un motore giù per strada da una distanza che non puoi ancora definire, altre ancora è il rumore di un treno che inizia il proprio viaggio. E benché le immagini dalla finestra della sua camera gli appaiano sempre uguali, tutto questo scorgere, annusare, ascoltare la città, è per lui parte di un rito che ha bisogno di pochissime parole dette o ascoltate. Di buon’ora, infatti, le frasi che Gianni pronuncia sono brevi, al limite dell’essenzialità: sono esortazioni al suo cane, come un “andiamo” o un “si torna”, un augurare “buongiorno” con un sorriso colmo di gentilezza ad un barbone lungo la strada o un “come va?” domandato a Habib, il giornalaio che, per un tempo, Gianni ha ospitato in casa sua.
Ma stamani Gianni sa d’essere pronto: Asunción, la nuova donna peruviana che da circa un mese lo aiuta in casa, pare in grado di poter finalmente badare anche a Full e pure il cane non sembra avere più paura di lei.
Di buon’ora, come sempre, Gianni ha aperto gli occhi, ha scostato il lenzuolo da sé, si è alzato per avviarsi lungo il corridoio; supera il bagno, mollemente oltrepassa pure la cucina ed arriva al terrazzino. Lì fuori è sempre così bello assaporare quei primi brividi che ti salgono appena lungo le gambe e, stamani, giù in strada non s’avverte alcun rumore, pure i furgoni del mercato paiono silenziosi. E tutto intorno c’è la brina: è lì, proprio sulla tovaglia di plastica del tavolo e la si riesce a vedere sulle piante, ferma sulle foglie del limone che a quest’ora paiono brillare quasi fossero pezzetti di lamiera appena illuminati dalla luce.
Gianni si siede, di nuovo immobile qualche istante, appena il tempo di tirare un paio di lunghi e profondi respiri. Poi, lentamente, si alza, avvicina il tavolo alla ringhiera e con un movimento in due tempi, decide di salirci sopra: che spettacolo da quell’altezza! Si possono vedere i binari fin giù all’acquedotto e, più lontano, l’intero profilo disegnato delle montagne che sembrano illuminate da un neon. Se poi si volge a destra, oltre la prima fila di palazzi, riesce a distinguere persino i tavoli e le sedie ancora impilate sulla terrazza del Radisson. Se gira, invece, la testa verso sinistra, in-travede addirittura le chiome delle palme e dei platani più alti di Piazza Vittorio. Se poi guarda in basso, Gianni può, finalmente, lasciarsi cadere. E lo fa.
Rosa

Non ha mai detto a nessuno quando esattamente l’ha scoperto, o meglio, quando le è accaduto di conquistarne una piena consapevolezza che quel gesto costituiva il solo, possibile, rimedio. È certo che per giungere a quella soluzione Rosa ha seguito un estenuante percorso empirico fatto di tentativi innumerevoli che - ora perché complessi, ora perché infruttuosi - l’avevano di volta in volta condotta a disperare di poter definitivamente controllare quella paura di esser inadeguata e incapace di fronteggiare i possibili imprevisti e le contrarietà con cui tutti, prima o poi nella vita, devono fare i conti.
Per Rosa, infatti, anche adesso che mancano pochi giorni al proprio settantatreesimo compleanno e sebbene la vita le abbia regalato un’esistenza tutto sommato felice, un marito che le è ancora accanto, una figliola responsabile e coscienziosa - come lei ama ripetere - e soprattutto Tiziana, la sua unica adorata nipote, vi sono dei momenti nei quali quella strana ansia sembra poter prendere il sopravvento. Ed allora, l’unico espediente serbato intatto negli anni con il quale Rosa può recuperare la calma interiore, consiste ancora nel chiudersi in bagno - non in un bagno qualsiasi, ma proprio quello della sua abitazione. Questo spiega la riluttanza con la quale, per tutta una vita, Rosa ha evitato qualsiasi viaggio che avesse una durata superiore alla settimana, per esser sicura di rintanarsi nella quiete di quello spazio, immergersi per una durata che può variare da un minimo di pochi minuti a fin oltre la mezz’ora, in modo da sottrarsi (momentaneamente) ad ogni altra occupazione e preoccupazione.
A Rosa piace, infatti, restarsene così segretamente confinata tra le pareti maiolicate, egoisticamente abbandonata al benefico effetto liberatorio prodotto dall’adagiarsi con le parti più intime della sua persona in un bagno di acqua calda. Molto calda.
Sì, è proprio il sollevare le proprie vesti, liberarsi della biancheria intima, andarsi a sistemare a cavalcioni del bidet già ripieno di acqua, che le consegna finalmente lo stato di calma e di benessere di cui ha ripetutamente bisogno. Rosa, infatti, non ha mai veramente prestato ascolto ad altri suggerimenti - come quelli delle amiche cui aveva confidato quelle ansie.
Nulla è come quel bagno caldo; né tisane rilassanti, né immersioni dell’intero corpo nella vasca da bagno (magari sciogliendovi del bicarbonato o qualche goccia di oli essenziali), né tantomeno lunghi pediluvi - seguiti da qualche manipolazioni ai plantari con creme o speciali balsami odorosi d’Oriente. O, piuttosto, passeggiate nel verde, esercizi di respirazione, ascolto di qualche brano di musica classica o, ancora, la pratica di piccole prove di manualità come il ricamo, il lavoro ai ferri o all’uncinetto - tutte pratiche nelle quali si è sempre destreggiata con risultati eccellenti - la gastronomia, la lettura o, ancora, l’applicarsi in qualche rompicapo o, infine, alcuni semplici istanti di completo ed assoluto riposo, restandosene distesa sul letto con la mascherina sugli occhi… nulla, proprio nulla, è per Rosa, neanche lontanamente paragonabile allo stato di sollievo che s’accompagna alla pratica del bidet.
E, sebbene tale assoluta consapevolezza sia emersa in età adulta, Rosa doveva averlo però intuito sin da bambina, da quando aveva più o meno l’età che ha ora la sua unica nipotina, Tiziana, con la quale Rosa trascorre quasi tutti i suoi fine settimana. Di quella intuizione, Rosa ricorda d’aver deciso di mantenere un certo riserbo, mettendone a conoscenza solo le persone più care. E le ci erano voluti almeno cinque anni di matrimonio prima di potersi sentire libera di rispondere alle domande ed alla curiosità di Ennio - suo marito - in relazione all’abitudine di sottrarsi improvvisamente alla vita familiare per concedersi quelle soste nella sala da bagno, e più tradi solo al compimento del decimo anno di età di Susanna - sua figlia - aveva confidato anche a lei il suo segreto.
Più tardi, quando era ormai una donna adulta - ispirata, forse, da una gita fatta a Caserta per visitare la Reggia - Rosa ha scoperto (sorridendone intimamente) che la regina Maria Carolina doveva aver nutrito, secoli prima di lei ma probabilmente con la medesima consapevolezza, la sua stessa inclinazione, avendo fatto installare nella stanza reale un bidet, arredo rarissimo all’epoca. A sua volta, proprio per rendere più confortevole e proficua la permanenza in bagno, Rosa ha vi ha introdotto alcuni accorgimenti specifici, non solo il telefono per eventuali urgenze ma, soprattutto, il piccolo tavolino pieghevole che ha sistemato per anni a cavallo del sanitario, così da potersene stare comodamente assisa per dedicarsi - contemporaneamente all’immersione - alla lettura di un libro o della rivista di giardinaggio e, financo (durante gli anni del suo insegnamento di greco e latino) alla correzione dei compiti dei suoi alunni di liceo.
Che fosse mattina tarda, pomeriggio o sera tardi, senza bisogno di dare troppe spiegazioni, Rosa ha sentito sempre il bisogno di quei ricoveri che ha preannunciato ad Ennio o a Susanna utilizzando sempre la stessa frase come mi ritiro per qualche momento oppure, in casi rari, vado a leggere qualcosa di là.
Dunque, non stupì per nulla Ennio, né tantomeno sua figlia, il contenuto dettagliato della seguente richiesta che - insieme ad una pagina con brevi istruzioni sui pochi beni sottratti alla comunione del patrimonio con suo marito - furono ritrovati nel cassetto del comodino di Rosa circa una settimana dopo la sua scomparsa avvenuta per ischemia cerebrale appena qualche settimana dopo l’improvvisa e terribile morte della sua adorata nipotina.
“Caro Ennio, Cara Susanna, - così si poteva, infatti, leggere sul primo capoverso della lettera su quella carta azzurrina, sistemata in modo da sporgere appena dal libro La moderna cura delle bulbose, nel quale Rosa l’aveva riposta forse in attesa che fosse ritrovata e certamente anni addietro, forse prima della nascita di Tiziana poiché non vi era alcun riferimento a sua nipote.
Sono certa che più di una volta vi siate interrogati sul perché della mia particolare abitudine, alludo alla consuetudine di richiudermi in bagno per starmene in ozio… Ebbene, vi ho taciuto, e me ne dolgo, il racconto di quanto occorso nei primi anni della mia vita, sia per desiderio di non creare in voi - meglio ammetterlo, soprattutto in me - un ulteriore imbarazzo e la necessità di ripercorrere con voi questo doloroso evento, sia perché, lo ammetto, ho finito per dubitarne io stessa della veridicità dell’accaduto non avendo altri testimoni se non i miei ricordi e preferendo - perché meno tragico - reputarlo frutto della mia pura immaginazione.
Il fatto risale ai miei primissimi anni di vita, potevo avere circa due anni. So che non può esser accaduto dopo poiché la persona - Assuntina - la donna cui collego l’episodio, sarebbe scomparsa poco prima del compimento della mio quinto anno di vita, ed io sarei stata affidata alle cure di Celestina, la balia che sarebbe rimasta in casa nostra fino al mio matrimonio. Assuntina, come poi sarebbe stato confermato da mia madre, qualche anno più tardi aveva dovuto far appello alle sue più ancestrali conoscenze in campo di puericultura per frenare il pianto ininterrotto cui mi abbandonavo sin dai primi istanti di vita ogni giorno, all’imbrunire. Io conservo ancora il preciso ricordo di quegli strazianti singhiozzi cui ero preda appena si faceva sera e che parevano non concedermi tregua per tutta la notte, destandomi nel sonno. Qualcuno, raggiunta io la maggiore età, avrebbe ipotizzato che questo sentimento - che io a volte ho interpretato come sopraffazione, altre come agitazione o, ancora, sconforto, e che mi ha accompagnato nel corso dell’intera mia vita fino a questi giorni - sarebbe stato conseguente al trauma subito al momento della nascita per la perdita dell’altra bambina - la mia gemella - morta durante il parto avvenuto proprio di sera. Ciò sarebbe certamente verosimile, perché a questi miei sentimenti si è sempre accompagnato un senso di ineluttabile perdita, distacco, quasi come se la realtà nella quale sono venuta al mondo e in cui ho finora vissuto sia in qualche modo diversa da quella nella quale ho la percezione di esser stata concepita o a cui sarei stata destinata. Ho compreso col tempo anche il dolore dei miei genitori, il rifiuto inconfessato di mia madre di allattarmi affidandomi invece alle cure totali di Assuntina, proprio perché la gioia della nascita della loro primogenita era stata sopraffatta dalla perdita di mia sorella.
Assuntina riuscì col tempo a trovare un rimedio e a trasmettermi la soluzione. Ogniqualvolta il pianto si faceva convulso, lei immergeva un panno bagnato nell’acqua calda e con questo mi massaggiava le parti intime. Io ho un preciso ricordo del luogo in cui Assuntina utilizzò su di me queste prime, empiriche “cure”. Conservo nella memoria dettagli piuttosto precisi, come la vista dal balcone, il letto della balia accostato alla mia culla, le tende ed il tappeto di quell’appartamento che avremmo lasciato pochi anni dopo e del quale non resta testimonianza neppure nelle immagini fotografiche. Anni più tardi, mia madre mi ha confermato che la stanza nella quale era stata allestita la mia camera da letto aveva le tende a quadri bianchi e rosa come io le rammentavo e che sul letto vi era una coperta ricamata in lana di diverse tonalità di verde, il che mi ha dato certezza della veridicità di quei miei primissimi ricordi. Quando ebbi l’età di camminare, persistendo in me il senso di ansia e le crisi di pianto serali, Assuntina prese a sostituire agli impacchi calmanti delle vere e proprie sedute sul vasino, in cui aveva diligentemente versato acqua tiepida. Fu per me naturale, divenuta autonoma, ricorrere da sola a questa soluzione nei momenti più difficili della giornata, nei quali mi sono sottratta temporaneamente alle occupazioni del momento e alla compagnia dei miei cari. Ecco, dunque, spiegatavi la ragione delle mie ripetute assenze. Non me ne volere Ezio. Non me ne volere Susanna”.
Con queste parole Rosa replicò per l’ultima volta al pubblico dei suoi cari il monologo che per una vita aveva perfezionato e recitato a se stessa, sino a persuadersi completamente della sua assoluta veridicità. Non c’era stata, d’altro canto, altra via possibile di fuga per combattere la sofferenza di una violenza impressa nella sua tenera carne di bambina da un padre che, sin dai primi mesi di vita, quasi ogni sera l’aveva morbosamente spogliata ed accarezzata fino ad esplorarle i segreti più intimi dell’animo. Nella versione dei fatti che Rosa aveva provato invano, e per tutta una vita, a raccontarsi e a raccontare quel demone non esisteva più ed al suo posto appariva l’immagine di una balia amorevole ch’aveva lenito i suoi tormenti, l’aveva assistita e coccolata, insegnandole a ripulirsi dalla lordura e dal peso di insostenibili gesti di un padre oscuramente malato.
Tiziana
Illustrazione di Clara Garesio
“Attenta piccolina, stai attenta!” ha iniziato a ripetermi la voce dentro ed aveva tutta l’aria di non volersi zittire.
Talvolta quella voce diventava più insistente, sino a privarmi anche di un unico attimo di tregua ed allora tutto risultava più difficile: impossibile concentrarmi, inutile tentare di riacciuffare per la coda l’ultimo pensiero e proseguire nei miei ragionamenti, vano continuare ogni conversazione e, soprattutto, poter lavorare, dipingere o modellare alcunché. Per non parlare delle volte in cui la voce s’intrometteva tra me e l’ultima parola appena letta su un libro o tra le righe di un articolo di giornale, ascoltata alla radio o per strada. Qualsiasi frase, anche quella più corta, smarriva il proprio senso, perché lei - la voce - era lì, fiera di aver preso il sopravvento su ogni mia azione, padrona assoluta nelle stanze oramai vuote della mia mente in cui iniziava ad echeggiare, simile ad un mantra che cresceva gradualmente d’intensità e così potente da annullare ogni altra percezione.
“Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta!”
Quella volta, mentre stavo raggiungendo Faenza, la cittadina dove avevo vissuto sin da quando, poco più che bambina, avevo scelto di dedicarmi alla mia arte (e che, adesso, mi onorava con un’intera sala del museo della ceramica dedicata ai miei lavori), la voce a bordo del treno regionale che aveva lasciato Bologna alle quindici e dodici minuti ha assunto il tono fatale di un invito alla prudenza: non proprio un allarme, piuttosto un monito, e l’oggetto di tale cautela era lì, davanti a me, indifeso e tenero nei panni di bimba di quattro, al massimo cinque anni.
Avevo appena ascoltato il suo nome - Tiziana - più volte ripetuto dal padre che l’accompagnava. Lei aveva preso posto sul sedile accanto a quello occupato dall’uomo proprio di fronte al mio. Ero stata attirata dalle loro chiome, lo stesso rosso-castano, simile al colore del miele di castagno, indizio palese del legame genetico tra padre e figlia. Dai capelli ero passata ad osservare il viso di quella bambina, le guance paffute come due brioches appena sfornate, solide e delicate allo stesso tempo, la bocca che pareva uscita da una pala di un pittore rinascimentale, con le piccole labbra rosse, inumidite appena. La bambina teneva le manine aggrappate ai braccioli del sedile su cui era stata issata, ma s’intuiva dal fremito con cui pareva tastare la plastica, d’esser sul punto di volersi ergere per iniziare l’esplorazione di quella dimensione di cui alcune parole - treno, viaggio, binario, finestrino - andavano dispiegando.
“Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta!”
Quel pomeriggio, appena il treno per Faenza aveva lasciato la stazione di Bologna lei, Tiziana, aveva mostrato la prima insofferenza per la posizione assegnata, esibendo, al contrario della sollecitazione paterna su quanto all’esterno iniziava a scorrere davanti agli occhi, una curiosità crescente per tutto ciò che all’interno del vagone pareva più generosamente esserle messo a disposizione. E così, infatti, dopo lo stupore per il tavolino a scomparsa collocato proprio sotto al finestrino, era stata la volta del piccolo cassetto per i rifiuti in cui la bimba aveva, con tutta la dovuta approvazione paterna, infilato qualche carta procuratale all’occorrenza. Quindi era gradualmente passata alla conoscenza dei passeggeri più vicini, me compresa. Rapidamente la finta vergogna esibita da principio aveva lasciato il posto ad una confidenza sempre maggiore tanto da indurla a fare capolino tra i sedili delle file limitrofe alla sua e, poi, gradualmente ad allontanarsi ulteriormente per entrare in relazione con qualche altro passeggero, facendo ritorno di tanto in tanto verso il suo papà, così da portarlo al corrente delle novità sperimentate a bordo di quel nuovo mezzo di trasporto sempre ricco per lei d’inaspettate e piacevoli scoperte.
“Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta!”
Mentre osservavo quella bimba, la voce dentro non ha mai smesso di farsi ascoltare. La mia attenzione, nonostante i tentativi di concentrarmi sulle pagine del catalogo che avevo tra le mani, era inesorabilmente rivolta a quella bambina, con un’ansia crescente che la voce, nel suo sommesso, ma ripetuto, scandire continuava ad alimentare.
Liberatasi dal cappottino di lana color azzurro pallido, che era perfettamente abbinato alla calzamaglia di lana fitta a righe che le fasciava le gambe cicciotte, Tiziana ormai aveva preso familiarità con l’intero vagone dell’interregionale per Faenza, destreggiandosi avanti e indietro, da una porta all’altra della nostra carrozza, esibendo una fiera disinvoltura e uno stupefacente equilibrio malgrado i continui sobbalzi indotti dagli scambi.
Dopo aver ascoltato con espressione leggermente imbronciata le indicazioni del padre sul tragitto da percorrere per attraversare l’intero vagone, intuendo probabilmente che più che rassicurare lei, servivano a tranquillizzare gli altri passeggeri, ritornava di volta in volta ad un capo del nostro vagone dove, attendendo di esser osservata, si deliziava dell’effetto prodotto dal pulsante per azionare la porta di collegamento tra la nostra carrozza e quella successiva.
Dopo una serie di operazioni che nella loro ripetitività avevano perso per me ogni particolare attenzione, avevo osservato Tiziana rientrare al suo posto, dove era rimasta ancora qualche minuto in attesa dello spettacolo annunciatole dal padre. Ma le poche mucche al pascolo l’avevano lasciata indifferente, così come il treno carico di autovetture che avevamo superato, le ciminiere degli impianti industriali ed i relativi pennacchi di fumo in lontananza, persino i nidi delle cicogne ben visibili sui rami di alcuni alberi. La bambina aveva domandato, invece, notizie sui veicoli che filavano in direzione opposta alla nostra e chiesto se stessero dirigendosi pure loro a Faenza seguendo una strada più corta. Ma anche le spiegazioni e i ragionamenti apparentemente lineari della mia vicina di posto, avevano finito con l’annoiarla, tanto che poco dopo la bambina aveva domandato ed ottenuto dal padre il permesso di lasciare nuovamente il proprio sedile per andare a mettersi al centro del corridoio dove il dondolio del treno pareva interessarla infinitamente.
“Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta!”, mi ripeteva ancora la voce mentre Tiziana barcollando proseguiva avanti e indietro tra i sedili, per fermarsi in prossimità degli altri passeggeri, attirata probabilmente da qualcosa di nuovo: era stato così per il controllore che aveva raggiunto la nostra carrozza e, subito dopo, per il contenitore termico nel quale io trasportavo il doppio espresso e che avevo poggiato sul tavolino. Tiziana mi si era avvicinata e, con le manine serrate sul bracciolo della poltrona, aveva affermato: Cappuccino, tanto che, quasi a volermi scusare, m’ero affrettata a rispondere: “No, tesoro mio. È solo caffè!... Come ti chiami?” “Tiziana” mi aveva risposto lei immediata ed altrettanto prontamente mi aveva chiesto “E tu come ti chiami?”
“Clara, tesoro mio. Mi chiamo Clara…”
“Dove vai?”
“Vado a Faenza”
“Pure io”
“Vai dalla nonna?”
“No amore, non vado dalla tua nonna. Vado in un Museo, il Museo della ceramica di Faenza, lo conosci? Ci sei mai stata?”
“Perché vai al Museo?”
“Vado a vedere una mostra. Vuoi venire con me?”
“No!” aveva tagliato corto la bimba, che si era rivolta allora al suo papà, attirata questa volta da una valigia con le ruote, lasciata proprio di fianco al sedile della fila successiva alla sua. Giunta accanto al bagaglio di plastica, Tiziana aveva indugiato qualche attimo e, poco dopo, aveva detto apparentemente senza alcun significato: “Nonna… nonna”. Era stato il papà, a rendere intellegibile quell’associazione: “Sì, è proprio come la valigia di nonna Rosa che ti piace tanto. Ma questa qui, Tiziana, è la valigia del signore, non quella della nonna. Vieni qui!” aveva proseguito l’uomo senza perdere la pazienza. “Ritorna al tuo posto perché, adesso, il treno sta andando più veloce e tu non puoi rimanere qui in piedi, altrimenti cadi!”.
Il papà aveva tentato di riportare la bambina in direzione del sedile, ma quel proposito non era andato a buon fine, tanto che all’accenno di ritornare a sedersi Tiziana aveva mostrato tutta l’ostinazione di cui una creatura così piccola sa esser capace. “Va bene…” aveva, infine, detto l’uomo, “Io vado a sedermi, tu rimani qui, ma tieniti bene e non dare fastidio alle persone. Capito?”
“Si!” aveva risposto Tiziana con un’espressione simile a quella di chi pregusta ogni possibile vantaggio della riconquistata libertà.
“Attenta piccolina, stai attenta Attenta piccolina, stai attenta Attenta piccolina, stai attenta!”
Avevo rimesso gli occhi sulla pagina del mio catalogo, mentre la voce che avevo dentro, sebbene non sopita, sembrava essersi fatta appena più lieve, forse, perché la bimba era ritornata indietro alla fila dei sedili anteriori attirata da qualcosa di nuovo (la cui vista mi era inizialmente ostruita) ma che, per l’espressione di curiosità, stampata in faccia a Tiziana, costituiva per lei fonte di nuova e magnetica attrazione. Il motivo per il quale la bambina sembrava non volersi schiodare dalla posizione in cui si trovava, traballante e a cavallo tra le due carrozze, lo compresi poco dopo: era il giochino elettronico che un altro bambino, qualche anno più grande di lei ed in attesa di entrare nella toilette, teneva serrato nelle proprie mani, muovendo appena le dita sui tasti. Solo dopo varie richieste da parte della mamma, il bimbo pareva essersi arreso e lo avevo visto cedere a Tiziana quell’aggeggio per lei così stupefacente. La bambina però, come se fosse stata già paga di quanto aveva osservato sullo schermo di quel gioco - dopo qualche istante speso, forse, nel tentativo di comprendere la dinamica del prodigio elettronico - aveva riconsegnato il gioco alla mamma del bambino e s’era avviata, seguita a distanza dal genitore, alla perlustrazione del corridoio della nuova carrozza.
“Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta!” mi ripeteva incessante la voce dentro e benché provassi a non alzare più gli occhi cercando di riconquistare la concentrazione, l’allarme adesso mi pareva diventare sempre più incalzante.
“Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta!” “Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta!” “Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta! Attenta piccolina, stai attenta!”
È stato un sibilo inatteso, simile a quello che si ascolta quando il treno s’incrocia un altro treno che viaggia ad alta velocità nella direzione opposta. Ho avuto appena il tempo di realizzare che si trattava, invece, del rumore del pistone a pressione della porta del nostro vagone che inaspettatamente si è aperto durante la nostra corsa e, nello stesso momento, ho avvertito improvvisa la corrente d’aria gelida che da dietro la nuca ha attraversato da un capo all’altro l’intera carrozza. La voce ch’avevo dentro ha cominciato ad urlare ancor più forte a squarciagola: “Attentaaaa! Attentaaaaa!” .
È stato in quell’istante preciso che alla voce ch’avevo dentro di me si è sovrapposto il grido inaudito che m’ha spaccato per sempre il cuore: ed era il nome di una figlia - Tiziana - urlato per afferrare una bambina che improvvisamente non c’era già più.
Che fine ha fatto?
 Racconto tratto da Storie liquide
Racconto tratto da Storie liquide«Gli occhi a volte vedono cose che non ci sono o non riconoscono
quelle che ci stanno proprio di fronte. Sono illusioni dovute alla stanchezza
». Proprio questa frase che aveva sentito dal suo analista, senza
comprenderne realmente il significato, adesso gli girava nella testa.
Giacomo provò a rimanere immobile. Sollevò la schiena e si mise con
le gambe lungo la sponda del letto. Ora che si era seduto, la stoffa del
pigiama si era gonfiata sul davanti e dalla patta semiaperta gli pareva
di intravedere finalmente qualcosa.
Giacomo volle verificare subito: aprì la mano e provò immediatamente
a premere su quel gonfiore, ma di rimando ci fu solo una sensazione
d’inutile e vuota pressione. Ci provò ancora due volte. La
prima, senza guardare, strofinando la mano sulla stoffa del pigiama e,
poi, scostandosi di dosso il pantalone per tastarsi direttamente in
mezzo alle cosce. La seconda con gli occhi aperti, seduto sul letto e
rivolto allo specchio. Ma nulla: non c’era più! Era scomparso e lui
adesso era certo che non stesse affatto sognando. Perciò, l’unica cosa
da fare era quella di correre al più presto in ospedale, lì qualcuno
sarebbe riuscito ad aiutarlo. No, quella non era una buona idea. Cosa
avrebbero potuto dirgli in ospedale? E poi, come glielo avrebbe spiegato
agli infermieri? Magari in ospedale avrebbe avuto di fronte una
donna a cui dover riferire il suo problema, e come gliel’avrebbe
detto? Sicuramente, chiunque avesse avuto di fronte, uomo o donna,
non avrebbe capito… l’avrebbe preso certamente per un folle. Eh sì
– continuava Giacomo nel suo ragionamento angosciato – c’era il
rischio che i dottori, temendo d’avere di fronte uno squilibrato, potessero
addirittura rifiutarsi di prenderlo in esame. O no… forse valeva
la pena di tentare. Sì, era meglio andare subito al Pronto Soccorso,
senza perdere altro tempo prezioso. Doveva vestirsi. Doveva vestirsi
in fretta, prendere l’auto, fare benzina e correre cercando d’evitare di
farsi vedere in quello stato di angoscia. Doveva schivare il portiere, i
condomini del palazzo, chiunque al di fuori dei medici, perché lui,
Giacomo Salemi, aveva adesso, certamente, impressa sul viso un’espressione
troppo sconvolta per essere decifrata da persone che non
potevano prestargli aiuto. Occorreva, invece, un medico. Un medico
prima di tutto.
Giacomo prese dunque a vestirsi rapidamente, afferrò i pantaloni
e la camicia, che aveva indossato il giorno prima, dalla sedia in camera
da letto. Infilò i mocassini sbattendo più volte i talloni sulla
moquette per far risalire i colletti e si diresse in gran fretta all’ingresso.
Lì rimase un attimo immobile, guardò dallo spioncino, girò la
chiave nella serratura cercando di non far rumore e aprì, infine, la
porta di casa. Rimase di nuovo immobile sul pianerottolo per qualche
secondo, stringendo il mazzo di chiavi nella mano, e solo quando fu
certo che le scale fossero sgombre, iniziò a scenderle rapidamente.
Superò l’atrio del palazzo al pianterreno, svoltò a destra verso la porta
del garage e in meno d’un minuto era già seduto in auto, pronto a
uscire in strada in tutta fretta.
«Trenta euro, Mario, per favore» disse Giacomo a bordo dell’automobile
arrivando dal benzinaio.
«Certo dottor Salemi. Che le è successo, dormito male?» lo interrogò
con un sorriso l’uomo. Giacomo non rispose, guardò i numeri
sul distributore sovrapporsi veloci e pensò di essere stato uno stupido:
se voleva allontanarsi con discrezione e senza esser visto in quello
stato d’agitazione, avrebbe dovuto evitare di fare rifornimento proprio
sotto casa.
«Arrivederci» lo salutò l’uomo prendendo i soldi che Giacomo gli
stava porgendo. «Arrivederci, Mario» rispose Giacomo. Ingranò la
marcia e raggiunse l’incrocio.
Lì, al semaforo, in attesa del verde, Giacomo guardò nello specchietto
retrovisore e vide una donna al volante intenta a ripassarsi il
rossetto con movimenti circolari dell’indice. Quando lei smise di
compiere quell’operazione e parve guardarlo direttamente negli
occhi, Giacomo distolse immediatamente lo sguardo e tornò a controllare
il semaforo. Davanti a sé vide il gran cartellone pubblicitario
con l’immagine in bianco e nero di un giovane uomo, più o meno
della sua età, trascinato per la cravatta da una donna di cui si vedeva
solo il braccio che manteneva la presa. Sopra la foto campeggiava la
scritta: «Se oggi hai perso la rotta, non lasciarti prendere per la
gola!». Giacomo pensò che sarebbe stato meglio non farsi prendere
dal panico e, forse, conveniva calmarsi e rivolgersi a chi lo conoscesse
davvero bene. Sì, forse era meglio desistere dal proposito di andare
in ospedale, ci voleva piuttosto qualcuno di fiducia a cui poter parlare
con franchezza. Giacomo pensò dapprima al medico di famiglia.
Il dottor Spadacenta, lo conosceva bene, lo aveva curato sin dall’infanzia,
ma forse per una cosa simile era meglio non coinvolgere
immediatamente qualcuno vicino alla sua famiglia. Forse, la cosa
migliore da fare in una condizione come la sua sarebbe stata quella di
rivolgersi al suo analista. Certamente lui, il dottor Di Vittorio, avrebbe
saputo indicargli un modo razionale per affrontare quel problema.
O, forse, poteva chiamare proprio suo padre… No, non era una buona
idea, certamente anche lui gli avrebbe detto di andare in ospedale.
Che fare dunque? Giacomo non sapeva più a cosa appigliarsi, sentiva
improvvisamente la propria testa scoppiargli come per effetto di
un’enorme bolla d’acqua che gli stava diluendo ogni pensiero,
lasciandolo privo d’ogni determinazione logica. Gli occorreva un po’
di calma. Doveva recuperare la concentrazione. Doveva prima di tutto
capire esattamente cosa fosse accaduto. Dopo avrebbe preso una
decisione. Non doveva farsi sopraffare dallo spavento e dalla fretta di
eliminare il disagio. Era necessario avere calma. Come gli aveva insegnato
il suo analista, «non esiste una soluzione giusta, un percorso
obbligato da fare, ognuno ha la possibilità di individuare quella che è
la rotta a lui più congeniale alla soluzione dei problemi». E per fare
ciò le due condizioni essenziali sono la calma e l’assenza della paura,
perché «l’assenza di calma e la paura non hanno rispetto del tempo
che ogni opportuna soluzione richiede».
Sì. Ora aveva capito: la cosa da fare era proprio recuperare la tranquillità,
magari attraverso un po’ d’isolamento, una mezza giornata in
cui doveva provare a restare «da solo in contatto con il proprio problema
», così da poter trovare da solo la strada migliore… Ecco, sì, gli
occorreva un luogo tranquillo! Doveva allontanarsi dalla città, anche
solo per poche ore, per riflettere con meno paura. La soluzione?
Adesso ce l’aveva. Avrebbe imboccato il raccordo, da lì l’autostrada
per Firenze e in meno di un’ora sarebbe arrivato a Narni: il casale di
famiglia era il posto migliore per prendere la decisione. Lì, in solitudine,
lui avrebbe valutato cosa fare e una volta individuato il modo
più adatto di risolvere il problema, avrebbe fatto ritorno in città e
affrontato razionalmente la situazione.
Forse proprio quale conseguenza di quella rinnovata determinazione,
Giacomo sentì pian piano d’esser in grado di formulare nuovamente
pensieri logici. Accese lo stereo, accostò a destra, attese che
il semaforo di inversione di direzione fosse verde e iniziò a ripercorrere
la strada nel senso opposto. Salì sul cavalcavia della tangenziale
e si diresse verso il raccordo.
Una volta sull’autostrada, Giacomo poté fare un primo tratto di
strada abbastanza velocemente. Tutto il traffico era diretto nel senso
opposto, verso la città. In direzione nord, invece, le auto sembravano
viaggiare spedite e le corsie erano quasi deserte. Fu così fino a
Magliano Sabino, poi l’asfalto iniziò a riempirsi d’autocarri e di altre
autovetture. Giacomo decelerò, cercando di rimanere sempre sulla
corsia di sorpasso. Guardò l’orologio e calcolò che in quaranta
minuti al massimo sarebbe arrivato alla meta. Inspirò profondamente
e, ricacciando sonoramente l’aria dalla bocca, guardò il cielo sfilargli
davanti.
Preannunciate appena dalla luce improvvisa di un lampo e da un
tuono, pesanti gocce di pioggia cominciarono a cadere violente sul
vetro dell’auto, quasi fossero state scagliate proprio contro Giacomo,
a volerlo colpire in faccia. Grandi, tonde, gonfie, le gocce una volta
arrivate sul cristallo vi rimanevano attaccate senza sparire. Giacomo
guardò le prime atterrare grosse e restare immobili per qualche secondo
sul parabrezza, per espandersi frementi in tutte le direzioni. Toccò
la leva del tergicristallo per far partire le spazzole poi, con la visuale
nuovamente sgombra, schiacciò un po’ l’acceleratore per superare
una lunga fila di camion, fino a quando non si trovò proprio davanti
un’auto blu che solo qualche minuto prima gli aveva insistentemente
chiesto strada. Adesso, però, era Giacomo che gli si era fatto dietro
ma l’autista non pareva avere alcuna volontà di restituirgli la cortesia
spostandosi a destra. Innervosito per quell’ostinazione, Giacomo
decise di tentare il sorpasso da destra ma pure quella manovra si
rivelò inutile: l’altra vettura si spostò solo di poco, continuando a
viaggiare a cavallo delle due corsie. Giacomo premette allora il clacson,
diede un nuovo affondo e gli si fece ancora più sotto mantenendosi
a pochissima distanza dall’altra vettura. Per evitare d’essere tamponata,
l’auto si spostò alla fine sulla corsia di destra e Giacomo
cominciò il sorpasso.
Una volta superata l’auto blu, Giacomo lanciò lo sguardo nello
specchietto retrovisore per guardare l’altro guidatore. Vide allora la
testa dell’uomo oscillare in avanti, indietro e ancora in avanti, come
se stesse ridendo. Sì, era proprio così, stava proprio ridendo quel
figlio di puttana. Giacomo staccò il piede dall’acceleratore, si rimise
sulla corsia di destra e lasciò che l’altro gli si affiancasse nuovamente.
Ora le due auto avanzavano parallele come trainate da un
unico vettore. Quando fu certo di essere davvero in linea con l’altra
auto, Giacomo volse la testa verso sinistra così da fissare direttamente
in faccia quel tipo. Non lo comprese immediatamente, forse
per via degli occhiali da sole che l’uomo aveva sul naso, ma dopo
una prima incertezza, Giacomo riconobbe quel profilo e soprattutto
quel neo, proprio al centro della guancia destra. Scorse il sorriso
largo, appena schiumato agli angoli, gli occhiali spessi e soprattutto
l’anello al mignolo con lo stemma di famiglia… Non poteva trattarsi
che di lui…
Giacomo non ebbe neanche il tempo di domandarsi perché proprio
il dottor Di Vittorio, perché proprio il suo analista, si trovasse lì, alla
guida di un macchinone, spinto in un’assurda gara di velocità con lui.
Giacomo sentì la voce del suo medico parlargli attraverso lo stereo
dell’auto, coprendo la musica.
«Giacomo, mi sente? Giacomo, sono il dottor Di Vittorio, mi
ascolta?»
«Ma dov’è?» chiese Giacomo incredulo.
«Sono qui nell’auto accanto. Non mi ha visto?»
«Certo che l’ho vista. Ma come fa a parlarmi? Che ci fa qui?»
domandò Giacomo guardando ancora in direzione dell’auto.
«La smetta di farmi domande, Giacomo, e mi stia a sentire! Credo
che lei abbia perso qualcosa, o mi sbaglio?» lo interrogò il dottore.
«E lei come fa a saperlo, dottore?» rispose Giacomo.
«Ancora domande. La pianti, Giacomo, con le domande e mi
ascolti bene: io sono qui per aiutarla, anche se il tempo a sua disposizione
è quasi scaduto perché alle tredici ho un altro appuntamento
e devo rientrare allo studio. Però Giacomo, io sono qui per dirle che
sua madre ha quello che lei sta cercando.»
«Che cosa? Che cosa?» urlò Giacomo.
«È stato lei, Giacomo, a darglielo» rispose il dottore e continuò
«Sì, Giacomo! Gliel’ha dato lei ieri, prima di andare a cena con gli
amici. Non ricorda?».
«Ma dottore, che sta dicendo? Non la capisco. E che ne sa lei che
mi manca qualcosa?» ripeté Giacomo.
«Giacomo, ancora un’altra domanda ed io la lascio in balia dei
suoi dilemmi!» sentenziò serio il dottore.
«Ma come fa a saperlo dottore?» provò ancora Giacomo «Dottore,
io a mia madre non ho dato un bel nulla. Sì, è vero, ieri… ieri io sono
passato da lei nel pomeriggio, ma abbiamo preso un tè e io non le ho
dato nulla… almeno, non quello che pensa lei. Mi sente?… Dottor Di
Vittorio mi ha sentito?» urlò Giacomo.
«Certo la sento. Ma le ripeto Giacomo, sua madre ha quello che lei
adesso sta cercando. Se le interessa davvero, torni da sua madre e
vedrà che non mi sbaglio!» confermò il dottore. Poi dopo una breve
pausa: «Adesso la saluto Giacomo, devo rientrare a Roma. Ne riparleremo nel nostro incontro settimanale. Ci vediamo mercoledì alle
diciotto in punto… Arrivederci, Giacomo, e vada piano: non metta a
repentaglio la sua vita!» concluse il medico.
Giacomo ebbe appena il tempo di pronunciare un remissivo «Va
bene dottore». Vide poi l’auto dell’analista schizzare via davanti a sé.
Provò ad accelerare di nuovo, ma la sua auto adesso non era più capace
di riavvicinarsi all’altra vettura che si stava allontanando veloce.
Giacomo tentò di parlare ancora con il dottore, provando a rievocare
la voce toccando tutti i tasti del suo stereo, ma non riuscì a sentire
altro se non le note del CD che aveva messo prima.
Decise allora di rallentare, accostò nella corsia d’emergenza, mise
le quattro frecce e prese il cellulare che aveva sul sedile accanto. Tre
squilli e poi l’inizio del messaggio: «Questa è la segreteria telefonica
di casa Salemi, non siamo in casa…» chiuse. Sua madre era uscita,
forse per andare dal dietologo, come gli aveva detto il giorno prima.
Che fare allora? Giacomo doveva parlare con lei, posò il cellulare
rimise le mani al volante pronto ad andare da lei.
«Buongiorno dottor Salemi» lo accolse sorridendo il portiere…
«Ero salito per portare la posta a sua madre, credo però che sia
uscita. Non mi ha risposto nessuno. Lei ha le chiavi vero?» continuò
l’uomo.
«Sì, sì, certo Antonio. Devo solo prendere una cosa che ho dimenticato
ieri» rispose Giacomo quasi giustificandosi mentre richiudeva
le porte dell’ascensore.
«Arrivederci» lo salutò il portiere.
«Arrivederci» rispose frettolosamente Giacomo premendo il pulsante
del quinto piano.
Una volta in casa, benché avesse trovato la porta chiusa a doppia
mandata, Giacomo non rinunciò a chiamare la madre ad alta voce.
Attraversò il corridoio sporgendosi prima in cucina, poi in camera da
letto, ispezionò rapidamente lo studio e poi entrò nel salone.
«Mamma… mamma, ci sei?» provò a chiamarla aggirandosi tra i
divani e la biblioteca, dirigendosi verso il terrazzo, ma non udì alcuna risposta. Si voltò dal lato della stanza dove il pomeriggio del giorno
precedente avevano preso il tè. Il carrello era stato rimesso al suo
posto dietro le poltrone e tutto sembrava come al solito in ordine, le
poltrone dove s’erano seduti erano state riaccostate alla parete, anche
se i cuscini non erano stati ancora battuti e rigonfiati come faceva la
madre. Le sagome di Giacomo e di sua madre erano ancora impresse
sul velluto verde, come se i loro corpi se ne fossero appena allontanati.
Giacomo ripercorse con la mente quanto accaduto, ma l’unico
evento notabile di quel pomeriggio in cui era passato per il solito
saluto era stato il fatto che lui avesse rovesciato il tè sul tappeto. Ma
a parte tale episodio, tutto gli pareva essere accaduto secondo il
copione consueto. Eppure l’analista era stato chiaro: «Sua madre ha
ciò che lei sta cercando. È stato lei a darglielo, ieri!» gli aveva detto.
Giacomo tornò in corridoio lanciando sguardi veloci nelle varie
stanze, verso il bagno e, infine, al ripostiglio. Pronto ad andare via,
riattraversò l’ingresso: fu allora che la sua mente gli restituì l’immagine
di qualcosa di singolare che aveva appena visto. Si voltò indietro,
entrò nel bagno, avanzò in direzione della finestra, guardò prima fuori
gli alberi nel parco, poi verso l’uscita. Ma ora che si trovava di fianco
al lavandino, fu attratto dai riflessi del sole che, dalla superficie
dell’acqua immobile nella vasca, si proiettavano sulle piastrelle e
rimbalzavano dalla ceramica azzurra allo specchio sul lavandino. Lì,
al centro di quella vasca, immobile e galleggiante, eppure come ancora
dotato di una vita, Giacomo poté finalmente vedere ciò che stava
cercando. S’avvicinò al bordo con l’impulso d’afferrarlo subito.
Provò ad allungare la mano, ma una sensazione di immediata repulsione
lo bloccò. Trattenne allora il respiro, s’inginocchiò sul pavimento
e immerse la mano nell’acqua. Proprio per effetto dello spostamento
d’acqua, il suo membro, fino a quel momento immobile con
il prepuzio rivolto all’insù, si immerse appena nell’acqua per riemergere
ondeggiante verso il bordo opposto della vasca. Giacomo tirò
fuori la mano dall’acqua, se la passò in fretta sulla coscia, quindi la
riavvicinò nuovamente con l’indice teso.
Il primo contatto non gli produsse nessuna sensazione tattile, nulla
di decifrabile. Giacomo si fece coraggio, immerse di nuovo la mano
nell’acqua, ruotò con lentezza il palmo sotto, proprio in corrispondenza
dell’organo e, quasi stesse manovrando un retino, sollevò il suo
membro fuori dell’acqua. Rimase così qualche momento con la mano
semiaperta e il braccio poggiato sul bordo della vasca, poi s’alzò,
muovendosi con attenzione afferrò con l’altra mano l’asciugamano,
lo stese sulla tavoletta del water e vi adagiò delicatamente il proprio
pene. Prese il cellulare e con le dita ancora umide iniziò a comporre
il numero dello studio del dottor Di Vittorio.
«Buongiorno, studio del dottor…» gli rispose una voce di donna.
«Buongiorno signorina, sono Giacomo Salemi… avrei bisogno di
parlare urgentemente col dottore» disse con ansia.
«Mi spiace dottor Salemi, ma il dottor Di Vittorio è arrivato da
poco e ha iniziato subito la seduta, in questo momento è già impegnato
con un paziente» spiegò cortesemente la donna.
«La faccio richiamare, dottor Salemi, non appena il dottore termina,
va bene? Oppure, può provare a richiamare lei dopo le diciannove:
a quell’ora il dottor Di Vittorio dovrebbe aver finito» spiegò la
segretaria.
«La prego signorina, so che il dottore è molto impegnato, ma io ho
bisogno… ho bisogno…» s’interruppe deglutendo e poi riprese «ho
bisogno di parlargli subito. Non posso aspettare. È veramente molto
importante; non mi permetterei di disturbare, ma le ripeto è vitale che
io gli parli subito. Subito!» concluse Giacomo.
«Attenda, provo a vedere se mi risponde…» disse la donna.
Giacomo aspettò qualche secondo, poi finalmente sentì il dottore
chiedergli con voce chiara: «Ha visto, Giacomo, che avevo ragione?
Lo ha trovato da sua madre, non è vero? Ne ero certo!».
«Sì, dottore… ma lei…» provò Giacomo, ma fu immediatamente
interrotto dal medico.
«Allora tutto risolto, Giacomo. Bene, sono contento. Lo conservi
bene, per adesso, poi mercoledì prossimo, quando ci incontriamo,
vedremo come affrontare il problema. Per adesso provi a distrarsi e
mi raccomodo, Giacomo, non drammatizzi, faccia piuttosto gli esercizi
come le ho insegnato, adesso sa come si fanno, no? È un esperto
oramai! Vedrà che tutto si risolverà!» disse con tono fiducioso
l’analista.
«Ma dottore?…» cercò d’insistere Giacomo e poi supplichevolmente
«Io, io… come faccio? Devo sposarmi tra pochi giorni».
Ma il dottore l’interruppe immediatamente: «Lo so, lo so, Giacomo,
ma prima di mercoledì per me è impossibile incontrarla, sono pieno di
appuntamenti, poi da domani fino a martedì sarò fuori. Non si preoccupi,
Giacomo, mercoledì mettiamo tutto a posto: si tratta di pazientare
un pochino. La saluto, a presto, Giacomo» concluse il medico.
«Dottore… dottore» provò ancora a trattenerlo, ma la conversazione
era già terminata. Giacomo guardò ancora interdetto lo schermo
del cellulare, poi selezionò il numero di Alessandra.
«Buongiorno, mi passa il 379, la dottoressa Rinaldi, per piacere?»
disse tutto d’un fiato al centralinista.
«Attenda, prego» rispose la voce all’altro capo del telefono.
«Pronto?» chiese Alessandra.
«Pronto Ale, sono Giacomo» disse lui.
«Ciao Giacomo, ma che è successo? Ero in riunione» domandò la
ragazza.
«Ale, devo parlarti subito, puoi raggiungermi a casa di mamma?»
«Certo, certo. Ma cosa è successo?» chiese lei preoccupata.
«Non posso dirtelo al telefono, e non c’è bisogno che anche tu ti
agiti. Però sbrigati, vieni qua a casa di mia madre, ti devo dire una
cosa molto importante» replicò Giacomo.
«Giacomo, ma stai bene? È successo qualcosa a tua madre?» disse
Alessandra in cerca di rassicurazione.
«No, mamma sta bene. Adesso lei non c’è. È dal dietologo,
credo…» spiegò Giacomo.
«E tu che ci fai lì?» lo interruppe Alessandra.
«Te lo dico appena vieni. Ti aspetto qui, vieni subito?» chiese lui.
«Va bene, va bene, ma io posso essere da te non prima di una mezzora
amore. Aspettami, arrivo. Tu stai calmo, aspettami. Arrivo» lo
rassicurò Alessandra prima di riagganciare.
Giacomo spense il cellulare, scrutò per alcuni secondi la sua
immagine immobile nello specchio, si avvicinò alla tazza e lo vide lì,
adagiato sull’asciugamano. Lo osservò nuovamente qualche istante,
infine, lo prese di nuovo in mano, sollevò il coperchio della tazza e lo
fece rotolare dentro. L’acqua del fondo emise soltanto un rumore
sordo. Schiacciò lo scarico e rimase lì ad attendere che lo scroscio
dell’acqua terminasse.
Un paio di gocce gli erano rimbalzate sui mocassini. Giacomo
strappò un pezzo di carta, s’asciugò con un movimento lento le scarpe,
si voltò, ritornò in salone e si sedette sulla poltrona.
Rimase fermo, sprofondato sul cuscino con pochi e stanchi pensieri,
gli occhi assenti, rivolti alla parete sul fondo. Quando il suono
ripetuto del citofono lo svegliò dal torpore, s’alzò stordito per dirigersi
all’ingresso.
«Pronto?» disse portandosi la cornetta all’orecchio.
«Sono io, amore» annunciò Alessandra.
Schiacciò il pulsante della porta aprì la porta e si diresse come per
tornare in salone ma, come sorpreso dallo stimolo di fare la pipì,
entrò il bagno. Fu in quel momento, appena il tempo di tirare giù la
cerniera e scostare l’elastico delle mutande che Giacomo se lo ritrovò
tra le mani.
Lo guardò appena qualche istante. Provò a girarlo quasi per vedere
che fosse tornato realmente a posto e s’ispezionò sotto i testicoli.
Il rumore dei passi affrettati di Alessandra che lo stava chiamando
dall’ingresso, lo costrinsero ad abbandonare quelle operazioni, risollevò
le mutande mentre lei stava ancora chiedendo: «Amore, amore…
Giacomo dove sei?».
«Che è successo, Giacomo, dimmi?» domandò la ragazza raggiungendolo
sulla soglia del bagno.
«Nulla amore!» rispose impacciato lui.
«Come nulla? Mi hai detto che mi volevi parlare, amore… Mi
sono scapicollata per arrivare qua e mi dici che non è successo nulla!»
protestò Alessandra.
«Amore non ti arrabbiare… Oggi non sono andato in ufficio, perché
volevo pensare a noi e… ho capito che ti amo tanto e volevo dirtelo!
» le sospirò Giacomo. Lei gli si avvicinò. «Ma dici sul serio,
amore?» gli chiese ancora. «Certo tesoro mio!» annuì Giacomo, le si
avvicinò di più, l’abbracciò e iniziò a baciarla appassionatamente.
Ortensia
Ortensia ha diciassette anni, capelli lunghi, lisci e biondi ma spenti, proprio come i suoi occhi grigi che hanno deciso di incrociare di rado quelli di un’altra persona. Come un animale impaurito, Ortensia non si fida più o, forse, non si è mai fidata, neanche di chi le sta accanto e, adesso, ha iniziato a dubitare anche di se stessa. In realtà, sono già quasi due anni che l’intero corpo di Ortensia, da sempre esile e spigoloso, non somiglia più a quello di una di quelle antilopi graffite sulle pareti delle caverne nel Sud della Francia che tanto l’avevano impressionata da bambina e nelle quali si era subito riconosciuta. Persino i maschi della sua classe non si sorprendono più della magrezza di Ortensia come facevano all’inizio, quando la sua bellezza di fanciulla ad un passo dall’adolescenza aveva iniziato a sbocciare, attraendone le attenzioni. Inizialmente, anche loro - i ragazzini che le giravano intorno - erano stati sopraffatti, sebbene non riuscissero a comprenderne l’essenza, da quella tensione verso il sublime che albergava in Ortensia e che era capace di farsi strada anche a dispetto delle piccole mortificazioni che lei, in segreto, aveva iniziato a sperimentare su se stessa.
Prima atti quasi impercettibili, come un’insolita trascuratezza nell’acconciarsi i capelli o nel vestire, un’unghia sanguinante, un piccolo graffio sul dorso della mano o sulla guancia, poi addirittura qualche livido e ancora un taglio più profondo sull’avambraccio che lei sembrava voler mantenere sensibile ripercorrendone la lunghezza con le dita.
In seguito, quell’inquietudine si era fatta palese e mentre i maschi della sua classe avevano preferito orientare i propri interessi verso le altre più fulgide compagne, quelle stesse femmine avevano cominciato a bisbigliarsi strane cose su Ortensia: gradualmente aveva cominciato a girare sempre con più insistenza la voce che i pantaloni che Ortensia indossava così mollemente sulle gambe o le felpe che sembravano diventare più grandi settimana dopo settimana, fossero le prime evidenti tracce della sua difficoltà a mangiare con regolarità. Ortensia - dicono queste stesse voci - non si vuole bene o, piuttosto (come aveva spiegato l’insegnante di latino e greco in uno dei tanti giorni d’assenza che avevano cominciato a riempire il calendario scolastico) Ortensia si vede grassa.
Quelle frasi sono arrivate anche alle orecchie di Ortensia e ora lei non può fare a meno che convenirne, perché - sebbene le curve intorno ai suoi giovani fianchi siano da tempo sparite e, persino, i suoi capezzoli paiano rimpiccioliti ed avviarsi ad una forma che somiglia sempre più a due mirtilli abbandonati su di un petto che ha perduto ogni morbidezza - preferisce trascorrere interi pomeriggi da sola, restandosene chiusa in camera sua, dove l’unica cosa che riesce a fare sollevandosi dal letto, è guardarsi per lunghe, interminabili sessioni, allo specchio. Sempre lì dentro, chiusa tra le pareti della sua camera, Ortensia si pesa, almeno cinque volte al giorno, provando a misurare l’effetto che le fa uno dei suoi pasti che oramai ha ridotto ad una mezza confezione di mais, una barretta di cioccolato, due fette biscottate col the o quattro mandorle sgusciate.
Questi cibi Ortensia li consuma quasi sempre da sola e li preferisce a quei pochi pasti cui è oramai obbligata in compagnia dei genitori. In queste occasioni, lei si mette a tavola con una sensazione di sopraffazione, come di chi sia stata obbligata a commettere un peccato, e con l’immane sfinimento derivante dal dover ripetere ciò che da tempo le appare come un’inutile messinscena. Una recita in cui Ortensia - figlia unica di due persone che non hanno mai parlato molto tra di loro, salvo quando sono in presenza di estranei, e che da subito han deciso di non tacere ad Ortensia la sua adozione - interpreta la parte di una ragazza timida e silenziosa.
Per la verità, circa un anno fa sua madre s’è accorta che qualcosa non va ed ha intuito che per Ortensia mangiare sta diventando insopportabile. Perciò, dopo i primi digiuni e le fughe in bagno di sua figlia, la mamma ha deciso di far sparire le chiavi di tutti e due i bagni. Ortensia ha però escogitato una strategia alternativa: lei si libera del cibo direttamente in camera da letto e lo fa infilandosi un lembo del lenzuolo in bocca, provando a spingerselo fin dentro la gola e, se trattiene per qualche istante il respiro, le viene poi naturale deglutire fino al momento in cui il cibo, che Ortensia controvoglia ha dovuto ingoiare a tavola, comincia finalmente a ripercorrere il tragitto inverso risalendo su per l’esofago per riaccumularsi di nuovo in bocca, pronto ad esser espulso. Lei, quel cibo lo vomita in una busta che l’indomani, lungo il tragitto verso scuola, può eliminare.
Sebbene non lo ammetta apertamente a se stessa, Ortensia ha cominciato a desiderare di vedere assottigliare sempre più il suo corpo proprio per poter sembrare ancor più uguale ad una di quelle gazzelle stilizzate sui muri delle caverne. Ma altre volte, lei si immagina come un solo filo d’erba: lungo, liscio e senza sporgenze, indifferente persino alla siccità e all’assenza totale di nutrimento e di luce. Ed è proprio questa immagine del filo d’erba che Ortensia ha scelto per descriversi con lo psichiatra, Esperto di disturbi del comportamento alimentare, come ha letto sulla targa d’ottone dello studio dal quale, da circa due mesi, ha accettato di andare. Ma se Ortensia l’ha fatto è proprio col preciso e lucido intento di far rientrare quell’improvvisa attenzione che alcuni professori, e in seconda battuta sua madre, hanno cominciato a riversare su di lei. La cosa, infatti, che maggiormente la disturba è avvertire quel preoccupato, a volte morboso interesse concentrato proprio su quel che mangia o ha smesso di mangiare. Per quale motivo - si chiede ormai retoricamente Ortensia - non può essere libera di ingoiare quello che desidera e, soprattutto, di stabilire da sola cosa e quanto sia sufficiente al proprio organismo?
Perciò, pur di far cessare quella fastidiosa apprensione esterna, due volte a settimana - ogni lunedì e giovedì pomeriggio - Ortensia ha acconsentito a lasciarsi ispezionare e, in molti casi, a farsi martoriare l’anima, in quello studio medico dove ha negoziato di poter essere condotta e riportata a casa da sola a bordo dell’auto di servizio del padre.
Già dal secondo incontro con il medico, quando lui ha spiegato ad Ortensia che il suo problema dipenderebbe da un bisogno di attenzione, divenuto viscerale sin dalla sua prima infanzia, lei ha realizzato che quell’uomo dal profumo di colonia così invadente non sarebbe stato in grado di capire un bel niente. E a nulla è servito ad Ortensia provare ad obiettare a quella sentenza il fatto che lei non provi alcun bisogno di attenzione ma, al contrario, desideri esser lasciata in pace e per conto proprio, in quanto del cibo - come dell’amicizia e dell’amore - lei non sente al momento alcuna necessità.
In cuor suo, Ortensia ha anche pensato dal secondo incontro con quel medico che, forse, avrebbe potuto rendere quelle sedute meno estenuanti se avesse confidato di aver provato attrazione e interesse in passato per qualcuno, invece di continuare a ripetere di non aver alcun interesse né per ragazzi, né per ragazze. Le è accaduto - ha narrato perciò - che, quando era poco più che una bambina, si era invaghita di un amico incontrato il primo anno delle sue vacanze-studio in Inghilterra. Se ben ci pensa un interesse simile le si era riproposto almeno altre due volte con un altro ragazzo, di qualche anno più grande di lei, figlio del benzinaio della pompa sotto casa. Ma poi è capitato che Ortensia abbia pensato di non esser lei la persona giusta o, viceversa, che quel ragazzo abbia fatto o detto qualcosa di sbagliato capace di farla immediatamente ravvedere.
Oltre ad incontrare lo psicologo e, sempre per esser lasciata in pace, Ortensia ha accettato di sottoporsi ad un programma di alimentazione controllata, secondo il quale lei è libera di scegliere da sola il cibo senza dover ascoltare le suppliche e le prescrizioni della madre. Adesso è qualcun altro che pesa gli alimenti al suo posto e soprattutto (circostanza inizialmente sottovalutata da Ortensia), i suoi pasti li deve consumare in presenza non più dei genitori, ma di una giovane donna, una dottoressa, Daniela, che appunto fa la nutrizionista di mestiere. È Daniela ad esser stata incaricata di assicurare la rieducazione alimentare di Ortensia. Ma dopo le prime volte in cui i pranzi con la dottoressa si sono rivelati se non interessanti, almeno sopportabili, Ortensia ha avuto la sensazione che quell’estranea la stesse trattando come un animale d’allevamento destinato al macello ed obbligato ad ingurgitare razioni alimentari al limite della sopportazione. Perciò, pur sforzandosi in sua presenza di consumare tutto il cibo proposto, Ortensia ha iniziato a percepire la presenza di Daniela una volta al giorno come una nuova tortura, anch’essa intollerabile, al punto da sentirsi impazzire e da dover inscenare malesseri che la costringono a letto.
Infatti, quello che sempre più snerva Ortensia è che qualcun’altro - sua madre, suo padre, il suo psicanalista e adesso Daniela - abbia comunque il potere di imporle quantità di alimenti che lei non considera affatto necessarie alla propria sopravvivenza. Perciò, sebbene abbia acconsentito a sedersi di nuovo a tavola almeno una volta al giorno, ad orari prestabiliti, in compagnia di Daniela e per un tempo non inferiore a venti minuti (tempo che lei stessa cronometra azionando il timer del microonde), ogni volta che ritorna in camera sua non può evitare di infilarsi l’angolo del guanciale in bocca per provocare il vomito e liberarsi di quella piccola massa melmosa, riversandola dentro un’altra busta di plastica che butterà in seguito.
Negli ultimi giorni Ortensia non può smettere d’immaginare con sempre maggiore orrore l’ago della bilancia che si avvicina di nuovo, pericolosamente, ai quarantasette chilogrammi e ciò che la ossessiona di più è l’idea che il proprio stomaco sia stato di nuovo riempito di alimenti pronti a trasformarsi in altro grasso. Perciò, tutto quel cibo lei non può tenerlo dentro di sé, non può aspettarne la digestione e quindi l’assimilazione. Occorre disfarsene come lei ha imparato a fare, oppure bere subito moltissima acqua, così da dilatare un poco lo stomaco, quel tanto che può arrestarle il vomito in presenza di Daniela. Dopo, in camera sua, quando il pianto l’avrà calmata ed avrà recuperato il coraggio e il controllo di sé, il vomito arriverà da solo, senza bisogno di usare le mani o la stoffa del cuscino. E non le importa che lo psicologo non creda che lei ami sentire la propria pancia brontolare, vedere la lancetta della bilancia girare in senso antiorario restando al di sotto dei quarantasette chili, né quanto sia importante per lei vedere e poter tastare le proprie ossa o ascoltare il sangue fluire nelle proprie vene.
Per Ortensia, tutti quelli sono desideri legittimi. Poco le importa se qualcuno li considera sintomi di una malattia o altro. Lei soltanto è in grado di capire ciò che può farla sentire a posto. È per questo che lo scorso ottobre si è iscritta in palestra e da allora ci sta andando ogni volta che se la sente. Spesso il sabato quando non deve andare a scuola.
Anche oggi, proprio come la scorsa settimana, Ortensia ha già fatto la prima ora di spinning e da meno di dieci minuti è ritornata nuovamente nella Sala Bike e sta montando sul sellino per una seconda lezione. Sebbene Mario - l’istruttore che Ortensia preferisce perché sa accompagnare la lezione con la musica Disco o R & B che più le piacciano – le abbia raccomandato nell’allenamento precedente di non sforzare troppo, lei è di nuovo salita in bicicletta.
Lì seduta, mentre il cardiofrequenzimetro inizia a segnare una media di battiti superiore a centocinquanta e con la musica anni Settanta pompata nelle orecchie, Ortensia prova l’eccitazione che le sale dalle gambe mentre ha ripreso a pedalare senza mostrare alcun segno di cedimento, anzi sollevandosi appena dal sellino per assecondare con le pedalate il ritmo che risuona nelle casse.
La sua capacità di pedalare senza sforzo dopo un’ora di lezione è la dimostrazione di quello che lei sostiene da sempre: tutto è comandato solo dalla mente e, se è la mente che lo desidera, non vi è stanchezza fisica o cedimento che il corpo non possa tollerare.
Ed è una sensazione talmente bella quella che prova Ortensia in questi momenti, una sensazione che l’avvicina ad uno stato di quiete senza tempo - una condizione nella quale lei non deve più curarsi di dare risposte e di fornire spiegazioni su quello che fa e non fa. Per questo, anche quando le pare che il fiato si stia appena spegnendo e che i contorni della sala oscillino intorno a lei, prima in una direzione e poi nell’altra, Ortensia continua imperterrita la sua scalata lungo la pendenza immaginata e scandita dalle esortazioni del nuovo allenatore.
Non importa che sotto i pedali non avverta più alcuna resistenza, né che le braccia non si sforzino più di sorreggere il busto tutto proteso in avanti o che le mani abbiano allentato la presa sui manubri e, sotto le tempie, il sangue abbia iniziato a pulsare sempre più potente e ad una velocità sconosciuta fino ad allora. Né importa che dopo qualche minuto dalla ripresa della corsa, il suo cuore è attraversato dalla corrente di un fulmine che la squarcia da capo a piedi, e qualcuno si sia già chinato su di lei. Non le importa di sbarrare quegli occhi grigi e dischiudere la bocca in una smorfia di disgusto. Lei ha preso le distanze da tutti. Soprattutto da quelli che continuavano a dirle cosa è bene per Ortensia e cosa non lo è come se fossero dei giardinieri esperti ed avessero a che fare con una delle piante di cui porta il nome e non con un essere umano.
Il disegno a china è di Clara Garesio
Gianluca Pirozzi, "Nomi di donna"
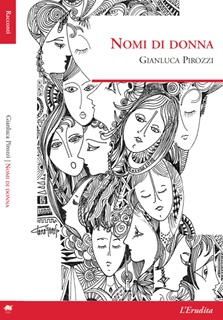
Nomi di donna
Gianluca Pirozzi
L’Erudita, 2016
pp 169
16,00
È così difficile trovare una raccolta di bei racconti e questi, contenuti in Nomi di donna di Gianluca Pirozzi, belli lo sono davvero, anzi di più. Sono originali, raffinati, scritti con maestria, sembra di avere fra le mani già un classico.
Qui nomen omen, ogni racconto un nome di donna, con storie peculiari e diverse fra loro. C’è la vedova che corre all’alba per sentire ancora la presenza del marito a fianco, c’è la femme de chambre che indulge in un piccolo vizio (ci viene in mente La carriola di Pirandello) capace di scompaginarle la vita ordinata, c’è la nera che si chiama Bianca ed è sopravvissuta al naufragio di un barcone, c’è la maestra Fabiana che cambia sesso e diventa il maestro Andrea, c’è la trapezista con la crisi di panico, c’è la prostituta che muore nell’incendio doloso della sua roulotte, c’è la moglie uccisa dal marito in un raptus di violenza. Ci sono tante figure dai nomi a volte comuni, come Nadia o Diana, a volte importanti, come Galatea o Aristea.
“I nomi, Sandro, non sono un dettaglio da poco o una casualità! È vero, non ce li scegliamo, al massimo tentiamo di adattarli storpiandoli con diminutivi o surrogati, ma sta a ciascuno di noi dargli il senso che ogni nome reca in sé e a riempirli dei nostri significati e del nostro modo di essere con la nostra vita.”
E poi, quando sei quasi oltre la metà della lettura, ti viene in mente che forse quel nome l’hai già sentito e ti costringi a tornare indietro per renderti conto che sì, avevi visto giusto, quel personaggio è davvero già comparso a margine di un racconto precedente e ora c’è un reprise del motivo, uno sbalzo temporale in avanti o indietro, un nuovo ramo è germogliato a formare una chioma folta, e capisci che tutti i racconti formano un’unica - a questo punto grandiosa - trama di romanzo simil picaresco ed immaginifico che ricorda un po’ quelli dei sudamericani Marquez e Allende. Gianluca Pirozzi ha vissuto in molte parti del mondo e, se è vero che il batter d'ali di una farfalla in Brasile può provocare un tornado in Texas, forse c’è un senso in tutto ciò che accade, una trama invisibile e sottile lega ci lega gli uni agli altri.
Più che di realismo magico o di surrealismo, si tratta di una raffinata rappresentazione della mente umana attraverso varie patologie. Molti dei personaggi, anche se non tutti, sono affetti da manie borderline, curiosamente derivate dalle loro passioni e dal loro lavoro. Diana, etologa, ha l’abitudine di paragonare ogni persona che incontra, anche i compagni di vita, agli animali. Edda, interprete simultanea, continua a tradurre mentalmente ogni parola e situazione. Alcune di queste manie sfociano nel delirio e nell’omicidio, altre in fughe, altre ancora restano confinate nel privato. Ma dietro a codeste fissazioni eccentriche si celano metafore della comune esistenza. Diana che non riconosce più in Ottavio il capriolo cui era solita paragonarlo, è simbolo, per contrasto onirico, della fine dell’amore, di come all’improvviso chi avevamo tanto vicino ci appaia diverso, dissonante, strano, non ci capacitiamo di averlo voluto al nostro fianco e riesca difficile persino rammentare il perché dei sentimenti e degli slanci che provavamo.
Quando capita di recensire testi così interessanti, che, pur nella loro intellettualità e nel loro spessore, sono avvincenti e intriganti, torna davvero la voglia di leggere.

/image%2F0394939%2F20190531%2Fob_6113d1_61425960-10216728261030327-19684367693.jpg)




