poli patrizia
LE NOVE DOMANDE E MEZZA PIU’ PAZZE DEL MONDO… MA NON TROPPO: PATRIZIA POLI

Amici del blog che fra le nuvole contemporanee lancia raggi di sole culturale, non poteva sfuggire al nostro appuntamento la super blogger toscana, Patrizia Poli, la nostra amica che, dietro un viso dai tratti gentili e timidi, cela una donna capace di esprimere, attraverso la forza delle sue parole, un’energia che ti contagia e ti avvicina alla lettura.
Ora ho la possibilità di farvela conoscere un po’ più a fondo, queste sono le domande che stiamo per rivolgerle.
1) signoradeifiltri.blog sta scalando le vette delle preferenze, qual è la ricetta del successo di pubblico?
Credo che sia la costanza. Il blog è aperto dal 2012. Otto anni in cui non mi sono mai arresa e, con perseveranza, ho pubblicato quotidianamente contributi interessanti. E l’ho fatto solo per il piacere di farlo, senza pensare se qualcuno leggesse oppure no, senza inseguire il successo a tutti i costi o stare per forza sul pezzo. E la gente ha capito e seguito perché gli argomenti sono tanti e vari, spesso di nicchia e insoliti. Poi mi sono avvalsa, negli anni, di collaboratori entusiasti e competenti come te, una bella squadra che ha fatto la differenza.
2) Con un fulmine Re Artù ti ha colpito e ora puoi viaggiare nel tempo. In che epoca preferiresti andare e perché?
Amo il Medioevo ma penso che non fosse comunque una bella epoca per vivere. Pestilenze, guerre, caccia alle streghe, tribunale dell’Inquisizione e ogni gesto della vita quotidiana permeato di fede e riportato alla religione. Pare che facesse anche più freddo di adesso. Amo il Medioevo ma solo nei libri e nei film. Forse sarei stata più adatta a vivere nell’Ottocento, anche se pure lì la speranza di vita era bassa e si moriva di tisi a trent’anni. Mi vedo a Haworth, nello Yorkshire, aggirarmi per la brughiera chiamando Heathcliff. Una cosa molto romantica e tempestosa.
Per tornare ad Artù, ho appena finito di scrivere un inedito basato sulla materia di Bretagna. È stato il libro che mi è venuto più facile, forse perché sono quaranta anni che ho in mente questa storia e questi personaggi. È il più romantico dei miei libri e anche quello più dolce. Artù è un grande, è la regalità fatta persona, è l’axis mundi.
3) Scegli un artista del trapassato per la tua copertina.
Dante Gabriel Rossetti
4)Il tuo mantra per descrivere il tuo stile.
Riscrivere e riscrivere all’infinito.
5) Il tuo colore preferito.
Rosa.
6) Consiglia uno dei tuoi libri e perché?
L’uomo del sorriso. Quello al quale sono più legata, il libro della vita, scritto con amore e dolore.
7) Hai di fronte l’A.D. della tua casa editrice, una a caso, Marchetti… Come la convinceresti ad accettare che, in occasione della presentazione di un tuo libro, ti metta una parrucca tipo Jessica Rabbit? E per quale tuo libro ti presenteresti cosi?
Farei presto a convincerla perché è una ragazza allegra, pazzerella e intelligente. Ma non mi vedo nei panni di Jessica, piuttosto di Rabbit, il marito coniglio. Forse lo farei per presentare Bianca come la neve, la storia di una vampira.
8) La Toscana è una fucina di grandi letterati perché?
Perché ha la lingua più bella del mondo, è la culla dell’italiano. No, anzi, è l’italiano.
9) La canzone preferita che canti sotto la doccia.
Non canto, parlo da sola.
1/2)Devi litigare con qualcuno, userai i versi di Dante Alighieri della Divina commedia, quali?
"Al cul fece trombetta".
Molto bene amici della signoradeifiltri, ringraziamo Patrizia Poli per essersi aperta per voi, perché una scrittrice come lei potete considerarla una vostra amica, una delle migliori.
Ci rivediamo al prossimo scrittore, qui sempre su questo blog, e sarà comunque un piacere.
Otello Marcacci, "Tempi supplementari"
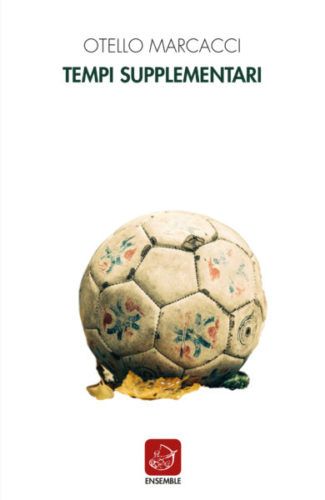
Tempi supplementari
Otello Marcacci
Ensemble, 2020
pp 366
16,00
Poiché, leggendo libri, amo le libere associazioni che essi mi suscitano, vi dirò che Templi supplementari di Otello Marcacci mi ha fatto venire in mente due cose: i romanzi nostalgico piombinesi di Gordiano Lupi, forse per la toscanità di entrambi - Marcacci vive a Lucca ed è grossetano e canta la Maremma- , e I ragazzi di via Pal di Molnar.
Anche qui abbiamo dei bambini, nella fattispecie appartenenti a una colonia marina, che, negli anni settanta, giocano la partita della vita contro un gruppo di “cattivi” di un’altra colonia. I nostri sono “inclusivi” ante litteram: la loro squadra comprende ebrei, omosessuali e donne, categorie emarginate, vituperate dai più e dalla chiesa cattolica. Solo una suora anticonvenzionale e coraggiosa può pensare di mettere insieme una squadra così.
Tuttavia l’idea del romanzo di formazione nostalgico è solo la prima impressione. Il testo è molto più complesso. È una storia d’intrecci e colpi di scena spesso grotteschi nella loro pur plausibile improbabilità.
La partita della Stella Maris contro il Cottolengo segna i passi più importanti dell’esistenza del protagonista, Giacomo Boselli, e dei suoi amici: Paolo, malato di cancro, David, ebreo, Cristiano, omosessuale, Bernardino, psicolabile, il Pescecane, attore porno, Ilenia, il primo amore, Marco etc. Il romanzo è diviso in tre parti, ciascuna dedicata a uno spaccato di vita durante il quale viene rigiocata la partita e che, in un modo o nell’altro, segna una svolta per tutti.
Marcacci si basa su un complesso ordito di rimandi e richiami. Il conflitto fra Giacomo e la figlia Maristella, affetta da una malattia rara, si fonderà proprio sul rifiuto del pregiudizio, tema che, come abbiamo visto, ha interessato Giacomo fin dalle prime amicizie estive. La trama si snoda per incastri, come un mosaico di pezzi collegati. Niente succede per caso e anche le situazioni più strane o insignificanti influenzano gli eventi successivi e li determinano.
Quando si gioca e si rigioca la partita, pur senza mai vincerla, “non si è disturbati dalla vita”, semplicemente si “è”, ci si cala nel flusso di un esistere sospeso nel tempo che non è preda di dolori, ripensamenti, scelte. Perché scegliere non è facile, il bene e il male non sono nettamente distinti, così come il giusto e l’ingiusto. Soprattutto la vita non mantiene le promesse.
Sebbene i dialoghi siano forse troppo maturi in bocca a ragazzini, la parte più bella è quella dedicata alle reminiscenze giovanili, ai ricordi delle sonnolente estati a Marina di Grosseto. Accanto alla fatica di vivere, all’angoscia del tempo che passa e ci trasforma senza accontentare le nostre aspirazioni ma, piuttosto, distruggendo i nostri ideali, la cifra di questo romanzo, e anche la sua bellezza, è la nostalgia. Nostalgia straziante di un periodo in cui ancora eravamo innocenti e tutte le possibilità erano aperte. Nostalgia di un periodo storico, di usi e costumi obsoleti (tutti e tre i blocchi temporali – anni settanta, novanta e duemila – son ben ricostruiti nei dettagli e nelle atmosfere), ma anche di parole non dette, di silenzi da colmare nel rapporto con persone che non ci sono più, che vivono nella memoria, che vengono in continuazione rielaborate e rivissute dentro.
È il “lavoro” di cui parla il protagonista ormai defunto, costretto, nel suo personale inferno o limbo, nei suoi infiniti “tempi supplementari”, a rivivere ossessivamente sempre i medesimi momenti, soprattutto legati alla partita, per cercarne significati e alternative che non si sono verificate ma avrebbero potuto essere. Un po’ quello che facciamo tutti, rimuginando sul passato, sulle sliding doors, su ciò che avrebbe potuto essere se solo avessimo detto o fatto questo o quello.
Un libro bellissimo che mi ha colpita al cuore e affascinata, un’ottima scrittura, che fa tornare la voglia e il piacere di leggere, molto avvincente e nello stesso tempo intelligente, con uno stile che ricorda in senso positivo i romanzi di qualche decennio fa.
Patrizia Poli: "Una casa di vento"

Una casa di vento è la storia di Francesco e Michela, i genitori di Loris, un ragazzino gravemente ammalato. Nella vita di questa coppia fanno improvvisamente irruzione delle lettere trovate per caso, provenienti da un lontano passato. Quelle lettere ritrovate generano la scintilla di una trasformazione che finirà per contagiare tutti i personaggi e per cambiare il corso delle loro vite.
A questo punto, continuare a parlare del libro non è facile. Chi parla di un testo ha il compito analizzare i personaggi, di mettere in luce la scrittura, di stabilire analogie e differenze con altri libri e altre storie. A differenza di Signora dei filtri (che ho avuto il piacere e l’onore di presentare), dove la storia di Medea era nota a tutti, per Una casa di vento a questo compito non facile si aggiunge l’onere di non togliere a chi legge il piacere di entrare da soli nella storia, di farsi sorprendere e turbare, di appassionarsi alle vicende dei personaggi e di restare col fiato sospeso fino alla fine.
Alla fine ho pensato di iniziare dal titolo.
La casa di vento si trova ad Antignano, un antico quartiere di Livorno. Forse il suo nome deriva da ante ignem (prima dei fuochi) perché stava prima dei fuochi di segnalazione per le navi dirette al Porto Pisano. La splendida scogliera, la spiaggetta di sassi, il piccolo porto per le barche ne fanno un luogo incantevole.
Quella del libro è “una” casa di vento, non “la” casa di vento. Non è unica, particolare, irripetibile questa casa (e così la sua storia e quella dei suoi abitanti), è una casa come tante, una storia come tante, fatta di vento. Quale vento? Di certo vento di mare perché Livorno è una città di mare e il mare – come dice Francesco - a Livorno fa da padrone, insieme al vento.
Vento, vento, sempre vento, da ogni parte, ovunque: grecale da est, freddo e prepotente, libeccio da sud che solleva cavalloni e li rovescia sulla strada, scirocco sfacciato, maestrale che dà sollievo nei giorni d’afa. È una casa di vento, questa, aperta su tre lati, esposta come una nave in tempesta, sventrata come la sua anima, come il suo corpo dopo l’incontro col ragazzo.
È Michela che descrive così la casa dove è andata a vivere col marito e il figlio, ed è lei a darle il nome. Dopo un lungo percorso, tornerà a parlare di questa casa che la rappresenta e le rimanda la nuova immagine di se stessa:
… la sua casa… è come la tolda di una nave spazzata dal vento. Lei sta imparando a convivere col vento, come con tutte le parti di se stessa che ancora le fanno paura, come la parte che è stata di Luca. Ora sa riconoscere lo scirocco e il libeccio che soffiano nella camera di Loris, il grecale che irrompe nel bagno, la tramontana che ghiaccia la cucina; sta imparando quale finestra deve chiudere e quale, invece, tenere aperta, dove stendere i panni, dove appoggiare i vasi dei gerani. Sta imparando a piegarsi, a puntellare, a contenere.
Le descrizioni di Una casa si vento sono soprattutto descrizioni di Livorno, mai nominata ma onnipresente. Livorno -“città” (vie, palazzi, quartieri) e Livorno -“natura” (mare e vento). Due “Livorno” molto diverse fra loro, due mondi paralleli incastrati l’uno nell’altro, ma sempre raccontati con maestria, usando le parole con audacia e rigore, esplorando tutte le potenzialità delle personificazioni, delle similitudini, delle metafore, delle sinestesie...
Se Livorno non è mai nominata direttamente, i suoi “luoghi” hanno sempre un nome preciso e una caratteristica comune. Nel caso di Livorno – città, ciò che li accomuna è il degrado, lo stesso che si è insinuato nell’anima dei protagonisti della storia:
via San Carlo, un budello di case umide e sudice, Villa Fabbricotti, un posto pieno di statue senza braccia mangiate dal muschio, una stupida grotta rococò piccola e sudicia, via Grande con le colonne di marmo sudicio, piazza Mazzini e la pizzeria con il tavolino vicino ai gabinetti, Stagno dove non si respira dal puzzo, i Fossi con le spallette bruciate dal sole, dove le erbacce spaccano l’asfalto , la Terrazza con le lunghe panche sbreccate …
Livorno-natura, è potente, dura e splendida insieme. Mare e vento fanno da sfondo alle vicende dei personaggi, entrano in sintonia con loro: lo stesso mare e lo stesso vento, diversi e opposti a seconda degli occhi che li guardano, rivelano in modo netto, a volte impietoso, sentimenti e segreti.
C’è il mare di Ida, col vento del ricordo e della lontananza … Bella l’aria di mare, fresca, chiara… già lì da Colline mi arrivava il vento di mare. Ricordavo i tuoi capelli agitati dal libeccio, la mano intrecciata alla mia nella tasca del paltò.
C’è il mare di Michela, un mare amaro, dove anche il vento è solo un’illusione … perché l’amore è evaporato come acqua di mare rimasta fra gli scogli. Quando l’acqua se ne va, rimangono cristalli aguzzi e amari, rimangono denti di cane che, se ti ci siedi sopra, strappano il costume, rimangono erbe marine che bucano, forse non sono erbe ma bestie con le chele, rimane il sale, proprio preciso a quello che lasciano le lacrime sulla pelle.
C’è il mare di Loris, un mare bello e amico che… ha un colore diverso per ogni alito di vento che lo agita, per ogni nuvola che ci passa sopra. Gli piace quando suo padre lo prende in braccio e lo bagna nell’acqua bassa e calda. Si sente normale, leggero, forte come gli altri
C’è il mare di Francesco, meraviglioso e struggente, che solo lui vede dalla terrazza della casa di vento e che non riesce a condividere … Le ha mostrato la bella vista dal terrazzo, le tamerici scosse dal maestrale, la scalinata che porta giù all’acqua limpida, ha indicato col braccio gli scogli che affiorano uno ad uno, mentre il mare si ritira nei giorni di luna piena, lasciando esposti denti di cane, padelle, ghiozzi imprigionati nelle buche. Ma non lo vedi, le ha detto, il celeste delle mattine belle, non li vedi certi tramonti? Quella striscia alta, prepotente, a tingere di porpora tutto l’orizzonte, non capisci quanto è benedetta, quanto è incredibile
Livorno raccontata da Patrizia è essa stessa un personaggio, una figura mitica, una divinità potente. Se dovessi raffigurarla userei l’immagine della Madonna della misericordia di Piero della Francesca che fa parte del polittico custodito nel Museo Civico di Sansepolcro. È una madonna solida, forte e severa, con i piedi poggiati sulla terra, come tutte le madonne di questo grande artista; è una regina che porta con fierezza la sua pesante corona; è una madre che indossa una veste senza ornamenti stretta da un cordone monacale; il grande mantello scuro è aperto, pronto a diventare un rifugio per tutti: uomini, donne, bambini, vescovi, papi… e per gli “abitanti” della casa di vento .
Gli abitanti della casa – cioè i protagonisti della storia – li troviamo elencati nell’indice, che merita un’osservazione più approfondita, anche perché, come si sa, delinea l’impianto della storia. È un indice davvero particolare: 3 stagioni (Inverno, Estate, Autunno, manca la primavera); nelle prime due (Inverno e Estate) un elenco di nomi che si ripetono (Francesco, Michela, Rosanna) con due “intrusioni” (Loris in Inverno, Luca in Estate) e infine un solo nome (Francesco) in Autunno. Perché solo lui? E che fine ha fatto la primavera?
A questo punto davanti a me (a noi) si aprono due strade: chiedere all’autrice oppure entrare nel “bosco narrativo” della casa di vento e, da bravi lettori, fare la nostra parte. Come dice Umberto Eco “il testo è una macchina pigra che chiede al lettore di fare parte del proprio lavoro. Guai se un testo dicesse tutto quello che il suo destinatario dovrebbe capire …”. Ma per far bene la sua parte il lettore (il lettore modello) deve stare al gioco dell’autore, seguirlo e assecondarlo nelle “operazioni interpretative che gli chiede di compiere: considerare, guardare, osservare, trovare parentele e somiglianze”. Così ho pensato di compiere con voi alcune di queste “operazioni” sulle stagioni elencate nell’indice, a partire dal loro nome.
La primavera, come dice l’etimo, è la stagione che precede l’estate, il tempo della rinascita, dell’inizio; per molto tempo in molti luoghi (per esempio a Pisa) l’anno iniziava a marzo, con la primavera.
Inverno deriva dalla radice sanscrita him- (freddo), che ritroviamo nel latino hiems (inverno). Perciò il suo significato è “tempo che appartiene al freddo, stagione gelida”. Però è anche il tempo in cui la terra riposa e custodisce i semi del grano che spunterà a primavera.
La parola estate ha sempre a che fare col sanscrito e si riconduce alla radice idh- o aidh- che esprime l'idea di ardere, infiammare, accendere. In latino diventa aestas, calore ardente.
Niente di nuovo, quindi.
Invece l’autunno - la stagione di Francesco potremmo dire, visto che in questo capitolo figura solo il suo nome - mi ha riservato una sorpresa. Contrariamente a quanto pensavo, il significato etimologico non ha a che fare con il tramonto, la fine, la preparazione all’inverno.
Autunno è da ricollegarsi al verbo latino augere, che vuol dire aumentare, arricchire e andando ancor di più alle origini, rintracciamo ancora una radice sanscrita av- o au- che esprime l'idea del saziarsi, del godere. Perciò l’autunno è la stagione che succede all’estate, una stagione ricca di frutti che la natura e il lavoro dell’uomo hanno preparato.
E se prendiamo le distanze dai luoghi comuni, ci rendiamo conto che non esiste una stagione più colorata dell’autunno. Il rosso e il giallo sono ovunque, e la cosa ancora più affascinante è l’origine di questo “oro”. Il giallo e il rosso in realtà sono già presenti nelle foglie, sono sostanze indispensabili alla vita che stanno nascoste sotto il verde della clorofilla. Quando la luce solare diminuisce e la clorofilla non può riprodursi, il rosso e il giallo emergono: le foglie, anche se sono perfettamente sane, diventano “zavorra” e devono essere allontanate dalla pianta perché possa mantenersi viva fino al ritorno della buona stagione, sbarazzandosi anche dei parassiti e degli agenti nocivi. Insomma: purificarsi, risparmiare energie, allontanare da sé ciò che è ormai passato, che ha finito il suo ciclo. E farlo nella bellezza, nel calore del rosso e dell’oro. È lo splendido fenomeno del “foliage”. Questo è l’autunno. La primavera non c’è perché ancora le foglie devono cadere per ripulire la pianta che ha bruciato di passione e gelato nel disamore. Ma le foglie rosso e oro stanno lavorando … Francesco, si può dire, è l’autunno, la stagione piena di frutti che anche quando “perde” in realtà arricchisce, “aumenta”, prepara la rinascita.
Perché l’autunno è la stagione di Francesco? Perché è da lui che parte la scintilla della trasformazione, accesa dalle parole nascoste in vecchie lettere, prima vissute come foglie morte, inopportune e fastidiose, poi come riappropriazione e purificazione, infine come rigenerazione e rinascita. Forse per questo i due anziani non compaiono nell’indice, come il giallo e il rosso non si vedono sotto la clorofilla, ma ci sono, nutrono la pianta e l’aiuteranno a purificarsi, in vista del sonno dell’inverno e del risveglio in primavera.
Inverno e estate sono stagioni estreme, come spiega il loro etimo. Quando Dante inizia il suo viaggio, Caronte descrive l’inferno come il luogo degli estremi dove si sta “nelle tenebre etterne, in caldo e in gelo”. In effetti in queste due stagioni i personaggi vivono così, nel gelo dei sentimenti e nel torrido delle loro passioni. I nomi che ricorrono nell’indice, oltre a Francesco – sempre presente come "seme” da cui tutto deve rinascere - sono pieni di donne. Le donne sono una componente forte delle storie di Patrizia, esplorate in tutti i loro aspetti. Spose e madri, “dure” e “stremate” dal matrimonio prima sognato e poi subito; giovani donne candide e gentili, travolte dalla loro innocenza e gentilezza (Glauce, la giovane moglie di Giasone e ora Ida); donne adulte che vivono con coraggio e forza le difficoltà, si confrontano con la loro diversità (Medea è la “strana”, la straniera), l’accettano e decidono di viverla perché non vogliono perdere se stesse e diventare come le loro madri. I nomi di queste madri a cui si ha paura di somigliare non compaiono nell’indice, come se agissero dall’interno - anime inquiete delle loro figlie - e questa “non presenza” le rende forse ancora più potenti. Le trasgressioni violente e crudeli (verso se stesse e verso gli altri) di Michela e Rosanna (come di Medea) nascono anche dal rifiuto istintivo, incontrollabile di diventare come le proprie madri, dal bisogno di “spezzare la catena” del destino femminile, il cordone ombelicale che ancora lega e nega l’evoluzione. E se il cordone ombelicale viene reciso in età adulta, non è più la separazione benefica che segna la fine del travaglio, ma la lacerazione dolorosa e violenta che spesso ne segna l’inizio.
In queste due stagioni sono presenti anche due “bambini”: Loris nell’inverno e Luca nell’estate. I bambini, come le donne, sono figure centrali nelle storie di Patrizia, simbolo della fragilità della condizione umana e della difficoltà di darle un senso. Bambini esposti alle intemperie della vita e ai limiti di adulti troppo spesso inadeguati a proteggerli, inadeguati al loro ruolo o anche oggettivamente e drammaticamente impossibilitati a svolgerlo, come nel caso dei genitori di Loris. Loris, aldilà della sua età, è un bambino “vero” capace di guardare il mondo con occhi buoni e di leggere nelle persone oltre le apparenze : non si vede bene che col cuore insegna la volpe al Piccolo principe, l’essenziale è invisibile agli occhi. Loris ama teneramente Amedeo, il nonno speciale (nonno era nonno, era speciale e nessuno potrà mai prendere il suo posto) che gli ha insegnato parole magiche, la formula con cui allontanare la paura e il dolore
Com’è che diceva il nonno? “Chiocciola chiocciola marinella, tira fuori le tue cornella”. Ripete tre o quattro volte la frase come un incantesimo di protezione, una preghiera
Loris, che tutti compiangono e commiserano, in realtà è una creatura forte e intera, l’unico capace di riconoscere nel nonno tenerissimo che gli dà i pizzicotti sul naso anche l’uomo, il nonno nascosto; e con la riservatezza, il pudore, il pensiero del cuore proprio dei bambini, non giudica, ma si limita a “vedere”, a “sapere” a “comprendere.
Non sa chi sia la donna di cui ragionano, però sa che suo nonno non era solo quello che conoscevano loro, suo nonno era anche i foglietti che gli passava di nascosto, timidamente, un po’ rosso in faccia, con quelle poesie lunghe, piene di parole sul cielo, sulle stelle, sulla morte. Ne ricorda una che parlava di una donna dai capelli morbidi e ondulati, bella come una regina, diceva, con la gonna sotto il ginocchio e le braccia piene di fiori. Ora capisce che non l’aveva scritta per la nonna Gina. La nonna è morta quando lui era ancora piccolo, anche nelle foto gli è sempre sembrata vecchia, persino in quella del matrimonio col nonno (...) Lui sa che c’era anche un altro nonno, un nonno nascosto, giovane dentro. Vorrebbe dirlo ma non gli escono le parole, preferisce far finta di non aver sentito nulla.
E poi c’è l’altro “bambino”, Luca, un uomo giovane che agisce solo d’istinto, stupito per primo da ciò che sente e che lo muove
«Mi piaci un sacco».
Il ragazzo ha allungato una mano e le sta stringendo il polso, ha mani callose ma non da operaio, la barba ispida, un accenno di herpes sul labbro superiore. (...)
«Mi piaci, non mi mandare via, fammi parlare, fammi stare qui con te».
Lei tira per liberare la mano, alla fine ci riesce ma si graffia con l’orologio di lui: «Smettila, non dire scemenze, sono vecchia per te e sono sposata».
«Farei qualsiasi cosa...»
«Lasciami in pace, non ti conosco, non so chi sei».
«Io sì, invece, ti conosco, so tutto di te. (...)
«Ti ho seguita, ti seguo da mesi, ti conosco, conosco la tua casa, la tua famiglia… no, aspetta, non ti spaventare… lasciami spiegare.» (...)
«Io non sono matto, non sono uno stalker, io… credo di essere innamorato.»
Luca è un bambino “cattivo” e affamato, vuole e prende senza porsi limiti
Pensa a Luca. Avrà trent’anni, magro che gli si contano le ossa, gli occhi azzurri col bianco un po’ ingiallito, lo sguardo affamato ma di cosa lei non lo ha capito. Siamo tutti affamati di qualcosa che manca, che ci riempirebbe ma non c’è mai.
Ma è anche un musicista (sono un musicista, suono il violino) e vuole bene a Buck: gli vuole bene, è il suo cane, l’unico che lo accetta per quello che è, che non lo giudica e non gli fa domande.
Come Bingo, il gatto di Francesco, anche Buck è una creatura saggia e intera che vede per quelle che sono le follie umane, le comprende e le sopporta per istintivo amore. Bingo e Buck anche se (o forse proprio “perché”) umani non sono, nutrono sentimenti forti e generosi e fanno da contraltare dei loro padroni deboli e chiusi in se stessi.
Buck sa che Luca è solo un bambino infelice che cerca invano di colmare i suoi vuoti, così infelice da invidiare Loris, amato nella sua sfortuna: voleva essere guardato, considerato, toccato, esattamente come quel ragazzo lì, quel ragazzo sfortunato. Voleva una madre che lo amasse pure a lui… Non a caso, mentre parte per allontanarsi da tutto, per non esserci, è proprio da un nuovo Loris che pensa di tornare un giorno, per dirgli che è suo padre.
Nell’elenco dei nomi che costituiscono l’indice ci sono due grandi assenti: Ida e Amedeo. Perché? Forse perché sono i “motori” della storia e non semplici personaggi? L’ellissi serve a rafforzare la presenza? Vediamoli più da vicino.
Ida è l’unica figura femminile del libro a non essere madre, eppure è quella più capace di “generare”: la sua capacità di amare in modo assoluto e assolutamente semplice la rende capace di accendere in Francesco la scintilla del cambiamento che piano piano contamina e trasforma tutti i componenti della storia. Ida, come Glauce, è una creatura primaverile, delicata e pura, ma non è fragile come l’infelice sposa di Giasone: la verità degli adulti, il loro ossequio alla conformità sconquassano la sua vita, ma non la spezzano, come invece fanno con Glauce. Ida si salva perché non rinuncia al suo amore, non lo lascia contaminare dalla mediocrità e dalla grettezza degli altri, Amedeo compreso, un altro giovane “eroe” bello e immaturo (come Giasone) che si fa travolgere dai doveri sociali o dalla “ragion di stato”, rinnegando l’amore. Nella lettera in cui ricorda il giorno del matrimonio di Amedeo con Gina (che diventerà la madre di Francesco), il dolore di Ida è lancinante. Quella volta l’amore e l’odio si mescolano e l’odio sembra prevalere sull’amore: eppure lei riesce a descrivere con affetto Gina (pur con una punta di umanissimo orgoglio: la figlia della contadina sembrava lei, non io) una ragazzina con le guanciotte rosse, così diversa dalla donna che rivedrà anni dopo, descritta in un’altra lettera, una moglie ingrassata, con un marito che le sta alle spalle e un figlio che le somiglia solo in qualcosa. Le due lettere raccontano la forza di Ida, la sua capacità di trasformare sempre il negativo in positivo, il rancore in compassione, l’odio in amore.
Si chiamava Gina, aveva qualche anno meno di te e una fonderia che avrebbe aiutato le finanze della tua famiglia. La figlia della contadina sembrava lei, non io, con le guanciotte rosse, i vestitini tirati sul petto e sui fianchi, la faccia tonda, i capelli da brava figliola. La vidi il giorno del fidanzamento, ché venne su con suo padre e sua madre, e poi un altro paio di volte.
Il mattino del vostro matrimonio sentii le campane dalla cucina di quella che, ancora per poco, sarebbe stata la mia casa. Non mi affacciai, continuai a pulire il pavimento, pensando che non stava accadendo. Amedeo è mio, mi dicevo, mio, solo mio, è mia la chiazza di sudore che il sole gli forma sotto le ascelle, è mia la frangia scompigliata dal libeccio, sono mie le dita intrecciate nella tasca del paltò. Amedeo è con me che vuole stare, nell’angolo di soffitta che è l’universo intero, noi soli, il fuoco in mezzo, e tutto il resto fuori. Mi dicevo no, dai, non è possibile, vedrai che ci ripensa, vedrai che te lo ritrovi sulla porta. Ma ti sposasti, successe, le campane alla fine smisero di suonare, il riso si posò sul sagrato e i piccioni scesero a beccarlo, le mie unghie si spezzarono sui commenti dei mattoni, i polpastrelli sanguinarono, io rimasi china a strofinare col bruschino, dando le spalle al mondo perché non mi vedesse piangere, rimasi sola a chiedermi com’era che respiravo ancora e se il freddo che sentivo dentro sarebbe cresciuto fino ad uccidermi. «Potessi io morire durante il tuo viaggio a Capri» mormoravo. Volevo chiudere gli occhi e stendermi in una bara, i capelli sciolti, un bel vestito addosso, i fiori fra le dita, come Ofelia impazzita per Amleto. Forse saresti venuto a vedermi, avresti pianto. «Che il mare t’inghiotta» ripetevo, «che ti uccida, che il traghetto si sfracelli sui Faraglioni, che tu sia maledetto. Spero che lei ti renda infelice, sì, spero che tu sia infelice per tutta la vita.»
Pensavano che non ti avessi più in mente perché ridevo e chiacchieravo con lei, con Paolina che m’era rimasta amica, con mio cognato Natale, invece non c’era giorno che non ricordassi l’odore di sale e di barche, specialmente quando il fine settimana venivo in città a trovare mia sorella e già lì da Colline mi arrivava il vento di mare. Ricordavo la chiazza che il sole ti formava sotto le ascelle, mentre camminavi con la giacca di traverso sulle spalle ed io, intanto, gettavo intorno sguardi per paura che ci vedessero. Ricordavo i tuoi capelli agitati dal libeccio, la mano intrecciata alla mia nella tasca del paltò. Sono immagini che continuo a ripeterti perché mi si sono conficcate dentro, anche ora che tante cose non le rammento più come vorrei. Per me eri sempre come ti avevo conosciuto io, con la camicia alla moda di prima, con la zazzera che ancora ti cadeva liscia e nera sull’occhio, e con lo stesso odore di sole sulle mani; il tempo si era fermato a quando eravamo giovani, a quando c’incontravamo per le scale e all’angolo della strada.
Invece il tempo passava, passavano i giorni, i mesi, gli anni, io cucivo, affondavo le mani e gli occhi nei punti e mi mancavi quanto manca il sole fra le gole buie delle montagne, ma non lo dicevo a nessuno e fingevo di essere felice di tutto, della casetta, del lavoro, della nipote che mia sorella aveva partorito. Volevo scappare dalle colline e tornare in centro, come aveva fatto mia madre tanto tempo prima, correre sotto casa tua e buttarti giù dal letto dove dormivi con tua moglie.
Poi, una mattina ch’ero scesa in città con la corriera, ti vidi al mercato. Eri con tua moglie e con tuo figlio. Tua moglie era ingrassata ancora, tu cominciavi a spiazzarti sulla fronte. La frangia non c’era più, per compensare portavi i capelli un po’ lunghi dietro ma erano radi. Stavi alle spalle di tua moglie mentre lei sollevava oggetti dal banco per guardarli meglio. Tenevi per mano tuo figlio senza parlargli, avevi lo sguardo insofferente. Io ero all’incrocio fra i barroccini, volevo incedere sdegnosa davanti a te, come quando mi vestivo per le signore e attraversavo lo stanzone di Rosachiara con tutti gli occhi puntati addosso, invece mi nascosi dietro le tovaglie appese, calai i capelli sugli occhi, rialzai il bavero del soprabito.
Tuo figlio ti somigliava ma aveva preso qualcosa anche da sua madre. Lo tenevi per mano come se ti aggrappassi a un salvagente, come se il padre fosse lui e tu un bambino o un vecchio, non l’Amedeo che conoscevo io, ma uno misero, grigio, rassegnato. Tornai a casa e cercai il tuo numero sull’elenco. Non lo avevo mai fatto prima.
Diversamente da Glauce, Ida non si lascia “uccidere” da Giasone ma, diversamente da Medea, neppure lo uccide dentro di sé o cerca di punirlo, non si lascia agire dall’odio: lei continua ad amarlo, ad amare e così salva se stessa, lui e tutto ciò con cui viene in contatto. Rosanna, la sorella di Michela, ricorda Ida in questa capacità di amare che la porta a superare i propri limiti, a dominare la paura per essere finalmente madre e persona.
Ha paura, ancora la stessa maledetta paura di sempre, ha paura di tutto ciò che può accadere e persino di ciò che è già accaduto. Ha paura di essere figlia e di essere madre, ha paura di somigliare a Neda e a Michela, di non saper dimostrare l’amore che prova. Ma lo ama, ama questo bambino.
“Non so se sarò tua madre, non so se saprò esserlo fino in fondo. Ma ti amo, ti amo e non m’interessa come sei nato, ti amo e basta. Stai sereno, bimbo mio, vedrai che tuo padre prima o poi torna. E vedrai che tua madre se la cava. Forse.”
Amedeo entra in scena attraverso lo sguardo del figlio Francesco. Nel libro i personaggi vengono presentati da altri personaggi e Amedeo è quello descritto da più voci. La prima è appunto quella di Francesco. Per lui Amedeo è un padre severo che gli metteva una mano sulla spalla solo per farsi fotografare e che non era mai contento dei voti che portava a casa, e un marito distante, che vive in una casa piena di silenzi. Ma da subito, proprio attraverso lo sguardo del figlio, si intuisce che Amedeo non è solo questo. Ci sono degli indizi. C’è un famoso materasso che suo padre insisteva per portare giù, nel fondo dove trascorreva tutte quelle ore di pomeriggio dopo il lavoro; c’è quella strana abitudine di farsi sempre la barba dopo mangiato; ci sono quelle scarpe di cuoio marrone che anche da vecchio, quando ormai non si sbarbava più, continua a tenere lustre, a lucidare con la ceretta. È ciò che rimane del ragazzo elegante e scanzonato, col soprabito color cammello, la cravatta un poco allentata, una zazzera di capelli neri più lunghi del dovuto che ha fatto innamorare Ida tanti anni prima. Per lei Amedeo è da subito l’Uomo, il suo uomo dalla voce forte e bella, che le punta in faccia due occhi neri ch’erano due fanali. Michela, invece, vede Amedeo solo com’è diventato, un vecchio, un anziano come tanti ma non di quelli simpatici, chiuso nel suo ruolo di suocero, utile – solo utile – che si occupa del nipote, fa la spesa, paga le bollette e poi se ne torna a casa sua. E forse anche per Francesco gli indizi resterebbero solo indizi e il padre solo una figura severa e sbiadita se non ci fosse l’incontro con le lettere di Ida, che trova per caso mettendo a posto la casa di Amedeo dopo la sua morte.
Ecco un pacco di lettere, tutte simili, mantrugiate, sporche, evidentemente lette e rilette. Ne prende in mano una a caso, la prima che gli capita. Ha un vago sentore di cipria, di spigo stantio, di roba da donna vecchia. (...)
Ora ha in mano una pagina vergata con una calligrafia strana, che ricorda quella antica che hanno tutti i vecchi, ma pende verso destra e sembra scritta da qualcuno ubriaco o malato.
Non mi sono fatta più viva dall’ultima lettera, quella nella quale ti ho mandato la fotografia di me coi fiori, scattata quando ero giovane e ci siamo conosciuti, ma la mia mente se ne va e ti scrivo prima che si oscuri di nuovo e torni il buio. (...) amore mio, mio unico amore, e loro dicono che devo morire e io ho paura perché non so più chi sono e allora vado a imbucare la lettera prima di dimenticare dov’è la cassetta della posta.
Tua Ida. Sì, è il mio nome, questo lo so, mi chiamo Ida.
Il primo istinto di Francesco è non andare oltre: “Ok”, pensa, “ Amedeo era mio padre. Ok, questa donna lo ha conosciuto e forse amato. Il passato è passato, certe cose stanno meglio sepolte”. Ma vuole sapere, ne ha bisogno…
Perciò decide di andare avanti. È il primo passo verso il cambiamento, l’inizio della trasformazione, segnato nella scrittura (la magistrale scrittura di Patrizia) da quel Ma collocato dopo il punto fermo, a segnare il distacco da ciò che precede e dal passato.
Così Francesco continua a leggere, non per suo padre o per sua madre, per sé, perché in quelle lettere ha intravisto una scintilla … qualcosa che capisce di avere cercato da tanto tempo, qualcosa di cui ha bisogno e gli mancava. E sente che ora ha qualcosa in mezzo al petto, qualcosa che fino a ieri non c’era: il padre ritrovato, il nonno nascosto di Loris, comincia ad “agire” e gli permette di “origliare se stesso”, come direbbe Bloom, cioè di ascoltare e riconoscere la propria voce interiore, di immaginare un se stesso possibile.
Ma chi tocca profondamente Francesco, più del padre, è Ida, una donna che lascia il segno, un’unghiata: di lei si sente quasi innamorato, è anche la sua Ida ormai. Così, leggendo il racconto dell’abbandono, sente il suo dolore e diventa insieme padre e figlio:
Il cuore di Francesco sta battendo forte, vede Ida davanti alla porta, i capelli sciolti, le spalle che tremano. Sente il suo dolore. Vede anche suo padre … è giovane come nella foto, ha l’espressione sgomenta, lacerata, e sta scuotendo la testa. “No, babbo, no, non lo fare” vorrebbe gridargli “non dire no, c’è un’altra possibilità, diventa davvero Amedeo, diventa quello che lei vuole, abbi coraggio, è la tua possibilità, ce l’hai ancora” Ora è lui Amedeo, e compirebbe senza alcun indugio o timore quel passo difficile – far entrare in casa Ida, chiuderla nelle sue braccia, baciala sui capelli morbidi, difenderla da chiunque. Ora è tutto semplice e possibile.
Ed è su questa apertura al “possibile” che, tempo dopo, dopo altre lettere e altre vicende, termina il lungo viaggio di Francesco. Ancora una volta la scrittura sottolinea con un Ma la trasformazione in atto, il cambiamento di prospettiva.
Magari, se un giorno riprenderemo a vivere insieme, Michela e io, torneremo a non vederci, a non ascoltarci … Ma c’è un sussurro ora nella sua voce che mi è caro, che raggiunge quella parte di me dove lei è ancora quella di un tempo.
Sono parole che echeggiano quelle dell’ultima lettera di Ida e che il destino e Francesco porteranno a compimento
Amore… ora non ricordo il tuo nome, sulla busta però l’ho scritto giusto, accanto all’indirizzo. (...) Amore… è quello che volevamo, no? Vedi, ci siamo riusciti a invecchiare insieme, a morire insieme. Mi guardavi negli occhi e dicevi insieme, sempre insieme, figli, nipoti, cane, sì, anche noi col cane, e poi seppelliti vicini. Ti amo, amore, non mi ricordo tutto per bene, non mi ricordo chi sei, non so più il tuo nome, però ti amo, ti ho sempre amato, ti amerò sempre.
Ci sarà questo nuovo inizio? Si potrà dire, con Andrea Chenier, “è dal dolore che a me venne l’amore”? Dopo la purificazione dell’autunno e il sonno dell’inverno, ci sarà finalmente una primavera? Sta a chi legge immaginare il seguito della storia, cercandone accenni e indizi nelle pagine del libro e nelle strategie testuali dell’autrice. Una cosa però mi sento di affermare a conclusione di questo viaggio tra il dire e il non dire, fra il mostrare e il nascondere, e cioè che tutte le storie narrate, drammatiche, intense, emozionanti, ma anche amare e impietose, sono tutte storie d’amore. Perché, secondo me, il vero protagonista di Una casa di vento è l’Amore, quello che, per dirla con Dante “muove il sole e l’altre stelle”. L’amore in tutti i suoi aspetti e sfumature, non certo solo l‘amore romantico o l’amore luminoso. L’amore di cui parla Patrizia è a volte durissimo e crudo. Del resto, per tirare in ballo ancora Dante, lui che inizia e conclude la sua Commedia parlando di Amore, ci ha fatto conoscere tutte le sue sfumature, da quello che redime dal male a quello che al male conduce e uccide l’anima e il corpo. Ed è l’Amore che trionfa alla fine del viaggio che l’ha fatto sprofondare nell’inferno e scalare la montagna del purgatorio prima di approdare alla luce. Un viaggio voluto da una donna che lo ama così tanto da lasciare il Cielo per dargli soccorso. Il viaggio di Dante è il viaggio di un credente sorretto da una fede senza dubbi, la fede granitica e intera del suo secolo. Per chi, come Francesco, Michela, Luca, Rosanna - come noi - vive in questo secolo “liquido”, credere nell’Amore che redime, nell’Amore come dio che vince la morte del corpo e dell’anima, non è semplice. Quello che Patrizia fa in questo libro è raccontarci un amore non perfetto, non luminoso, non divino, un amore squassato dal vento, terrestre e solo possibile, ma forse proprio per questo capace di farci da guida, perché tanto ci somiglia e perché, come dice Francesco “ Quando uno ha l’amore, babbo, se lo deve tenere stretto, perché non c’è altro, davvero non c’è altro, credimi”.
Una casa di vento: incipit

Incipit de Una casa di vento di Patrizia Poli
Sale la scala a piedi, senza accendere la luce. Gli par di sentire Michela: «Hai tanto insistito per l’ascensore e ora non lo prendi?». Gira la chiave ed entra, lo accoglie la vampa dei termosifoni, s’infila in camera di suo figlio, subito sulla destra, con la porta spalancata perché devono averlo a portata d’orecchio anche mentre dorme. Si lascia cadere ai piedi del letto, il respiro pesante di Loris dà spessore al buio.
«Babbo.»
«Dormi, ciccio.»
«Perché ci hai messo tanto a tornare?»
«Ho fatto un giro, si sta bene fuori.»
«Volevo salutare il nonno.»
«Poi un giorno ti ci porto, ora dormi, è quasi l’alba. Cazzo, hai di nuovo la tosse.» Gli sistema il lenzuolo sotto il mento, poggia le labbra sulla fronte che è appiccicaticcia, sgradevole, calda. «Buonanotte, per quel che ne resta.»
«Buonanotte, babbo.»
Spera che si riaddormenti, che non stia sveglio nei suoi laghi di sudore, nelle sue tossi convulse che grattano la gola. Va in camera sua, si spoglia, lascia cadere gli abiti sul parquet, tutti in un mucchio solo, sa che domani Michela si arrabbierà anche per questo, ma adesso non importa, adesso è così e basta. Si stende accanto a lei. Odori e scricchiolii prendono corpo dall’oscurità. Il ticchettio della sveglia, il puzzo dei calzini che ha tenuto su tutto il giorno, la tosse di Loris, secca e raschiante, il gatto che russa fra le gambe di sua moglie. Non saprebbe dire se lei dorme o fa finta, in ogni caso è molto tardi, è stanco e non gli va di parlare. Gli occhi, però, rimangono aperti e si adattano pian piano all’oscurità della camera. Comincia a intravedere il profilo di Michela. La frangia liscia arriva fino al naso, che è grosso, la bocca è come un taglio nella faccia, solo il labbro inferiore è carnoso, l’altro è sottile, lungo. Ha un accenno di doppio mento che s’intensifica non appena ingrassa. La conosce a palmo a palmo, anni fa la percorreva con la lingua dalla fronte alle dita dei piedi, imparando il sapore dei suoi orifizi, dei suoi umori nascosti, della sua pelle, delle prime increspature che non erano ancora rughe. Ora lei non ha più un odore suo, sa di bagnoschiuma, di candeggina, di gatto. Un piede lo sfiora poi si ritrae, è freddo, con le unghie che tagliano.
Lei sente il suo sospiro e si gira nel letto, si è svegliata o forse non dormiva. Non apre bocca, però, non lo consola. Lui avrebbe tante cose da dire, le parlerebbe di come suo padre gli metteva una mano sulla spalla solo per farsi fotografare, di quando gli strappò la maglietta di dosso per punirlo, di come non era mai contento dei voti che portava a casa, di quella volta che lo sgridò perché, colorando l’album, era andato fuori dai contorni. Parlerebbe anche volentieri di tutti quei silenzi a cena, della mano di sua madre che stringeva la padella così forte da far cadere la frittata. E pure del famoso materasso, sì, che suo padre insisteva per portarlo giù, nel fondo dove trascorreva tutte quelle ore di pomeriggio dopo il lavoro, e sua madre a chiedergli perché non lo butti e perché ti fai sempre la barba dopo mangiato. Parlerebbe di tutte queste cose per vedere se quel blocco di pietra che ha sul cuore potrebbe spostarsi un pochino. Prima lei lo avrebbe anche ascoltato, pure tenendolo abbracciato, a quei tempi là, quelli della Uno. Ora gli direbbe solo: «Me l’hai già detto, che ci vuoi fare, è così.»
In una notte come questa, la notte che hanno appena tumulato tuo padre in quello schifo di loculo di cemento, Cristo santo, non dovresti fissare il soffitto, dovresti stare fra le braccia di tua moglie che ti dice «piangi amore mio sfogati», come si vede nelle fiction. A quel tempo là parlavano, quando fermavano la macchina sulla strada del Castellaccio - e la macchina non era quella di adesso e nemmeno quella prima, era la vecchia Uno - in quel posto dove di notte si vedono tutte le luci della città e delle navi in rada. Allora stavano mano nella mano per tutto il tempo, si guardavano la bocca, si baciavano. La lingua di lei cercava la sua, prima come un guizzo sulla punta, poi a fondo, fino alla gola, fino al palato, e lui rispondeva subito, la stringeva, la stritolava. E si raccontavano ogni cosa, parlavano fitto, le lucciole entravano dal finestrino, accendevano l’abitacolo d’estate, i fiati appannavano i vetri d’inverno, in macchina c’era odore del vino che avevano bevuto, del profumo di marca che lei si metteva, di sudore buono. «Chissà come saranno i nostri figli, chissà dove saremo noi fra qualche anno» gli diceva lei. Qui siamo, cazzo, qui, in questa stanza che hai arredato tu e ora non ti piace, con te che smani per le caldane e Loris che si gratta e respira male. A quei tempi lo avrebbe consolato, lo avrebbe stretto al cuore, magari avrebbe anche pianto con lui. Di piangere, lei, ha smesso da tanto. La musica si è spenta, l’amore evaporato come acqua di mare rimasta fra gli scogli. Quando l’acqua se ne va, rimangono cristalli aguzzi e amari, rimangono denti di cane che, se ti ci siedi sopra, strappano il costume, rimangono erbe marine che bucano, forse non sono erbe ma bestie con le chele, rimane il sale, proprio preciso a quello che lasciano le lacrime sulla pelle.
Dentro si sente come se avesse attraversato il deserto dimenticando a casa la borraccia. Il viso s’inumidisce, suda ghiaccio nella camera surriscaldata. Sono costretti a tenere quella temperatura per Loris, ma l’autunno è mite, un novembre che sta per diventare dicembre senza che nessuno se ne accorga, dicono che il freddo, però, quello vero, sia in arrivo a giorni. A suo padre il freddo dava parecchio fastidio negli ultimi tempi, stava ingobbito nella poltrona, non si voleva lavare. Francesco si annusa le mani, ci sente l’odore dell’olio con cui hanno lucidato le panche della chiesa e anche la bara. Forse usano lo stesso prodotto per tutto quello che è collegato alla morte. La bara è entrata nel loculo con una traiettoria sicura, forse l’unica certa della vita. Lui ha guardato Michela, sperando di vedere qualcosa, di cogliere uno di quei tic che indicano turbamento, magari anche solo la gola che deglutisce, ma lei aveva la solita espressione di sempre. Michela fa tutto quello che deve fare ma poi te lo rinfaccia, con gli occhi, con la postura del corpo. E lì lui si è spaventato, ha capito che si muore, che un giorno ti svegli ma non vai a letto la sera, apri il diario ma non ci scrivi, apri bocca ma non respiri, come suo padre all’ospedale che spalancava la gola e si sentiva il rumore attraverso la laringe. Ha capito che toccherà anche a Loris, che succederà presto, e che loro non possono farci nulla. Lui è padre ma non può proteggere suo figlio, non può difenderlo, può solo aspettarne la morte, che è innaturale, fuori dall’ordine normale delle cose. Ma stanotte deve accantonare per un momento persino il pensiero di Loris e concentrarsi solo sul proprio padre, congedarsi da lui come si deve. Di parole fra loro ce ne sono sempre state poche. Suo padre era quello che montava in silenzio le ruote del triciclo e poi stava a guardare mentre lui andava su e giù ai giardinetti spelacchiati della Questura. Quando si voltava, lo vedeva distratto che si fissava le scarpe.
Si gira nel letto, dà la schiena a sua moglie, prova a dormire. Lei soffia nel buio, forse sospira o forse è stato il gatto, o il primo inizio di vento dietro la tapparella.
Ormai è giorno, c’è una luce grigia che sporca la camera. Si alza, va in bagno a urinare, si prepara un caffè con la macchinetta a capsule compatibili. Michela si è alzata prima di lui e ora gli dà le spalle, con i polsi affondati nella schiuma del lavello.
«Il bimbo?»
«Dorme, meno male.»
«E allora lascialo dormire, non fare tutto quel casino. Perché non dai la via alla lavastoviglie invece di rigovernare?»
«Per due piatti? Non c’eri ieri sera a cena. Non ci sei mai.»
«È morto mio padre, te lo sei scordato? Avevo bisogno di un po’ d’aria, di schiarirmi le idee, di stare da solo.»
«Se eri da solo, non lo so.»
«Sempre gli stessi discorsi del cazzo.»
Lei si volta per metà: «Stare insieme a te è come lanciarsi tutti i giorni a testa bassa contro un istrice. E io sono stufa, stufa, stufa di dissanguarmi. Voglio un po’ di pace. Non mi va di litigare sempre.»
«Nemmeno a me, ma siamo quello che siamo.»
Vederla dibattersi come una farfalla intrappolata sotto il bicchiere della sua indifferenza gli procura una certa soddisfazione sadica, deve ammetterlo. «Io vado.»
«Sì, è meglio.»
Esce senza nemmeno radersi. Il gatto si piazza accanto alla porta e lo fissa, come per chiedergli dove vai così presto, dove cazzo vai tutti i giorni a quest’ora, che bisogno c’è di uscire all’alba se l’ambulatorio apre alle dieci? Ma non ce la fa a rimanere, non ce la fa vedere Loris che si sveglia e comincia subito a sudare e tossire, che lo guarda con quegli occhi imploranti. E non ce la fa a rimanere con lei, perché dovrebbe trovare parole diverse, parole morbide che non gli escono più di bocca da tanto tempo, dovrebbe avere il coraggio di toccarla, di stringerla fra le braccia e chiederle: «Com’è che ci siamo ridotti così? Siamo noi, cazzo, siamo ancora noi, Francesco e Michela, siamo tu ed io.»
Vincenzo Zonno, "L'ultimo spettacolo"

L’ultimo spettacolo
Vincenzo Zonno
Catartica Edizioni, 2020
Pp 192,
14,00
Ormai Vincenzo Zonno ci ha abituato al proprio stile superlativo (a parte piccolissimi errori, forse solo refusi) di cui riveste e ammanta il suo surrealismo, che mescola a vari generi letterari, dal romanzo storico, all’horror, qui, nello specifico, alla fantascienza.
Al solito, confesso di non aver capito molto della trama del tutto onirica – e di non aver nemmeno avuto interesse a comprendere - ma di essere stata colpita dall’ambientazione. In un futuro ucronico e distopico, dove tutto è controllato dal governo centrale, i cittadini sono indottrinati e spiati attraverso gli schermi della televisione. Ogni cosa è artificiale, l’erba è sintetica, i fiori sono di stoffa, il profumo viene spruzzato da erogatori nascosti, ci si sposta a bordo di grandiosi dirigibili. Ogni aspetto della vita è diretto e amministrato dal governo. Le relazioni amorose sono regolamentate, persino la religione e l’accesso al paradiso esigono una tessera. Per decidere se si è colpevoli o innocenti c’è un elaboratore elettronico che esamina i dati degli interrogatori e stila il giudizio finale. È stata riammessa la tortura e la pena di morte viene comminata senza rimpianti. Persino i mali di stagione sono disciplinati dall’alto.
I cittadini vivono (o, meglio, vegetano) sollevati dal pensiero di scegliere e di ragionare con la propria testa, è tutto semplice, asettico, freddo. Solo il sogno li salva. Come nel film Matrix, non si sa qual è la realtà e dove finisce l’immaginazione. Non si sa chi crea cosa, chi plasma chi. Chi dorme e chi è sveglio. Chi è carnefice e chi vittima. Forse "sogno quindi sono"?
La realtà è piatta e asfissiante, ma c’è “l’ultimo spettacolo” messo in scena per Rebecca, un tempo insegnante di danza e che ora non può nemmeno spiegare a una bambina come si balla. Una bellissima performance su un palcoscenico. Un mondo parallelo fatto di arte fantasmagorica che sublima la bruttezza del reale.
I personaggi del romanzo sono vari e strani. Harpo, un tizio che viene accusato d’omicidio ma non si può interrogare perché dorme. Un elettricista che uccide la gente. Rafaela, una ragazza morta su una panchina. Rebecca, la ex di Harpo. Carl, il delegato che indaga sull’omicidio di Rafaela, incarnazione fisica del travet, della burocrazia spersonalizzata. Convergono e si mischiano, entrano ed escono dal sogno, dal racconto che uno dei protagonisti sta scrivendo, dalla mente confusa del lettore.
Una scrittura bellissima ma, come già detto, volutamente al servizio di trame sempre più da teatro dell’assurdo. Un romanzo di nicchia, frutto di autoerotismo letterario, diretto a chi ha voglia di faticare, ricostruire, far combaciare i pezzi del puzzle. Zonno, è così. O lo si odia o lo si ama. Devo ancora decidere.
Tanti sassolini nella scarpa
Poiché è meglio un’autentica cattiveria che una falsa bontà, mi pare giunto il momento che qualcuno dica la verità. La verità scomoda, sgradevole, che pure Gesù c’è morto per dirla.
Oggi è esattamente il mio quarantesimo giorno di clausura. La mia quarantena autoimposta.
Da mercoledì 4 marzo, da prima di qualsiasi ingiunzione governativa, non metto il naso fuori del cancello del condominio, nemmeno un minuto, nemmeno per fare la spesa o “pisciare” il cane. A queste cose pensa mio marito.
All’inizio fu il focolaio in Cina. Io non mi preoccupai. Ho cinquantotto anni e di epidemie ne ho viste tante. Ho fatto l’Aids, Ebola, la Sars, la suina e l’aviaria. Persino la mucca pazza. Passerà, mi sono detta, la fermeranno come tutte le altre. Non è stato così. Ho cominciato a subodorare che qualcosa questa volta non andava, forse per intelligenza, forse per intuizione.
Il 22 di febbraio mando un messaggio a Tizia: “Pensi sia il caso di vederci stasera a cena?”
Risposta: “Non ci si può mica chiudere in casa.” Ok, la cena è prenotata, vado. Il ristorante è affollatissimo, c’è uno che tossisce e starnuta. Io sto con l’ansia.
Il 29 febbraio arriva una foto di un piatto di pappardelle al ragù di un ristorante di montagna. Tizia scrive: “Voi quarantena, noi queste”.
Il 4 marzo devo accompagnare mia madre a fare una tac in clinica. Vado, faccio la tac e torno a casa di corsa. Non ne uscirò più.
Il 6 marzo posto su fb uno dei primi disperati appelli di una rianimatrice che ci esorta a stare a casa perché la terapia intensiva sta già collassando. Caia mi dice, testuali parole, “è una psicopatica.” Quella sera mio marito va a cena dalla figlia e dalle nipotine. Io resto a casa. Ho mal di testa da tre giorni, non voglio eventualmente contagiare nessuno
Il 7 marzo ancora Caia: “Noi oggi bellissima passeggiata sul fiume e tortelli di XXX”.
Il 9 marzo il governo chiude La Lombardia e il giorno successivo, mi pare, chiude anche tutta l’Italia.
Io in casa, triste, mogia, soprattutto spaventata a morte dal virus. Mi telefona Sempronia: “Non c’è da preoccuparsi, è tutta una montatura dei giornalisti”..
Da allora sono passati tanti giorni e i decreti si sono succeduti ai decreti.
Io sempre ligia e sempre a casa, a cercare di dare un senso alle giornate, ad ascoltare le informazioni sempre più controverse e, alle 18, come tutti, il bollettino dei morti. E la fila dei carri al crematorio. E la gente che racconta il girone dantesco dell’intubazione, della pronazione. Ad ascoltare ogni più piccolo segnale del mio corpo per capire se sta per addentarmi il mostro. A fare da cameriera agli altri della famiglia. Perché, se manco io, qui si va a rotoli. A scrivere un intero romanzo, almeno per credere che tutto questo mi sia servito a qualcosa.
E altri giorni passano. E i provvedimenti si susseguono, sempre meno seri, sempre più isterici e ridicoli. E piovono da tutte le parti. Da Conte che, poveraccio, è sfinito, sta facendo quello che può per arginare una situazione che gli è sfuggita di mano e che non ha avuto il coraggio di bloccare quando era il momento. Perché, per carità, meglio che muoiano le persone piuttosto che qualcuno venga considerato, non sia mai, razzista. E piovono dai presidenti delle regioni, ché almeno ci si ricordi anche di loro, visto che prima manco ne conoscevamo il nome. E piovono dai sindaci, che diventano sceriffi e si atteggiano a salvatori della patria. Assurdi, nevrotici. Non puoi portare il cane oltre cento metri da casa. E se io ho un muro davanti a casa mia? Non puoi sedere in auto a fianco di quello stesso marito con cui dividi il letto, la tazza del water e la tavola. Non puoi far prendere una boccata d’aria al bambino.
Ecco, io comincio ad agitarmi, a stare male, a pensare che stiamo esagerando, perdendo il cervello e il buon senso. Penso che il giusto sta sempre nel mezzo, che, se uno fosse equilibrato, non ci sarebbe bisogno di polizia e deliranti autocertificazioni che cambiano ogni giorno.
Ma il governo deve spostare la colpa da se stesso, dalla propria iniziale dabbenaggine, al comune cittadino. Così si fa la caccia alla mamma col passeggino, al signore che porta giù il cane, a quello che vuole respirare un po’ d’aria. Diventano loro gli untori, il pericolo pubblico. Gli assassini. E cominciano a circolare foto truccate di falsi assembramenti, prese ad arte in vicoli stretti e con l’obbiettivo schiacciato. Per dimostrarci quanto siamo stupidi, infantili e cattivi.
Ma c’è anche chi sta in un condominio che dà su una chiostra puzzolente piena di topi, c’è chi non ha uno straccio di balcone nemmeno per cantare l’inno di Mameli. C’è chi ha bisogno di un poco di respiro.
E il mio disagio cresce. E penso che non mi va di uscire due minuti, entro il raggio di cento metri, con una mascherina che mi toglie il respiro e mi appanna gli occhiali, col rischio che un poliziotto – categoria che non ho mai amato – mi chieda i documenti come fossi una delinquente.
E i giorni di prigionia aumentano e mi sento soffocare e comincio a capire che Cacciari e Crepet hanno ragione: la casa è un inferno. La convivenza forzata è un incubo, le stanze sono celle, le famiglie sono covi di serpi che non possono districarsi dal groviglio e scappare.
E comincio a desiderare la mia vita di prima, a sentire una straziante nostalgia per la mia libertà, la libertà di scegliere di rimanere a casa a scrivere il mio libro. Ma anche di uscire all’aria aperta, al sole, ad annusare l’odore del mare. Con la bocca e il naso liberi. Senza disinfettante.
Io pratico il distanziamento sociale da quando sono nata. La vita mondana non mi manca. Non mi mancano le cene forzate con le persone che non ho voglia di vedere. Non mi manca giocare a carte. Non mi manca nemmeno la retorica degli abbracci. Mai andata in giro ad abbracciare la gente e, quando mi baciavano sulle guance, di nascosto mi sono sempre pulita anche in tempi non sospetti.
Mi manca piuttosto prendere il mio cane, varcare il cancelletto del condominio e uscire sola, libera. LIBERA. Senza autocertificazioni, senza documenti in tasca. Libera di stare fuori quanto voglio, ben distanziata da gente che, comunque, in ogni caso non mi andrebbe di incontrare.
E quando il mio cane mi guarda incredulo, invitandomi a superare quel cancello che ormai è diventato una barriera psicologica, mi si strazia il cuore. Sì, si strazia per quello e non per i 16000 morti.
Io non credo alla solidarietà, a quelli che, nel momento del bisogno, tirano fuori l’Italia migliore. Io credo alla verità e la verità è fatta di meschinità, di egoismi, di cattiveria. E ognuno pensa a se stesso. Io penso a me stessa. Alla mia vita che non c’è più. Al mare, all’aria aperta, a un aereo da prendere per andare all’altro capo del mondo.
Ed ecco che Tizia, Caia e Sempronia insorgono. Si fanno improvvisamente paladine dello stare in casa, della repressione di ogni libertà, della quarantena infinita e felice. Diventano accanite. Fanno la caccia al vicino che esce troppo, controllano quanti bambini sono fuori. Sì, proprio loro, quelle che andavano a cena al ristorante e che sono rimaste a casa solo perché ce le hanno costrette.
E allora, oltre alla tristezza per un futuro che non sarà mai più quello che avevamo, oltre alla paura di morire sola e intubata, il sentimento che adesso mi pervade è la RABBIA. Violenta, acre in bocca, verde come bile. Rabbia e senso d’ingiustizia per quello che mi è stato tolto, per questi arresti domiciliari che sconto incolpevole. Rabbia contro le imposizioni, i divieti a raffica, la polizia sotto casa, i droni, gli elicotteri e le persone che mi dicono di pensare a chi sta peggio.
C’è sempre chi sta peggio. Anche mentre voi andavate bellamente al ristorante ogni sacrosanto sabato sera, c’era chi stava peggio, chi moriva di cancro, straziato dai dolori, chi finiva sotto una macchina, e, magari, non aveva nemmeno 90 anni, non sbavava e si cacava addosso, magari era giovane e aveva figli piccoli. Ma questo non v’impediva di uscire a divertirvi, perche “non ci si può mica chiudere in casa”. Eh, no, certo.
Ah, e l’enfasi dei vecchi che stanno morendo nelle case di riposo, dove la mettiamo? Familiari disperati che non possono vederli. Ma se davvero ti stava a cuore il nonno, non lo abbandonavi, te lo tenevi in casa e gli cambiavi il pannolone piscioso, che si sa che in quei posti ci vanno a morire.
Però chi, come me, dice la verità ora è diventato ai vostri occhi un irresponsabile. E la verità è che ci sta capitando un trauma, una tragedia cosmica, e non esistono le famiglie della Vodafone, quelle alacri, attive e felici di incontrarsi su internet. O quelle che impastano gioiose perché, finalmente, hanno trovato il lievito per farsi il pane e la crostata. Quelle che non vedono l’ora di abbracciarsi. Quelle che fanno ginnastica e annaffiano i gerani. Quelle che sorridono alle telecamere dal divano. Telecamere, che, per inciso, sono le uniche ammesse là dove si muore da soli, dove a nessun congiunto affranto è permesso entrare.
Diciamola la verità. Che su quel divano bisogna pur starci e ci staremo finché dovremo, ma senza sorriso sulle labbra, senza aria da salvatori della patria. Che, secondo come andrà finire, dopo tutti questi sacrifici odiosi, manco la nostra di pellaccia salveremo.
I sopravvissuti
Correva l’anno 1979 e uno sceneggiato - o meglio serie televisiva, come si chiamano quelle che oggi imperversano sulla tv on demand – ci catturò e spaventò tutti. Si tratta de I sopravvissuti, serial fantascientifico d’inquietante e strabiliante attualità. Un virus, sfuggito a un laboratorio cinese, infetta il mondo. Sono in pochi a sopravvivere, lottando per non soccombere in uno scenario post apocalittico, caotico e imbarbarito.
Eh sì, anche adesso par di stare in un film. Mascherine, assalti ai supermercati, fughe di massa dalle zone interdette, orribili immagini di pazienti “pronati” in sale di rianimazione sovraffollate e da incubo.
Ma fino a che non toccherà a qualcuno che conosciamo - non uno della tv, non il capo del partito democratico Zingaretti o un uomo della scorta di Salvini, e nemmeno il salumiere o il tabaccaio del nostro quartiere - ma proprio uno che conosciamo bene, un amico o un familiare, fino ad allora continueremo a pensare che sia tutta una grande esagerazione mediatica, qualcosa che non ci riguarda. Invece è una pandemia bella e buona, di quelle che non si vedevano da un secolo, e con le quali, ahimè, dovremo fare i conti sempre più spesso.
Quando una specie si fa troppo aggressiva e invadente, quando contamina, riscalda e distrugge il paese che la ospita, sbucano fuori i virus nascosti che, ne sono certa, sono gli anticorpi della terra. La terra si difende, elimina una parte degli invasori, la parte più debole e inutile: i vecchi, i malati, gli immunodepressi.
Eppure io penso che non tutto il male viene per nuocere. Diciamo che, per esperienza personale, ormai ne ho fatto il mio motto. Possiamo sempre trovare nelle difficoltà delle opportunità. Intanto stiamo rivalutando la vita normale, tutto quello che facevamo fino a quindici giorni fa, e ci sembrava pure noioso: uscire da casa, abbracciare un bambino, programmare un viaggio, cenare in un ristorante, fare due passi. Già questo ti fa capire che prima eri felice anche se non te ne rendevi conto, che avevi qualcosa a cui adesso vorresti tornare, che eri libero senza saperlo.
Rivalutiamo ciò che facevamo e, tuttavia, dobbiamo sapercene consapevolmente astenere. Non è necessario fare l’apericena, no, non lo è per niente. Fino a venti anni fa non sapevamo neppure cosa fosse. E, se torniamo indietro di quaranta anni, il sabato sera cenavamo tutti in famiglia. Non è necessario nemmeno per il proprietario del locale perché, se lui morirà, o se noi moriremo, la sua attività non servirà proprio più a niente.
Dobbiamo avere rispetto, senso civico, prudenza e saper attendere con pazienza. Astenerci dal giudicare ciò che non conosciamo e non abbiamo ancora vissuto.
Restate in casa, leggete un libro, guardate un film divertente o istruttivo, recuperate la lentezza, riscoprite i rapporti con i familiari e i social come mezzi d’informazione e di comunicazione e non come recipienti d’odio.
Fatelo senza prospettive, senza scadenze, perché non sappiamo quanto durerà, né se e come finirà.
Aldo Dalla Vecchia, "Mina per neofiti"

Mina per neofiti
Aldo Dalla Vecchia
Graphe .it, 2020
pp 101
8,50
Prima di parlare di Mina per neofiti, ultima fatica di Aldo Dalla Vecchia, devo fare una precisazione che scandalizzerà i più e mi attirerà il discredito di tutti. A me non piace Mina, non amo la sua voce – quando la sento cambio canale – non amo il suo personaggio né chi, come il giornalista Vincenzo Mollica, l’ha sempre incensata e ha contribuito a costruirne il mito. Penso che sia una bravissima cantante, una raffinata interprete, con dei notevoli virtuosismi vocali, ma come ce ne sono altre, ad esempio Giorgia.
Ho letto questo libro, tuttavia, con interesse, e con un pizzico di curiosità. L’interesse è stato soddisfatto, la curiosità no.
Il fascino di questa biografia – definita un “bigino”, un manualetto di consultazione sulla carriera e le opere della tigre di Cremona - sta ancora nell’inconfondibile penna di Aldo Dalla Vecchia, sempre garbata e nostalgica, che ci fa rivivere molti decenni della nostra cultura nazionale. A parte la Storia con la Esse maiuscola, quello che impatta sul lettore è il fascino della ricostruzione d’epoca, le piacevoli atmosfere del tempo che fu, il rimpianto.
Preferisco la parte dedicata agli anni sessanta e settanta, quando Mina si concedeva ancora come personaggio televisivo glamour. Televisione degli esordi, quella, con show come Milleluci capaci di fare ventitré milioni di spettatori, cifre inarrivabili oggi. Rivediamo Mina con Raffaella Carrà, a colpi di tacchi, minigonne e ombelico scoperto, oppure Mina con Alberto Lupo, eroe de La Cittadella, sogno erotico delle casalinghe, con la sua voce suadente e le sue “parole parole” riprese persino da Papa Francesco.
Mina è stata, oltre che una brava cantante, un personaggio sofisticato, elegante, modernissimo che molte donne imitavano per look e acconciature. Dopo si è trasformata in un mito sfuggente, una sorta di Elena Ferrante della musica. Laddove Battisti è riuscito, ahimè, addirittura a morire, lei si è limitata a oscurarsi, a rendersi irraggiungibile, preziosa e… “costosa”.
Il personaggio Mina, oggi ormai alle soglie degli ottanta anni, è qui mostrato nelle sue molteplici sfaccettature, ad esempio la sua partecipazione come articolista a giornali importanti. Pare che Mina Mazzini abbia, oltre ad un’ugola d’oro, anche una penna sagace e incisiva.
La mia curiosità, invece, è stata disattesa. Mi aspettavo più gossip, più vita privata, proprio quella che Mina ha sempre difeso mascherandosi e ammantandosi, ma nel libro non si parla né di amori né di pettegolezzi. L’autore, innamorato della cantante e della sua arte, ne ha rispettato la scelta di libertà e autonomia, scrivendo un libro asciutto, che ha quasi lo stile di una tesi di laurea, arricchito da preziose testimonianze d’epoca, tratte da giornali, riviste, saggi, biografie e interviste.
A livello personale ne ho tratto godimento rievocativo, come sempre con le opere di Dalla Vecchia, ma anche un quadro utile e puntuale della carriera di un’artista senz’altro fondamentale nel panorama canoro e culturale italiano.
Gordiano Lupi, "Sogni e altiforni"

Sogni e altiforni
Gordiano Lupi e Cristina de Vita
Acar Edizioni, 2018
pp 318
15,50
Sogni e altiforni, di Gordiano Lupi e Cristina de Vita, è il seguito a quattro mani di Calcio e Acciaio. È composto da due testi distinti, uno poetico e uno narrativo, visti rispettivamente dalla parte del protagonista maschile e da quella della protagonista femminile.
Ritroviamo Giovanni là dove lo avevamo lasciato alla fine del primo libro. Un ex calciatore famoso che, dopo aver abbandonato il mondo dorato del calcio importante, è tornato nella sua città, Piombino, e ricomincia a interessarsi di sport facendo il direttore tecnico per una piccola squadra di ragazzi del Venturina.
Giovanni è sempre più triste, più solo e più vecchio. Giovanni è preda di abitudini cui per pigrizia non riesce a rinunciare. Divorziato da tempo, vive con la madre e fa sesso senza amore con la badante di lei.
“E la mia vita, se provo a ricordare, è stata solo un tuffo nel non fatto, un’ipotesi infinita di non detto”. (Pag 96)
Torna spesso con la mente a un amore di gioventù, Debora, che non ha avuto il coraggio di concretizzare quando era il momento. Debora è l’amore romantico e perduto, quello che rimarrà meraviglioso proprio perché non lo si è vissuto, perché è finito prima ancora di cominciare. La realtà brutale non lo ha corrotto, non lo ha contaminato.
In tutta la lunga parte scritta da Gordiano Lupi ritroviamo il suo incedere lento e poetico, quell’ingolfarsi sempre sui medesimi ricordi, ripetuti come in un loop tristissimo e nostalgico. Sehnsucht, saudade, nostalgia canaglia, chiamatela come volete, è lo strazio di un passato che non ti fa progredire, ti lascia sempre nel medesimo punto, forse perché, alla fine, è lì che vuoi rimanere, con la tua abulia intrisa di comode memorie dolceamare.
Quello che per noi è un brutto presente sarà il ricordo magico di qualcun altro, ed è così anche per Giovanni. Percorrendo i paesaggi conosciuti, torna ossessivamente all’infanzia, rivede il padre, la madre, riascolta i racconti del nonno, risente l’odore della fuliggine dell’altoforno, rivede il falso tramonto rosso dell’acciaieria ormai spenta, triste relitto di archeologia industriale.
Piaceva tutto del passato, perché tutto è trasfigurato dal tempo, piaceva il puzzo dell’acciaieria, la povertà dignitosa, i campi incolti, i muri fatiscenti, l’odore di frittura, le seme e le noccioline del cinema di seconda visione.
Quando vivi da sempre nello stesso luogo, ogni pietra, ogni anfratto, ogni angolo è pervaso di ricordi. Per qualcuno la reminiscenza è dolce e allegra, per altri, come per Giovanni, è rimpianto struggente. Di che? Di tutto e di niente, di quel momento in cui ogni cosa era ancora possibile, di oggetti poveri e brutti che, attraverso le nebbie del tempo, ora sembrano belli. Rievocazioni di un mare ondoso e cangiante, di un cielo terso, di un campetto sterrato dove tirare calci a un pallone, sentori amari e ancora selvatici di provincia, di pitosforo e tamerici, di cipressi e salmastro.
La cifra stilistica di Lupi è la ripetizione, come una dolce e tristissima onda che rotola e poi torna indietro, si avviluppa su se stessa. Ripetizione di scorci, di paesaggi, d’immagini, di sentimenti perduti.
Dall’altra parte c’è il testo narrativo, la voce di Debora. Sappiamo dalle sue parole che cosa le è accaduto dopo che Giovanni l’ha abbandonata. La scrittura è più romanzesca e più femminile, meno poetica, meno ritmata e meno perfetta di quella di Lupi.
Giovanni e Debora s’incontrano un’ultima volta per caso ma non concretizzano il loro ritrovarsi. Sanno entrambi che il passato non può tornare, che, se accadesse, non darebbe le gioie immaginate, che il sogno deve rimanere sogno e il ricordo ricordo.
Un romanzo struggente fin dalla dedica, consapevole del tempo che passa, dell’avvicinarsi della fine. “Le cose da scrivere con urgenza sono sempre di meno”. Perché ormai si è all’impasse e si vive “di ricordi senza scorgere un brandello di futuro”.
Sotto la cenere
Ti ho lavato
dove tu lavavi me
ti ho lavato
dove ora io lavo i bambini
che non ti piacciono
che non capisci.
Ti ho imboccato
con la bava
e la lingua,
di traverso.
Farfugliare esasperato
Rabbioso
occhi come lampi d’impotenza
anche tu diventi figlia
anche tu ritorni figlia
il mio niente si fa paura
il primo fremito di un dolore ritrovato
che c’era
che c’è

/image%2F0394939%2F20190531%2Fob_6113d1_61425960-10216728261030327-19684367693.jpg)


/image%2F0394939%2F20200410%2Fob_f019a6_img-20200410-171246.jpg)
/image%2F0394939%2F20200410%2Fob_b98a12_img-20200410-171259.jpg)
