pietro pancamo
Poesie e altro ancora.

Poesie
Mi dico
Mi dico
all’indomani della notte:
«In fondo la vita
è un dolore come tanti».
***
Nel mio subconscio
Nel mio subconscio,
il mare non tocca
e domani, dunque,
è un’altra notte.
***
Speranza
La terra promessa,
l’unica,
è quella del sepolcro.
***
Io
I chi sono?
Un poeta qualunque:
diciamo, ecco,
un “vattelappesca”.
Un piccolo monologo
Dormendo senza posa nell’angolo degli incubi, mi trovo a coprire, qui in Valtellina, un tratto di vita dove ogni strato di terra è acqua fossile, brava davvero a intralciarmi il cammino con valve antiche, che atteggiandosi a pietre e rocce affioranti, mi rendono il passo anonimo e sommario, impreciso e imprecisato.
Aforismi
Spes ultima dea: ovvero la speranza è l’ultima speranza.
***
Per i delusi e i rassegnati non c’è mai serenità; al massimo un disprezzo signorile e distaccato.
***
L’ironia è la serenità degli infelici.
***
Dittico degli elettroni
1) La nascita è l’anodo, la morte il catodo. La corrente fra questi due poli è giusto chiamarla vita?
2) Senza il catodo, nessuna corrente. Dunque la morte è necessaria?
Il buon vecchio quesito

L’ironia è il coraggio della tua disperazione (ma anche, se vogliamo, di quella in genere) e ti dà forza necessaria a seguire i tuoi incubi (i tuoi incubi vari) fino al quesito (il buon vecchio quesito) che dice di notte: 《Per caso la morte è l’autoironia della vita?》.
Pietro Pancamo
(pietro.pancamo@alice.it)
Il regista dimenticato

Esitò, quando il meteo tacque. L’occasione era propizia – si rese conto, spegnendo la radio –, ma la forza per attuare il “piano” (peraltro già studiato e preparato da tempo) tardò a presentarsi, lì per lì. L’anima non s’atteggiava all’ardimento, per dirla col poeta. Oh nessun problema, ad ogni modo, perché eccolo il rimedio: scherzare fra di sé. «Lo schiocco secco del cuore che si spezza è proprio come quello di un ciac in campo», pensò, allora. E all’improvviso trovò il coraggio: un coraggio amaro, che l’accompagnò per mano alla rada solitaria.
Così adesso, in quell’esterno notte che si era scelto, il regista dimenticato non voleva tornare più alla vita che lo aveva diseredato, né gli riusciva di capire se a gonfiare il genoa e spingere il piccolo cutter malandato fossero le frequenti scosse d’aria o le immagini “ondose” che il vecchio proiettore a bobine – dall’alto del suo treppiede, assicurato con gomene e cime a proravia – drappeggiava sul bianco agitato della vela. Guardandola, continuava a ripetersi: «Senza il minimo dubbio, “Marosi alla deriva” è stato il mio film migliore!». E mentre una stilla di sorriso iniziava a formarsi sulle sue labbra, gli sembrò di scorgere i flash dei fotografi.
Ah, no… erano i lampi. Quelli, per ora lontani, della tempesta in arrivo. Il bollettino dei naviganti, beh non si sbagliava.
Vigilia di Natale

Oggi, ad esempio, consegni le pizze, triste fattorino, in questa sera ascensionale ch’esala, nella neve, dall’asfalto al cielo. Vorresti fare il traduttore, cambiar lingua alle parole, ma ti obbliga a tutt’altro la realtà. «Pazienza, mi rassegno», hai deciso già da anni. E mentre i due lampioni chini sulla via, cioè il vicolo piccino che attraversi proprio ora, ti ricordano l’infanzia, rifletti un poco più sereno sulla cupa delusione esistenziale che t’infesta sia la vita che le tante sfacchinate, vagabonde e assai randagie, d’ogni giorno; e concludi i tuoi pensieri rivolgendo una preghiera all’amico preferito, il tuo... Babbin Gesù: «Fa’ che il lavoro mi nobiliti la rabbia...».
TV

I
Gli occhi
come i piatti di una bilancia
che ha per sostegno
un sentimento a ritroso:
mezzo chilo d’amore
e mezzo chilo d’odio
tengono i piatti in equilibrio.
Risultato?
Uomo da niente,
uomo di niente.
II
Sentimenti di Natale
rabboniscono il televisore.
E adesso
il tuo cuore
è un ornamento
che sai appendere
al rametto stilizzato
di un sogno narcotico,
di un sorriso plagiato.
Terzo comandamento: ricordati
di santificare il televisore.
Serafino preposto al coraggio

Gli angeli si diplomano al Conservatorio Astronomico perché studiano la musica che le sfere celesti producono ruotando. Fanno l’analisi armonica degli accordi supremi che, una volta, anche gli uomini eletti (Pitagora, ad esempio) avevano la forza e il diritto di ascoltare.
Gli esami sono molti, però che gran soddisfazione ultimare i corsi e ottenere infine (lode al Signore!) il permesso d’insegnare.
I miei studi sono a buon punto e fra poco l’esame conclusivo mi darà il titolo che sogno tanto: quello di Maestro!
Nel frattempo, grazie alle mie doti vocali, già occupo la carica di tenore-capo nella gerarchia lirica del Conservatorio: sono forse il più bravo, tra gli allievi di “Esercitazione corale”. E poi, dirlo mi riempie di gioia, lavoro come assistente di un angelo cherubino che scende ogni giorno in Terra, posandosi delicato sulla quercia di un bosco dolce e campagnolo, per educare gli uccellini al canto. Li abitua a portare il cinguettio in maschera e a sorreggerlo con il diaframma; non tutti riescono subito, anzi nessuno: perciò hanno bisogno di me, “serafino preposto al coraggio” che deve esortarli a ignorare la delusione.
Mi capita, spesso, di calmare i picchi, tanto irascibili da abbandonarsi a voli isterici e rabbiosi, dopo un acuto sbagliato. Per sfogare il rammarico dell’errore, percuotono il becco addosso agli alberi, facendosi (io credo) un male diavolo!
Allora intervengo: abbraccio con la mano grande il loro corpicino scosso dai nervi, accarezzo piano la testolina invasata di furore e fischietto per loro qualche melodia celeste; così, lentamente, l’ira si placa. L’agitazione, tachicardia dei nervi, torna ad essere tranquillità.
Una lezione dura da mattina a sera e in fondo non è pesante: diverse pause concedono sollievo alla stanchezza. Io mi apparto, negli intervalli, su di un ramo nascosto e mi svago a pensare. Se un’aria d’opera comincia a formarsi nella mia immaginazione, la scrivo per appunti sulle foglie pentagrammate che gli uccelli usano a mo’ di spartito e, magari, cerco di farla somigliare a quelle dei compositori più illustri. No, non Rossini o Mozart, come ritengono gli uomini, bensì Giove, Saturno e Urano, come noi angeli sappiamo benissimo!
Quando mi annoio, tento un’occhiata verso l’orizzonte e sempre vedo qualcosa d’interessante che mi convince a osservare il paesaggio. Ho una vista incantevole dagli occhi panoramici che possiedo in volto: gli avvenimenti fanno tappa nel mio sguardo, e nulla viene considerato con poca attenzione.
D’altronde come può sfuggirmi una persona bizzarra simile a quel prete in tonaca di gala, che si avvicina lungo il sentiero mostrando, allegro, un giglio all’occhiello. Ah no! Si tratta di un monaco elegante, che sfoggia un saio a coda di rondine… Macché! Ora lo scorgo chiaramente: è di sicuro un Beato, assorto nel compito di farsi propaganda (distribuisce infatti santini da visita a cacciatori e spaccalegna: “Casomai vi servisse una grazia…”).
Anche Satana gradisce, talvolta, un giro nei boschi: sale dall’Inferno e va a rintanarsi nel buio intricato delle macchie più fitte. Nella tenebra contorta dei rami bassi, in quella notte artificiale, trova l’ispirazione per musiche blasfeme: con spirito malvagio architetta note sacrileghe, bestemmie sinfoniche, allucinazioni sonore da far eseguire alla sua orchestra d’orchi.
Però i concerti non sono mai un granché ed anzi, in Paradiso, gli angeli ironizzano inventando dialoghetti briosi. È facile sentirli scherzare: “Ho fatto una volata all’Inferno per assistere a un’esibizione dell’orchestra d’orchi.”, “Ah sì? E chi suonava? Il primo violino?”, “No, il primo venuto: sai, era una cosa improvvisata…”.
Sorrido fra me per le battute ingenue dei colleghi alati, mentre la mia curiosità continua a sorvegliare la vita intorno. E mi accorgo di un simpatico ragazzo, seduto ai piedi d’una betulla, intento a deliziarsi del tepore e della luce. Sembra davvero uno scrittore, forse perché si è poggiato accanto uno strato di fogli che non smette di compilare, mano mano, a penna.
Affido agli occhi uno sguardo più pronto, per leggere le parole di quel ragazzo… ecco, finalmente capisco: è impegnato a buttar giù la recensione di un libro, che s’intitola Il Silenzio Stonato. Ha scelto la natura come ufficio di lavoro, quel ragazzo, e il suo inchiostro afferma, tutto disinvolto: “Rob Demàtt introduce la fantasia dei lettori all’uso narrativo dei ricordi, costruendo uno sfogo romanzato (dal linguaggio brillante e volitivo) che ha per contenuto un messaggio autobiografico: il sesto senso è quello di colpa. È il rimorso d’aver sprecato gli anni e la vita per dedicarci a illusioni che prima incantavano e che, adesso, ci deridono. Allora un’esclamazione prende in noi a gridare: “Temo il cielo e la terra; il tempo mi sta lasciando solo: entra nelle ossa la paura, il respiro non ha più forza nei polmoni e tutto mi incita alla morte!”.
Ma quando i cicli d’angoscia termineranno e la sofferenza non sarà che uno stimolo di guarigione, scopriremo sollievo anche nel dolore e, nel sollievo, amore”.
“Realizzerai i miei desideri?”, domanda l’uomo.
“Aspetta e spira…”, ribatte il destino.
Chissà per quale motivo, la recensione mi ha suscitato in mente questo lugubre giochetto di parole… Certo dev’essere triste per gli uomini ritrovarsi in mezzo alle ore, sempre minacciati da pene e afflizioni. Un giorno, però, avranno soltanto gioia e serenità, perché noi angeli provvederemo a convertire il destino!
Per il momento, io e il Maestro cherubino salutiamo gli uccelli agitando le ali (è sera, la lezione è finita) e torniamo lassù, nel Conservatorio Astronomico, a riascoltar le stelle.
Verande d'azzurro

Un laghetto di fumo nel cuore… Processioni di frasi lasciano calzature d’intelligenza
prima di entrare nella moschea delle bocche.
II
I profumi sorridono tra le maschere di foglie. E lettere serpentine
indossano pastrani di luce.
III
Un gregge di bagliori
alle pendici dei versi
nasconde l’Ulisse della mia ispirazione…
Canicola di gioia, tanfo d’allegria
negli sguardi ciclopici del solo occhio giornaliero. Spranghe di felicità
negli acuti del sole
e, fra verande d’azzurro, spaventapasseri di poesia…
IV
Tachicardia di vento nei vestiti: il vento, cuore del cielo…
Le nuvole sembrano covoni di luce, capanne di fieno
intorno al pagliaio del sole. Nel raspo degli alberi
festoni d’aria, e gli occhi sono brandelli di nostalgia tra festuche di tempo allegro.
Stelle filanti d’erba, pendii agitati fra la bonaccia della pianura…
V
Terra diroccata e baracche di collina. Villaggi di sole.
Dal lievito nullo di rocce azzime,
paesini salgono
pioli di luce.
Poeti
Noi che visitiamo carmi di sole
brindiamo con versi e parole.
Scriviamo sorrisi
e sentimenti in codice;
insonni di vita
andiamo sposi
ai nostri occhi.
Se la tua voce desidera cullarsi
nel mio cuore,
troverò i sorrisi
con la mano di un giocoliere
e i miei minuti saranno il volto di acrobazie
che, da una mano all’altra,
volano fra una mano e l’altra.
Decomposizione psichica

Il destinorizzonte
Stracci di sonno coprono,
masticano il corpo della notte
diafano di tenerezza;
lo avvinghiano
sinuoso di buio
– flessuoso di membra stellate –
e lo attraversano d’amore.
Poi, fosforescente,
lo sguardo della nebbia,
scosso di stanchezza,
si espande lento nel cuore
come un gas di desideri
volatilizzati.
Mentre il mio destino,
guantato dalla notte,
scende nei sobborghi dell’anima:
strade oscure di pensiero
e siepi d’amore
s’intersecano nel mio nome.
Il destinorizzonte
s’attorciglia
a questa landa di tempo.
«Chi» – si domanda –
«striscerà nella roccia del canto
la gioia, turgida
come i seni di un fiore incantato?».
Danzai nelle viscere di un sentimento
all’ombra de’ tuoi occhi.
Poi l’amore s’irradiò in rivoli di tempo.
«Che sia la vita!», urlava il nostro dio
(o soltanto noi).
Ma si sbagliò (o soltanto noi sbagliammo
perché non c’era
null’altro da fare) e
fu il tempo
(o continuò… )
Parole dal silenzio
Ricorda il mistero
che fioriva in un sospiro,
dove la morte ha tessuto il nido
come una spiaggia
di parole taciute;
come un barbaglio di sogni trasparenti,
orchestra di anime perdute.
Desideri esplosi nel cielo
mimano le stelle.
Regni abissali di morte,
fiorita nel respiro di Dio.
Leggende di anime affogate nel buio
sotto la volta di sentimenti castrati.
Malinconia: il pensiero animato di sole
rattrappito
nel sonno di una dolce tristezza.
E la morte vive all’inchinarsi del tempo
all’imbrunire della voce
in questa via del pensiero
ghiaiosa d’amore.
E gli uomini
(sogno di Dio, ossessione della morte)
spengono una scintilla
umida di storia;
ascoltano un nome
raggiato di follia.
In incognito
Dormo in incognito
per non farmi riconoscere dagli incubi.
Scavano per l’aria come talpe;
hanno un paio d’occhi
larghi e fotofobici.
Sul comodino
il lume acceso mi nasconde.
Decomposizione psichica
Musica come bava alla bocca:
e il cielo si gonfia tra le urla dei pazzi,
il loro sguardo è vento
che si perde nel labirinto di stelle.
Ogni parola è una stella
che splende di saliva: e cieli agitati
innevati di stupore
tramontano lontani,
evocati dalla morte.
Il mio cielo
è questo mio cervello
pieno di tralicci spezzati
e di barriere sventrate
e d’acque ferite
e di binari sradicati
che si mordono col ferro.
Dentro le vene,
aggrovigliate come un gomitolo
di dolore,
il sangue è un fiume abbandonato
terso di rumori prosciugati.
La morte è silenzio
stonato.
La voce trasuda parole d’accento piagato
ma è tiepido il grido del tuo respiro,
le piaghe troppo soffocanti
perché tu abbia il fiato d’urlare.
Morire da te
è una fuga troppo leggera
per avere il sollievo.
Così
un pantano di figure
nel cuore
e il giorno s’increspa
a raccogliere il tuo soffio.
Morbido silenzio, soffice
come una preghiera del sonno.
Il buio che adora fruscii e parole:
il buio, affannato dal mio respiro,
può solo accarezzare la
nausea di questa vita.
Nel giorno,
sputo della notte,
fiori freddi
come steli di pioggia.
Un’orma di luce
imbavaglia lo spazio.
Morte antologica permanente

PREFAZIONE:
le parole seguenti
sono un fango di cellule nervose,
tenute insieme dal silenzio.
Il silenzio è un’isteria di solitudine
che genera e accumula:
prodotti temporali,
energie cinetiche,
reazioni di gesti a catena.
I sogni, inseriti nella rassegnazione
come in un programma di noia pianificata,
sono gli arti di questo silenzio;
o, se preferiamo,
gli organuli ciechi del silenzio
che lavorano a tastoni
dentro il suo liquido citoplasmico.
Il silenzio può anche essere
la cellula monocorde
di un sentimento spaventato,
di un amore rappreso,
di un guanto scucito:
in tal caso
trasforma la solitudine
nella raggiera cerimoniosa
d’una nausea che procede,
maestosa,
con moto uniformemente accelerato.
(Si registra un’accelerazione a sbalzi
solo quando
un’effervescente disperazione
s’intromette con scatti sismici
a deviare il corso
dell’accelerazione stessa).
Per concludere,
l’evoluzione della nausea
può secernere un vuoto,
avente più o meno
le caratteristiche della morte;
o germogliare per gemmazione
quella strana forma di vita
identificata col nome di indifferenza,
la quale risulta essere (da approfondite supposizioni)
il chiasmo di paura e odio.
POSTFAZIONE:
le parole precedenti
sono un fango di cellule nervose,
tenute insieme dal silenzio.
Ogni allusione
a sentimenti e/o fatti reali
è voluta
silenziosamente.
prima di far cena,
mangiando fette di pandoro.
Che pensieri terra terra
vengono in mente
mandando giù bocconi
pastosi di burro:
pensieri... stomaco stomaco.
Tipo: «Sono stracco di vivere
a mia rovina;
sono stracco di vivere
alle mie spalle».
Insomma è un malessere transitorio che bisogna pur soffrire passando, tutto d’improvviso, dalla gioia al dolore. È un po’ come il malore successo a quelli che han volato da un fuso orario all’altro. Poi, quando la rabbia finisce, il mio pessimismo è solo rassegnazione.
Se vedo, però, intorno a me
sorrisi di compassione
per l’enorme sfiducia
che mi affligge il cuore,
mi rincacchio con passione
e, senza nemmen finire
di rovinarmi l’appetito,
corro a letto immusonito
saltando l’antipasto
(e figurati la cena!).
«Ah, sono stracco di vivere
a mia rovina;
sono stracco di vivere
alle mie spalle».
Pomeriggio sfaticato
A casa,
nel disordine alchimistico
delle ore scapestrate,
sfoglio un libro
foruncoloso di parole.
Allora esco
e vado a guardare i miei passi
che vorrebbero tanto
(come mille moschettieri)
essere uno
per ogni raggio di sole.
«Miao», fa il micio.
«Vruum», risponde l’automobile.
«Boh!», commento io. E torno a casa
galleggiando su questi passi
che ormai hanno capito
di essere ben pochi:
«Vorremmo tanto» – pensano –
«che i raggi di sole
(come tre moschettieri)
fossero uno
per ognuno di noi».
A casa,
nel disordine alchimistico
delle ore scapestrate,
mi ritrovo a fare
la critica letteraria
di uno starnuto
o della mia
scarpa sinistra.
Il traviato
Nel vero senso del cimitero
e di un riposo ossessivo
non sa più divincolarsi
dalle materie (o macerie) di studio
che pian piano disimpara con pigrizia
nella vecchi’aia del suo podere.
Traviato da un senso malinteso d’allattamento,
al contrario dei fratelli
partiti allo sbaraglio
(coraggiosi inermi in armi),
lui cerca rifugio
nella casa di famiglia:
la masseria
prensile e sterrata.
Morte antologica permanente
Siccome la vita
ci rovina la vita
(sempre!),
a giugno ho visitato
(un po’ turista, un po’ becchino
e un po’ parente sconsolato)
l’interessante morte
antologica permanente
delle mie speranze
migliori:
quanti sogni falliti
imbalsamati in bella mostra!
Li guardavo e piangevo
desolato nero,
dannandomi frenetico
la salute.
E adesso è soltanto
stanchezza rabbiosa
resistere ogni giorno
al ripetersi ingombrante del respiro
e della luce.
Delusione
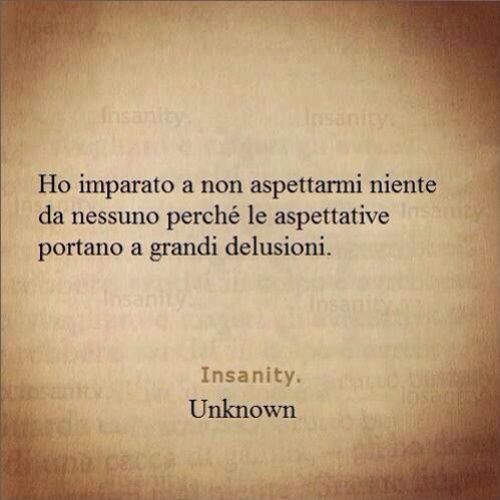
DELUSIONE
La bravura simbiotica delle rime a incastro.
Il sogno è un conservante,
l’additivo artistico
per rimodernare
ambizioni letterarie,
o speranze, sopite ad honorem.
Comunque il sole
non è bello come prima.
Adesso mi pare una vecchia fotografia.
Il particolare, anzi,
di una vecchia fotografia
... ritagliato via
dall’alone di un sorriso.
Vecchio! La vita?
Ti piaceva…
«Sissì… Beh
in fondo vivevo
solo per ricordare me stesso:
per non avere rimpianti
o rimorsi».
E la seguivi, allora.
La seguivi!
«Sissì…
Magari non per nobiltà
o entusiasmo
o speranza. Nonnò…
Per una ragione, invece,
molto più romantica:
perché non mi scacciava…
Ma sì! Poi l’eco di uno sguardo,
l’eco di uno sguardo
s’infrange nel cuore:
e tutto quello che resta da vedere
è il desiderio di guardare».
Il nulla
I miei sogni leggeri, scanalati
fra ombre creole di tenera luce
e foglie di facciata
(ovvero blande
come ballerine
morse dal vento).
E quando l’incubo arriva
il nulla esce dal suo fuori
per annuire agli occhi del presente;
«io sono» – dice –
«un barbaglio di notti camuse
e la pioggia di quel che verrà:
del futuro mi rivelo
l’unica, insomma,
l(’)abile traccia!».

/image%2F0394939%2F20190531%2Fob_6113d1_61425960-10216728261030327-19684367693.jpg)


